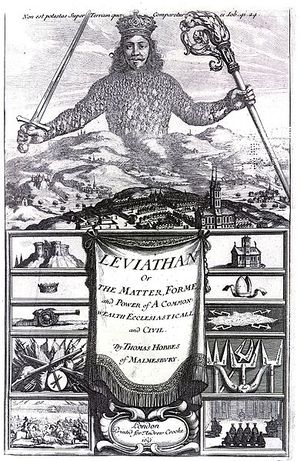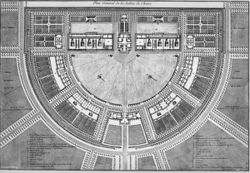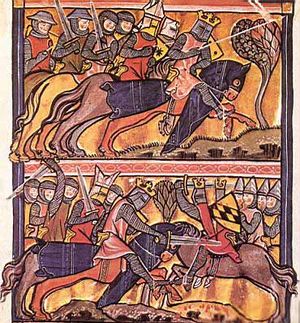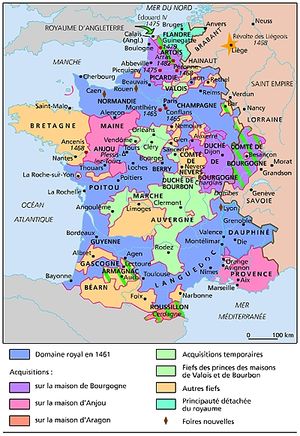« Guerra: concezioni e sviluppi » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{hidden | {{hidden | ||
|[[ | |[[Introduzione alle scienze politiche]] | ||
|[[ | |[[Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu]] ● [[Le origini della caduta della Repubblica di Weimar]] ● [[Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto]] ● [[La nozione di "concetto" nelle scienze sociali]] ● [[Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni]] ● [[Marxismo e strutturalismo]] ● [[Funzionalismo e Sistemismo]] ● [[Interazionismo e Costruttivismo]] ● [[Teorie dell'antropologia politica]] ● [[Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee]] ● [[Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica]] ● [[Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica]] ● [[Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica]] ● [[Teorie della guerra nella scienza politica]] ● [[Guerra: concezioni e sviluppi]] ● [[Ragion di Stato]] ● [[Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello]] ● [[Teorie della violenza nella scienza politica]] ● [[Welfare state e biopotere]] ● [[Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione]] ● [[Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze]] ● [[Il sistema di governo delle democrazie]] ● [[Morfologia delle contestazioni]] ● [[L'azione nella teoria politica]] ● [[Introduzione alla politica svizzera]] ● [[Introduzione al comportamento politico]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione]] ● [[Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali]] ● [[Introduzione alla teoria politica]] | ||
|headerstyle=background:#ffffff | |headerstyle=background:#ffffff | ||
|style=text-align:center; | |style=text-align:center; | ||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
= L'evoluzione della guerra nella storia = | = L'evoluzione della guerra nella storia = | ||
== La guerra come costruttore dello Stato moderno == | == La guerra come costruttore dello Stato moderno == | ||
[[Fichier:Passage de la Seine par armee anglaise et pillage Vitry XIVe siecle.jpg|vignette|droite]] | [[Fichier:Passage de la Seine par armee anglaise et pillage Vitry XIVe siecle.jpg|vignette|droite|L'attraversamento della Senna e il saccheggio di Whittier da parte delle truppe inglesi nel XIV secolo.]] | ||
Per studiare la guerra, dobbiamo innanzitutto concentrarci sui suoi legami con lo Stato moderno come organizzazione politica. Vedremo come la guerra di oggi sia plasmata da e attraverso l'emergere dello Stato moderno. Inizieremo con il constatare che la guerra è una questione di Stato. Per introdurre l'idea che la guerra è legata alla costruzione stessa dello Stato e all'emergere dello Stato come forma di organizzazione politica in Europa a partire dalla fine del Medioevo, il modo migliore per farlo è quello indicato dal socio-storico Charles Tilly nel suo articolo War Making and State Making as Organised Crime, che sviluppa l'idea di war making/state making: è facendo la guerra che si è creato lo Stato, e viceversa. | |||
In "War Making and State Making as Organized Crime", Charles Tilly offre una provocatoria analisi storico-sociale della costruzione dello Stato moderno in Europa occidentale. Sostiene che i processi di costruzione dello Stato e di guerra sono intrinsecamente legati e paragona gli Stati a organizzazioni criminali per evidenziare gli aspetti coercitivi e di sfruttamento della loro formazione. Secondo Tilly, la formazione degli Stati moderni è in gran parte guidata dagli sforzi delle élite al potere per mobilitare le risorse necessarie alla guerra. A tal fine, queste élite ricorrono a mezzi come la tassazione, la coscrizione e l'espropriazione, che possono essere paragonati a forme di racket ed estorsione. Inoltre, Tilly sostiene che la costruzione dello Stato è stata facilitata anche dalla monopolizzazione dell'uso della forza legittima. In altre parole, i governanti cercavano di eliminare o subordinare tutte le altre fonti di potere e autorità nel loro territorio, compresi i signori feudali, le corporazioni, le corporazioni e le bande armate. Questo processo ha spesso comportato l'uso della violenza, della coercizione e della manipolazione politica. Infine, Tilly sottolinea che la costruzione dello Stato richiedeva anche la costruzione di un consenso sociale, o almeno l'acquiescenza delle popolazioni, attraverso lo sviluppo di un'identità nazionale, la creazione di istituzioni sociali e politiche e la fornitura di servizi e protezioni. Questa analisi offre una prospettiva critica e critica sulla costruzione degli Stati moderni, evidenziando le loro radici violente e coercitive e sottolineando il loro ruolo chiave nella strutturazione delle nostre società contemporanee. | |||
La | La concezione dello Stato moderno, così come lo conosciamo oggi, si basa principalmente sul modello europeo, emerso durante il periodo rinascimentale e moderno, tra il XIV e il XVII secolo. Questa evoluzione è stata caratterizzata dalla centralizzazione del potere politico, dalla formazione di confini nazionali definiti, dallo sviluppo di una burocrazia amministrativa e dalla monopolizzazione dell'uso della forza legittima da parte dello Stato. Tuttavia, è importante notare che in altre parti del mondo esistono altri modelli politici, basati su traiettorie storiche, culturali, sociali ed economiche diverse. Ad esempio, in alcune società la struttura politica può essere più decentralizzata o basata su principi diversi, come la reciprocità, la gerarchia o l'uguaglianza. Inoltre, il processo di esportazione del modello statale europeo, in particolare attraverso la colonizzazione e, più recentemente, la costruzione dello Stato o della nazione, ha spesso incontrato resistenza e può aver portato a conflitti e tensioni. Ciò è spesso dovuto al fatto che questi processi possono non tenere conto delle realtà locali e possono talvolta essere percepiti come forme di imposizione culturale o politica. | ||
Nel suo articolo "War Making and State Making as Organized Crime", Charles Tilly propone un quadro di riferimento per comprendere il processo di formazione degli Stati, concentrandosi in particolare sull'Europa tra il XV e il XIX secolo. Tilly vede l'emergere dello Stato come il prodotto di due dinamiche interconnesse: il war making e lo state making. | |||
* | * Fare la guerra: Tilly ipotizza che gli Stati siano stati plasmati dalla costante necessità di preparare, condurre e finanziare la guerra. Le guerre, in particolare nel contesto europeo, sono state fattori chiave nello sviluppo delle strutture statali, non da ultimo a causa delle risorse necessarie per combatterle. | ||
* | * Creazione dello Stato: è il processo attraverso il quale si consolida il potere centrale di uno Stato. Per Tilly, si tratta di controllare e neutralizzare i rivali interni (in particolare i signori feudali) e di imporre la propria autorità sull'intero territorio sotto il suo controllo. | ||
Questi due processi sono strettamente collegati, in quanto le guerre forniscono l'impulso per il consolidamento dello Stato e sono esse stesse rese possibili da questo consolidamento. Per esempio, per finanziare le guerre, gli Stati hanno dovuto creare sistemi fiscali e amministrativi più efficienti, che hanno rafforzato la loro autorità. | |||
=== La | === La guerra e lo Stato moderno === | ||
[[Fichier:Einhard vita-karoli 13th-cent.jpg|vignette|right]] | [[Fichier:Einhard vita-karoli 13th-cent.jpg|vignette|right|Illustrazione manoscritta del XIII secolo della Vita Karoli Magni.]] | ||
Il sistema feudale era una complessa struttura di relazioni tra i signori e il re, basata sulla proprietà della terra (o "feudi") e sulla fedeltà. I signori avevano una grande autonomia sulle loro terre ed erano generalmente responsabili della sicurezza e della giustizia nelle loro terre. In cambio del loro feudo, dovevano giurare fedeltà al re e fornirgli supporto militare quando ne aveva bisogno. Questo sistema di vassallaggio costituiva la base del potere durante il Medioevo. Tuttavia, con l'avvento dello Stato moderno, questo sistema fu gradualmente sostituito. Il consolidamento dello Stato è stato accompagnato da uno sforzo di centralizzazione del potere, che spesso ha comportato l'abolizione o la riduzione del potere dei signori feudali. Un elemento chiave di questo processo fu la necessità di finanziare e sostenere le guerre. I re iniziarono a sviluppare strutture amministrative e fiscali per raccogliere fondi e reclutare direttamente gli eserciti, anziché affidarsi ai signori feudali. Questo rafforzò la loro autorità e permise la formazione di Stati più centralizzati e burocratici. | |||
Secondo Charles Tilly, la guerra è stata una potente forza trainante per la formazione dello Stato moderno. Nel Medioevo, la competizione tra i signori per espandere il proprio territorio e accrescere il proprio potere portava spesso al conflitto. I signori erano costantemente in guerra tra loro, cercando di ottenere il controllo delle rispettive terre e risorse. Inoltre, questi conflitti locali erano spesso collegati a conflitti più ampi tra regni. I re avevano bisogno di una solida base di potere per sostenere i loro sforzi bellici, il che li portava a cercare di rafforzare il controllo sui loro signori. Queste dinamiche crearono una pressione costante per una maggiore centralizzazione e un'organizzazione più efficiente. I re svilupparono amministrazioni più sofisticate e sistemi fiscali più efficienti per sostenere i loro sforzi bellici. Allo stesso tempo, cercarono di limitare il potere dei feudatari e di affermare la propria autorità. Questi processi gettarono le basi dello Stato moderno.[[Fichier:France sous Louis XI.jpg|300px|vignette|right]] | |||
Norbert Elias, | Norbert Elias, sociologo tedesco, ha sviluppato il concetto di "lotta eliminatoria" nella sua opera "Il processo di civilizzazione". In questo contesto, si riferisce a una competizione in cui i giocatori si eliminano l'un l'altro finché non ne rimangono solo pochi, o addirittura uno. Nel contesto della formazione degli Stati, questa può essere vista come una metafora del modo in cui i signori feudali combattevano per il potere e il territorio durante il Medioevo. Nel corso del tempo, alcuni signori sono stati eliminati, sia per sconfitta militare sia per assimilazione a entità più grandi. Questo processo di eliminazione contribuì alla centralizzazione del potere e alla formazione dello Stato moderno. | ||
Nel corso dei secoli, molti re francesi rafforzarono gradualmente il loro potere, sottraendo territori alla nobiltà feudale e consolidando l'autorità centrale. Questi sforzi furono spesso sostenuti da alleanze matrimoniali strategiche, conquiste militari, accordi politici e, in alcuni casi, dall'estinzione naturale o forzata di alcune linee nobiliari. Luigi XI, in particolare, svolse un ruolo cruciale in questo processo. Re dal 1461 al 1483, fu soprannominato "l'Universelle Aragne" o "il Ragno Universale" per la sua politica astuta e manipolatrice. Luigi XI si impegnò a fondo per centralizzare il potere reale, riducendo l'influenza dei grandi feudatari e istituendo un'amministrazione più efficiente e diretta in tutto il regno. Ciò contribuì alla formazione dello Stato moderno, con un potere centralizzato e un'amministrazione organizzata, che si sarebbe rafforzato nel corso dei secoli, in particolare con Francesco I e Luigi XIV, il "Re Sole". | |||
La | La Francia e la Gran Bretagna sono spesso citate come esempi tipici della nascita dello Stato moderno. In Francia, i re hanno gradualmente accentrato il potere, creando un'amministrazione più diretta ed efficiente. L'apogeo di questa centralizzazione fu probabilmente raggiunto durante il regno di Luigi XIV, che dichiarò "Io sono lo Stato" e governò direttamente dal suo palazzo di Versailles. Tuttavia, questo processo fu intervallato da periodi di conflitto e di rivolta, come la Fronde e, successivamente, la Rivoluzione francese. La Gran Bretagna, invece, ha seguito un percorso leggermente diverso verso la formazione dello Stato moderno. Il re Enrico VIII consolidò il potere reale istituendo la Chiesa d'Inghilterra e abolendo i monasteri, ma la Gran Bretagna vide anche un forte movimento per limitare il potere reale. Questo culminò nella Gloriosa Rivoluzione del 1688 e nell'istituzione di un sistema costituzionale in cui il potere era condiviso tra il Re e il Parlamento. In entrambi i casi, la guerra ha giocato un ruolo importante nella formazione dello Stato. La necessità di radunare eserciti, di imporre tasse per finanziare le guerre e di mantenere l'ordine interno contribuì notevolmente alla centralizzazione del potere e alla creazione di strutture amministrative efficienti. | ||
La | La concorrenza esterna, soprattutto a partire dal Rinascimento e durante l'età moderna, è stata una forza motrice importante nella formazione degli Stati e nella strutturazione del sistema internazionale come lo conosciamo oggi. Ciò si può notare nello sviluppo della diplomazia, delle alleanze e dei trattati, delle guerre per la conquista e il controllo dei territori e persino dell'espansione coloniale. Inoltre, ha portato a una più chiara definizione dei confini nazionali e al riconoscimento della sovranità degli Stati. In particolare, il coinvolgimento di Luigi XI e dei suoi successori nelle guerre in Italia e contro l'Inghilterra ebbe un ruolo importante nel consolidamento della Francia come Stato e nella definizione dei suoi confini e interessi nazionali. Allo stesso modo, anche la competizione tra le potenze europee per i territori all'estero durante l'epoca della colonizzazione ha contribuito a plasmare il sistema internazionale. | ||
Le ambizioni imperiali di governanti come Luigi XI erano in parte motivate dal desiderio di consolidare il proprio potere e la propria autorità, sia all'interno che all'esterno. Avevano bisogno di risorse per condurre guerre, il che significava spesso esigere tasse più alte dai loro sudditi. Queste guerre avevano spesso anche una dimensione religiosa, con l'idea di riunificare il mondo cristiano. Man mano che questi regni si sviluppavano e iniziavano a scontrarsi tra loro, iniziava a prendere forma un sistema internazionale. Fu un processo lento e spesso conflittuale, con molte guerre e conflitti politici. Col tempo, però, questi Stati hanno iniziato a riconoscere la sovranità reciproca, a stabilire regole per le interazioni internazionali e a sviluppare istituzioni per facilitare queste interazioni. | |||
Tutto ciò ha portato alla formazione di un sistema di Stati nazionali interconnessi, in cui ogni Stato ha i propri interessi e obiettivi, ma anche un certo obbligo di rispettare la sovranità degli altri Stati. Questo è il fondamento del sistema internazionale che abbiamo oggi, anche se le sue specificità si sono evolute nel tempo. | |||
=== | === Il ruolo della guerra nel sistema interstatale === | ||
Per fare la guerra (war-making), uno Stato deve mobilitare risorse significative. Queste includono risorse materiali, come il denaro per finanziare l'esercito e comprare le armi, il cibo per nutrire l'esercito e i materiali per costruire fortificazioni e altre infrastrutture militari. Servono anche risorse umane, come i soldati per combattere e i lavoratori per produrre i beni necessari. Per ottenere queste risorse, lo Stato deve essere in grado di esercitare un controllo effettivo sul suo territorio e sui suoi abitanti. È qui che entra in gioco la creazione dello Stato. Lo Stato deve istituire sistemi di tassazione efficaci per raccogliere il denaro necessario a finanziare la guerra. Deve anche essere in grado di reclutare o arruolare soldati, il che può richiedere sforzi per instillare un senso di lealtà o di dovere verso lo Stato. Inoltre, deve essere in grado di mantenere l'ordine e risolvere i conflitti all'interno dei propri confini, in modo da potersi concentrare sulla guerra all'esterno. La guerra e la costruzione dello Stato sono quindi intimamente legate. L'una richiede l'altra e le due cose si rafforzano a vicenda. Come ha scritto Charles Tilly, "gli Stati fanno le guerre e le guerre fanno gli Stati". | |||
La | La necessità di fare la guerra ha portato gli Stati a sviluppare una burocrazia efficiente in grado di raccogliere risorse e organizzare un esercito. Questo processo ha rafforzato la capacità dello Stato di governare il suo territorio e i suoi abitanti, in altre parole la sua sovranità. Per registrare la popolazione, riscuotere le tasse e reclutare i soldati, lo Stato doveva creare un'amministrazione in grado di gestire questi compiti. Ciò comportava lo sviluppo di sistemi di registrazione delle informazioni sugli abitanti, la definizione di leggi sulle tasse e sulla coscrizione e la creazione di organismi per l'applicazione di tali leggi. Con il tempo, questi sistemi burocratici si sono evoluti diventando sempre più efficienti e sofisticati. Inoltre, contribuirono a rafforzare l'autorità dello Stato, garantendo che la sua legittimità fosse accettata dal popolo. Le persone erano più inclini a pagare le tasse e a servire nell'esercito se credevano che lo Stato avesse il diritto di chiedere loro di farlo. La guerra ha svolto un ruolo centrale nel processo di costruzione dello Stato, non solo incoraggiando lo sviluppo di una burocrazia efficiente, ma anche rafforzando l'autorità e la legittimità dello Stato. | ||
Secondo Charles Tilly, lo Stato moderno si è sviluppato attraverso un processo di lungo periodo noto come "war making" e "state making". Questa teoria sostiene che le guerre sono state la principale forza motrice della crescita del potere e dell'autorità dello Stato nella società. La teoria di Tilly suggerisce che lo Stato moderno si è formato in un contesto di conflitto e violenza, dove la capacità di fare la guerra e di controllare efficacemente il territorio erano fattori chiave per la sopravvivenza e il successo dello Stato. | |||
Dopo la fine del Medioevo, l'Europa entrò in un periodo di intensa competizione tra gli Stati nazionali emergenti. Questi Stati cercavano di estendere la loro influenza e di affermare il loro dominio sugli altri, il che spesso portava a guerre. Uno degli esempi più emblematici di quest'epoca è Napoleone Bonaparte. Come imperatore di Francia, Napoleone cercò di stabilire il dominio francese sul continente europeo, creando un impero che si estendeva dalla Spagna alla Russia. Il suo tentativo di creare un impero senza confini e inclusivo era in realtà un tentativo di sottomettere le altre nazioni alla volontà della Francia. Tuttavia, questo periodo di rivalità e guerra vide anche il consolidamento dello Stato nazionale come principale forma di organizzazione politica. Gli Stati rafforzarono il loro controllo sul territorio, centralizzarono la loro autorità e svilupparono istituzioni burocratiche per amministrare i loro affari. L'emergere dello Stato nazionale moderno nel periodo post-medievale è stato in gran parte il prodotto delle ambizioni imperiali e delle rivalità interstatali. Questi fattori hanno portato alla creazione di un sistema interstatale basato sulla sovranità e sulla guerra come mezzo per risolvere i conflitti. Questo sviluppo ha avuto un profondo impatto sul mondo di oggi. | |||
Dopo un periodo di guerre e conflitti intensi, si stabilì un certo equilibrio di potere tra gli Stati nazionali europei. Questo equilibrio, spesso definito "equilibrio di potenza", è diventato un principio fondamentale della politica internazionale. L'equilibrio di potere presuppone che la sicurezza nazionale sia garantita quando le capacità militari ed economiche sono distribuite in modo tale che nessuno Stato sia in grado di dominare gli altri. Ciò incoraggia la cooperazione e la competizione pacifica e, in teoria, aiuta a prevenire le guerre scoraggiando le aggressioni. Questo processo ha portato anche alla stabilizzazione dei confini. Gli Stati hanno finalmente riconosciuto e rispettato i confini reciproci, il che ha contribuito ad allentare le tensioni e a mantenere la pace. | |||
Da qui è emersa l'idea di sovranità, ovvero l'idea che l'autorità sul territorio fosse divisa tra aree su cui venivano esercitate sovranità che si escludevano a vicenda. La sovranità è un principio fondamentale del sistema internazionale moderno, basato sul concetto che ogni Stato ha un'autorità suprema ed esclusiva sul proprio territorio e sulla propria popolazione. Questa autorità comprende il diritto di fare leggi, di farle rispettare e di punire chi le infrange, di controllare i confini, di intrattenere relazioni diplomatiche con altri Stati e, se necessario, di dichiarare guerra. La sovranità è intrinsecamente legata alla nozione di Stato nazionale ed è fondamentale per comprendere le dinamiche delle relazioni internazionali. Si ritiene che ogni Stato abbia il diritto di gestire i propri affari interni senza interferenze esterne, diritto riconosciuto dagli altri Stati del sistema internazionale. | |||
In definitiva, il principio di sovranità ha dato vita a un universalismo dello Stato nazionale che non era quello dell'Impero, poiché il principio di sovranità è stato riconosciuto da tutti come principio organizzatore del sistema internazionale. Il principio di sovranità e di uguaglianza tra tutti gli Stati è il fondamento del sistema internazionale e delle Nazioni Unite. Ciò significa che, in teoria, ogni Stato, grande o piccolo, ricco o povero, ha un solo voto, ad esempio all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ciò deriva dal principio dell'uguaglianza sovrana, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. L'articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite afferma che l'Organizzazione si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri. | |||
L'idea delle Nazioni Unite nasce dall'idea del principio di sovranità come organizzatore del sistema internazionale. Il sistema interstatale che si stava creando era organizzato intorno all'idea che esistesse una logica di equilibrio interno, in cui lo Stato amministrava un territorio, cioè la "polizia", e di equilibrio esterno, in cui erano gli Stati stessi a regolare i loro affari. Questa distinzione è centrale per il concetto di sovranità statale. È lo Stato che ha la prerogativa e il dovere di gestire gli affari interni, compresa l'attuazione delle leggi, garantire l'ordine pubblico, fornire servizi pubblici e amministrare la giustizia. Questa è la cosiddetta sovranità interna. La sovranità esterna è il diritto e la capacità di uno Stato di agire autonomamente sulla scena internazionale. Ciò include il diritto di entrare in relazione con altri Stati, di firmare trattati internazionali, di partecipare a organizzazioni internazionali e di condurre la propria politica estera secondo i propri interessi. | |||
Una volta costituiti, tutti questi Stati devono comunicare tra loro. Poiché ciascuno di essi deve sopravvivere come Stato e ci sono altri Stati, come faranno a comunicare? Se partiamo dal principio che la guerra è un'istituzione, serve proprio a questo. La guerra, in quanto istituzione, è stata un modo per gli Stati di comunicare tra loro. Questo non significa necessariamente che la guerra sia auspicabile o inevitabile, ma certamente ha svolto un ruolo nella formazione degli Stati e nella definizione delle relazioni tra di essi. Nella storia europea, ad esempio, le guerre sono state spesso utilizzate per risolvere dispute su territorio, potere, risorse o ideologia. I risultati di queste guerre hanno spesso portato a cambiamenti nei confini, nelle alleanze e nell'equilibrio di potere tra gli Stati. | |||
Secondo John Vasquez, la guerra è una modalità appresa di decisione politica attraverso la quale due o più unità politiche assegnano beni materiali o beni di valore simbolico sulla base di una competizione violenta. La definizione di John Vasquez sottolinea l'aspetto di competizione violenta della guerra. Secondo questa visione, la guerra è un meccanismo attraverso il quale le unità politiche, di solito gli Stati, risolvono i loro disaccordi o rivalità. Ciò può riguardare questioni di potere, territorio, risorse o ideologie. Questa definizione sottolinea una visione della guerra saldamente radicata nella tradizione di pensiero realista delle relazioni internazionali, che vede la politica internazionale come una lotta di tutti contro tutti, dove il conflitto è inevitabile e la guerra è uno strumento naturale della politica. | |||
Ci stiamo allontanando dall'idea della guerra come qualcosa di anarchico o violento; la guerra è qualcosa che è stato sviluppato nella sua concezione moderna per risolvere le controversie tra gli Stati, è un meccanismo di risoluzione dei conflitti. Ciò sembra controintuitivo perché la guerra è generalmente associata all'anarchia e alla violenza. Tuttavia, nel contesto delle relazioni internazionali e della teoria politica, la guerra può essere intesa come un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra Stati, nonostante le sue tragiche conseguenze. Questa prospettiva non cerca di minimizzare la violenza e la distruzione causate dalla guerra, ma piuttosto di capire come e perché gli Stati scelgono di usare la forza militare per risolvere i loro disaccordi. Secondo questa prospettiva, la guerra non è uno stato di caos, ma una forma di condotta politica regolata da determinate norme, regole e strategie. Per questo motivo la guerra viene spesso descritta come una "continuazione della politica con altri mezzi" - una famosa frase del teorico militare Carl von Clausewitz. Ciò significa che la guerra viene utilizzata dagli Stati come strumento per raggiungere obiettivi politici quando altri mezzi falliscono. | |||
La | La guerra può essere intesa come un meccanismo estremo di risoluzione dei conflitti, utilizzato quando i disaccordi non possono essere risolti con altri mezzi. Questo processo richiede la mobilitazione di risorse significative, come le forze armate, finanziate dal gettito fiscale degli Stati belligeranti. L'obiettivo finale è il raggiungimento di un accordo, spesso determinato dall'esito dei combattimenti. Tuttavia, la vittoria non significa necessariamente una soluzione definitiva del conflitto a favore del vincitore. L'esito della guerra può portare a compromessi, cambiamenti politici e territoriali e talvolta anche alla nascita di nuove dispute.[[Fichier:1280px-Ajaccio tempesti bataille.JPG|vignette|left|Scena di battaglia al Musée Fesch di Ajaccio di Antonio Tempesta.]] | ||
La guerra può essere vista da diversi punti di vista, a seconda della prospettiva adottata. Vista da una prospettiva umanitaria, è spesso considerata in termini di sofferenza e perdita di vite umane che provoca. Da questa prospettiva, emergono domande sulla protezione dei civili, sui diritti umani e sulle conseguenze per lo sviluppo socio-economico delle aree colpite. Da un punto di vista giuridico, la guerra comporta un complesso insieme di norme e leggi internazionali, tra cui il diritto umanitario internazionale, il diritto di guerra e vari accordi e trattati internazionali. Queste norme mirano a limitare l'impatto della guerra, in particolare proteggendo i civili e vietando alcune pratiche e armi. Tuttavia, nonostante queste norme, la posta in gioco legale rimane alta, soprattutto quando si tratta di determinare la legittimità di un intervento armato, di valutare le responsabilità in caso di violazione del diritto internazionale e di gestire le conseguenze postbelliche, come la giustizia di transizione e la ricostruzione. | |||
In breve, la guerra, come meccanismo di risoluzione dei conflitti, è un fenomeno complesso che coinvolge questioni umanitarie, politiche, economiche e legali. Questo corso si pone in un'ottica di scienza politica per analizzare l'origine di questo fenomeno e il suo utilizzo. Non siamo interessati alla dimensione normativa della guerra. | |||
Ci avviciniamo all'idea che la guerra è un meccanismo di risoluzione dei conflitti e che quindi, se la strategia ha un fine, il fine e l'obiettivo di tale strategia è la pace. Il fine ultimo della strategia militare è spesso quello di stabilire o ristabilire la pace, anche se il percorso per raggiungerla comporta l'uso della forza. Questa idea ha origine negli scritti di diversi pensatori militari, il più famoso dei quali è forse Carl von Clausewitz. Nel suo libro "Sulla guerra", Clausewitz descriveva la guerra come "la continuazione della politica con altri mezzi". Questa prospettiva suggerisce che la guerra non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere obiettivi politici, che possono includere l'instaurazione della pace. Inoltre, nella tradizione della teoria delle relazioni internazionali, la guerra è spesso vista come uno strumento che gli Stati possono utilizzare per risolvere le controversie quando non riescono a raggiungere un accordo con mezzi pacifici. Pertanto, sebbene la guerra sia un atto violento e distruttivo, può essere vista come parte di un processo più ampio volto a ripristinare la stabilità e la pace. | |||
Le due cose sono collegate. Abbiamo un concetto in cui la pace è intimamente legata alla guerra e, soprattutto, la definizione di pace è intimamente legata alla guerra. La pace è intesa come assenza di guerra. È interessante vedere come l'obiettivo della strategia sia vincere e tornare a uno stato di pace. In realtà è la guerra a determinare questo stato. C'è una dialettica molto forte tra le due cose. Ci interessa il rapporto tra guerra e Stato, ma anche tra guerra e pace. Si tratta di una relazione fondamentale che non esamineremo oggi. In molti quadri teorici, la pace è definita in opposizione alla guerra. In altre parole, la pace è spesso concettualizzata come assenza di conflitto armato. Questa visione è chiamata "pace negativa", nel senso che la pace è definita da ciò che non è (cioè la guerra) piuttosto che da ciò che è. La strategia militare spesso mira a ripristinare questo stato di "pace negativa" vincendo la guerra o raggiungendo condizioni favorevoli alla fine del conflitto. | |||
Parliamo di pace perché ciò che è importante è che nella concezione della guerra che si sta instaurando con l'emergere di questo sistema interstatale, cioè con gli Stati che si formano all'interno e competono tra loro all'esterno, la guerra non è fine a se stessa, l'obiettivo non è la condotta della guerra in sé, ma la pace; la guerra si fa per ottenere qualcosa. Questo è il punto di vista di Raymond Aron. Raymond Aron, filosofo e sociologo francese, è famoso per il suo lavoro sulla sociologia delle relazioni internazionali e sulla teoria politica. Secondo lui, la guerra non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere la pace. Ciò significa che la guerra è uno strumento politico, un mezzo utilizzato dagli Stati per raggiungere obiettivi specifici, generalmente allo scopo di risolvere i conflitti e raggiungere la pace. In questa prospettiva, la guerra è una forma estrema di diplomazia e di negoziazione tra Stati. È un'estensione della politica, attuata quando i mezzi pacifici non riescono a risolvere le controversie. È per questo motivo che Aron ha dichiarato che "la pace è il fine, la guerra è il mezzo". | |||
Il concetto di guerra come meccanismo di risoluzione dei conflitti si basa sull'idea che la guerra sia uno strumento della politica, una forma di dialogo tra gli Stati. Vi si ricorre quando i mezzi pacifici di risoluzione dei conflitti sono falliti o quando gli obiettivi non possono essere raggiunti con altri mezzi. Da questo punto di vista, gli Stati usano la guerra per raggiungere i loro obiettivi strategici, che si tratti di proteggere i loro interessi territoriali, estendere la loro influenza o rafforzare la loro sicurezza. Questi obiettivi sono generalmente guidati da una strategia militare chiaramente definita, che mira a massimizzare l'efficacia dell'uso della forza riducendo al minimo le perdite e i costi. | |||
== L'approccio alla guerra di Carl von Clausewitz == | |||
== L' | |||
[[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | [[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | ||
Carl von Clausewitz, | Carl von Clausewitz, ufficiale prussiano dell'inizio del XIX secolo, ha svolto un ruolo decisivo nella teorizzazione della guerra. Scrisse "Sulla guerra" (Vom Kriege in tedesco), che è diventato uno dei testi più influenti sulla strategia militare e sulla teoria della guerra. | ||
Clausewitz | Carl von Clausewitz prestò servizio nell'esercito prussiano durante le guerre napoleoniche, che durarono dal 1803 al 1815. Durante questo periodo, acquisì una preziosa esperienza di combattimento e di strategia militare, che influenzò le sue teorie sulla guerra. Clausewitz partecipò a diverse importanti battaglie contro l'esercito di Napoleone e fu testimone dei drammatici cambiamenti nel modo di combattere le guerre all'inizio del XIX secolo. Fu in questo periodo che iniziò a sviluppare la sua teoria secondo cui la guerra è un'estensione della politica. Dopo la fine delle guerre napoleoniche, Clausewitz continuò a servire nell'esercito prussiano e iniziò a scrivere la sua opera principale, "Sulla guerra". Tuttavia, morì prima di poter completare l'opera, che fu pubblicata postuma dalla moglie. | ||
Clausewitz | Clausewitz disse che la guerra è "la continuazione della politica con altri mezzi". Questa citazione, probabilmente la più famosa di Clausewitz, esprime l'idea che la guerra è uno strumento della politica nazionale e che gli obiettivi militari devono essere guidati da obiettivi politici. In altre parole, la guerra è uno strumento politico, non un fine in sé. Clausewitz sottolineò anche l'importanza della "nebbia di guerra" e dell'"attrito" nella conduzione delle operazioni militari. Egli sosteneva che la guerra è intrinsecamente incerta e imprevedibile e che i comandanti e gli strateghi devono essere in grado di gestire queste incertezze. Nonostante la sua morte nel 1831, il pensiero di Clausewitz continua a esercitare una grande influenza sulla teoria militare e strategica. La sua opera è studiata nelle accademie militari di tutto il mondo e rimane un riferimento essenziale nel campo della strategia militare. | ||
Clausewitz definisce la guerra come un atto di violenza volto a costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà. Si tratta di un quadro molto razionale, non della logica di un "pazzo di guerra". La guerra si combatte per ottenere qualcosa. Carl von Clausewitz concepiva la guerra come un atto di violenza volto a costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà. Secondo lui, la guerra non è un'impresa irrazionale o caotica, ma piuttosto uno strumento di politica, un mezzo razionale per perseguire gli obiettivi di uno Stato. Nella sua opera principale "Sulla guerra", Clausewitz sviluppa questa idea affermando che la guerra è semplicemente la continuazione della politica con altri mezzi. In altre parole, gli Stati usano la guerra per raggiungere obiettivi politici che non possono ottenere con mezzi pacifici. | |||
Immaginiamo uno Stato che è un governo con l'obiettivo di acquisire terre fertili per migliorare la propria economia o la sicurezza alimentare. Poiché il suo vicino non è disposto a cedere volontariamente questa terra, lo Stato sceglie di ricorrere alla guerra per raggiungere il suo obiettivo. Se lo Stato belligerante vince, è probabile che venga redatto un trattato di pace per formalizzare il trasferimento della terra. Questo trattato potrebbe includere anche altre disposizioni, come indennità di guerra, accordi per le popolazioni sfollate e una promessa di non aggressione futura. L'obiettivo iniziale (l'acquisizione di terre fertili) è stato quindi raggiunto attraverso la guerra, utilizzata come strumento di politica. | |||
Questa concezione della guerra, espressa da Clausewitz, evidenzia il fatto che la guerra è un'estensione della politica con altri mezzi. In questo contesto, la guerra è vista come uno strumento della politica, un'opzione che può essere utilizzata quando altri metodi, come la diplomazia o il commercio, non sono riusciti a risolvere i conflitti tra gli Stati. | |||
È essenziale capire che, secondo Clausewitz, la guerra non è un'entità autonoma, ma piuttosto uno strumento di politica controllato e diretto dalle autorità politiche. In altre parole, la decisione di dichiarare guerra, così come la gestione e la conduzione della guerra, sono responsabilità dei leader politici. Gli obiettivi militari sono quindi subordinati a quelli politici. Nel pensiero clausewitziano, la guerra è un mezzo per raggiungere obiettivi politici che non possono essere raggiunti con altri metodi. Tuttavia, è sempre vista come una soluzione temporanea e non come uno stato permanente. La guerra non è quindi un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere un fine: l'obiettivo politico definito dallo Stato. Una volta raggiunto questo obiettivo, o quando non è più possibile raggiungerlo, la guerra finisce e si torna a uno stato di pace. Ecco perché la nozione di pace è intrinsecamente legata a quella di guerra: la guerra mira a creare un nuovo stato di pace più favorevole allo Stato che la conduce. | |||
== Il sistema westfaliano == | |||
Il sistema di Westfalia, che prende il nome dal Trattato di Westfalia che pose fine alla Guerra dei Trent'anni nel 1648, ha influenzato profondamente la struttura politica internazionale e la comprensione della guerra. Questa serie di trattati ha sancito il concetto di sovranità statale, stabilendo l'idea che ogni Stato ha l'autorità esclusiva sul proprio territorio e sulla propria popolazione, senza interferenze esterne. Inoltre, formalizzò l'idea di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. Per quanto riguarda la guerra, il sistema di Westfalia ha contribuito a formalizzarla come attività tra Stati, piuttosto che tra fazioni o individui. Inoltre, ha incoraggiato lo sviluppo di regole e norme che disciplinano la condotta della guerra, anche se questo processo è decollato nei secoli successivi con lo sviluppo del diritto internazionale umanitario. Così, mentre la guerra continuava a essere vista come uno strumento di politica estera, il sistema di Westfalia iniziò a introdurre vincoli e regole per il suo utilizzo. Questi vincoli furono rafforzati dallo sviluppo del diritto internazionale nei secoli successivi. | |||
Hugo Grotius, noto anche come Hugo de Groot, fu una figura centrale nello sviluppo del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda le leggi di guerra e di pace. La sua opera più famosa, "De Jure Belli ac Pacis" ("Sul diritto di guerra e di pace"), pubblicata nel 1625, è considerata uno dei testi fondamentali del diritto internazionale. In quest'opera, Grozio cerca di definire un insieme di regole che disciplinano il comportamento degli Stati in tempo di guerra e di pace. Esamina in dettaglio quando la guerra è giustificata (jus ad bellum), come deve essere condotta (jus in bello) e come può essere ripristinata una pace giusta dopo il conflitto (jus post bellum). | |||
Queste idee hanno avuto un'influenza significativa sul modo in cui la guerra viene percepita e condotta, introducendo il concetto che anche in guerra alcune azioni sono inaccettabili e che la condotta della guerra deve essere regolata da determinati principi etici e legali. I principi stabiliti da Grozio hanno continuato a evolversi e a svilupparsi nel corso dei secoli, culminando nella formulazione di convenzioni internazionali più dettagliate e complete, come le Convenzioni di Ginevra, che oggi regolano il comportamento in guerra. | |||
L'organizzazione del sistema interstatale ha portato all'adozione di norme rigorose per regolare la condotta della guerra. Lo scopo di queste norme è quello di limitare, per quanto possibile, le conseguenze distruttive della guerra e di proteggere le persone che non vi sono direttamente coinvolte, come i civili o i prigionieri di guerra. Per questo motivo, secondo il diritto internazionale, una guerra deve essere dichiarata prima del suo inizio. Lo scopo di questa dichiarazione è quello di inviare un chiaro segnale a tutte le parti interessate, compresi altri Paesi e organizzazioni internazionali, che un conflitto armato è iniziato. Durante la guerra, i combattenti sono tenuti a rispettare alcune regole. Ad esempio, non devono prendere deliberatamente di mira i civili, gli edifici civili come scuole o ospedali, né usare armi proibite dal diritto internazionale, come le armi chimiche o biologiche. Infine, dopo la guerra, deve essere messo in atto un processo di pace per risolvere le controversie, punire i crimini di guerra e riparare i danni causati dal conflitto. Sebbene queste regole siano spesso violate, la loro esistenza e il loro riconoscimento universale sono un importante tentativo di civilizzare un'attività che, per sua natura, è violenta e distruttiva. | |||
La guerra, nonostante le sue conseguenze spesso devastanti, è stata integrata nel sistema interstatale come strumento di risoluzione delle controversie politiche. È importante notare, tuttavia, che l'idea non è quella di promuovere o glorificare la guerra, ma piuttosto di cercare di contenerla e regolarla. A partire dal XVII secolo, sono state stabilite numerose regole per cercare di limitare le devastazioni della guerra. Tra queste vi è il diritto internazionale umanitario, che stabilisce limiti al modo in cui la guerra può essere condotta, proteggendo le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità, come i civili, gli operatori sanitari e i prigionieri di guerra. Inoltre, il diritto internazionale ha anche stabilito regole su come dichiarare la guerra, condurre le ostilità e concludere la pace. Questo include il diritto di guerra, che stabilisce le regole per la condotta delle ostilità, e il diritto di pace, che regola la conclusione dei trattati di pace e la risoluzione dei conflitti internazionali. Questi sforzi per regolamentare la guerra riflettono il riconoscimento che, sebbene la guerra possa talvolta essere inevitabile, deve essere condotta in modo da ridurre al minimo le sofferenze umane e la distruzione materiale.[[Image:Helst, Peace of Münster.jpg|thumb|400px|<center>Banchetto della Guardia Civile di Amsterdam per celebrare la pace di Münster (1648), esposto al Rijksmuseum, opera di Bartholomeus van der Helst.]] | |||
Il Trattato di Westfalia, concluso nel 1648 per porre fine alla Guerra dei Trent'anni, era composto da due accordi separati: il Trattato di Osnabrück e il Trattato di Münster. Il Trattato di Osnabrück fu firmato tra l'Impero svedese e il Sacro Romano Impero, mentre il Trattato di Münster fu concluso tra il Sacro Romano Impero e le Province Unite (oggi Paesi Bassi) e tra il Sacro Romano Impero e la Francia. Questi trattati sono storicamente importanti perché hanno gettato le basi del moderno ordine internazionale basato sulla sovranità degli Stati. Furono stabiliti il principio di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e il principio dei pesi e contrappesi. Il Trattato di Westfalia segnò la fine dell'idea di un impero cristiano universale in Europa e aprì la strada a un sistema di Stati nazionali indipendenti e sovrani. | |||
I Trattati di Westfalia posero fine alla Guerra dei Trent'anni, una guerra di religione che dilaniò l'Europa, e in particolare il Sacro Romano Impero, tra il 1618 e il 1648. La guerra fu combattuta principalmente tra forze cattoliche e protestanti, sebbene anche la politica e la lotta per il potere giocassero un ruolo importante. Ponendo fine alla guerra, i Trattati di Westfalia non solo portarono una gradita pace, ma segnarono anche un cambiamento fondamentale nell'organizzazione politica dell'Europa. Prima di questi trattati, era ancora viva l'idea di un impero cristiano universale, in cui un'autorità superiore (il Papa o il Sacro Romano Imperatore) avrebbe avuto una certa autorità su regni e principati. I Trattati di Westfalia stabilirono il principio della sovranità statale, affermando che ogni Stato aveva un'autorità assoluta ed esclusiva sul proprio territorio e sul proprio popolo. Ciò significava che, per la prima volta, gli Stati, piuttosto che gli imperatori o i papi, diventavano i principali attori sulla scena internazionale. Si tratta del cosiddetto "sistema di Westfalia", che rimane il fondamento dell'ordine internazionale moderno. | |||
La Svizzera è stata riconosciuta come entità indipendente con il Trattato di Westfalia del 1648, anche se la sua forma attuale di Stato ha richiesto più tempo per consolidarsi. La neutralità perpetua della Svizzera fu stabilita anche al Congresso di Vienna del 1815, rafforzando il suo status distinto sulla scena internazionale. Tuttavia, va notato che la Confederazione svizzera come unione di cantoni esisteva già prima del Trattato di Westfalia. La sua struttura unica, tuttavia, non corrispondeva esattamente al concetto di Stato nazionale emerso con il sistema di Westfalia. Per questo motivo, la Svizzera ha tardato a emergere nella sua forma moderna. | |||
Il Trattato di Westfalia ha posto le basi del moderno sistema internazionale basato sulla sovranità nazionale. In altre parole, ogni Stato ha il diritto di governare il proprio territorio come meglio crede senza interferenze esterne. Questo principio di non interferenza negli affari interni degli altri Stati è un pilastro fondamentale del sistema internazionale. Detto questo, non elimina i conflitti o i disaccordi tra gli Stati. Quando sorge una controversia, si può ricorrere alla guerra come mezzo di risoluzione. Tuttavia, nel mondo moderno si preferiscono altre forme di risoluzione dei conflitti, come la diplomazia, il dialogo e la negoziazione. La guerra è spesso considerata l'ultima risorsa quando nessun'altra opzione è praticabile o efficace. | |||
La distinzione tra spazio interno ed esterno degli Stati è fondamentale per la politica internazionale. All'interno dei suoi confini, uno Stato ha la sovranità di far rispettare le proprie leggi e regolamenti e di mantenere l'ordine come ritiene necessario. Questo spazio interno è spesso caratterizzato da un insieme di regole e norme ben definite, ampiamente riconosciute e rispettate. Al di fuori dei propri confini, uno Stato deve navigare in un ambiente più complesso e spesso meno regolamentato, dove le interazioni avvengono principalmente tra Stati sovrani che possono avere interessi divergenti. Questo spazio esterno è regolato dal diritto internazionale, che è meno vincolante e dipende maggiormente dalla cooperazione tra gli Stati. | |||
Il principio di sovranità, sebbene stabilisca l'uguaglianza formale di tutti gli Stati nel diritto internazionale, non si traduce necessariamente in un'uguaglianza reale sulla scena internazionale. Alcuni Stati, grazie al loro potere economico, militare o strategico, possono esercitare un'influenza sproporzionata. Allo stesso tempo, l'ascesa degli attori non statali ha reso più complesso il panorama internazionale. Le organizzazioni non governative (ONG), le multinazionali e persino i singoli individui (come attivisti, dissidenti politici o celebrità) possono ora svolgere ruoli significativi nella politica internazionale. Questi attori possono influenzare le politiche globali mobilitando l'opinione pubblica, intraprendendo azioni dirette, fornendo servizi essenziali o esercitando il potere economico. Tuttavia, nonostante la crescente influenza di questi attori non statali, gli Stati rimangono gli attori principali e più potenti sulla scena internazionale. | |||
Nel sistema internazionale contemporaneo, lo Stato è l'unità politica fondamentale. Il concetto di Stato-nazione sovrano, sebbene criticato e spesso complicato dalle questioni del transnazionalismo, della globalizzazione e delle relazioni internazionali interdipendenti, rimane il principale organizzatore della politica mondiale. Ogni Stato, in quanto entità sovrana, dovrebbe esercitare un'autorità assoluta sul proprio territorio e sulla propria popolazione. Il sistema internazionale si basa sull'interazione tra questi Stati sovrani e sul rispetto dei principi di non interferenza negli affari interni degli altri Stati. Tuttavia, la realtà è spesso più complessa. Numerosi attori non statali - dalle multinazionali ai gruppi terroristici, dalle organizzazioni non governative alle istituzioni internazionali - svolgono un ruolo importante sulla scena internazionale. A volte, questi attori possono persino sfidare l'autorità e la sovranità degli Stati. Ma nonostante queste sfide, l'idea di Stato nazionale rimane centrale per comprendere e strutturare il nostro mondo politico. | |||
Non si parla di "world studies" o "global studies". Il termine che si è imposto è "relazioni internazionali". Il campo di studio delle "relazioni internazionali" si concentra sull'interazione tra gli Stati e, più in generale, tra gli attori della scena mondiale. Non si tratta semplicemente di studiare il mondo nel suo complesso, ma di capire come gli Stati interagiscono tra loro, come negoziano e si contendono il potere, come collaborano e come entrano in conflitto. L'accento è posto sulle "relazioni" perché è attraverso di esse che gli Stati si definiscono l'uno rispetto all'altro, modellano la loro politica estera e influenzano il sistema internazionale. Per questo motivo, nonostante la crescente interdipendenza e globalizzazione, la nozione di Stato nazionale e di confine statale rimangono concetti chiave nella teoria e nella pratica delle relazioni internazionali. La strutturazione dello spazio tra gli Stati è infatti una dimensione fondamentale nell'analisi delle relazioni internazionali. È questa strutturazione che determina, tra l'altro, le alleanze, i conflitti, il commercio e i flussi di popolazione. Ha anche un'influenza significativa sulla governance globale e sullo sviluppo di standard internazionali. | |||
Il Trattato di Westfalia, firmato nel 1648, ha posto le basi dell'ordine internazionale moderno basato sul principio della sovranità nazionale. Secondo questo principio, ogni Stato ha il diritto di governare il proprio territorio e la propria popolazione senza interferenze esterne. L'uguaglianza sovrana significa che, dal punto di vista del diritto internazionale, tutti gli Stati sono uguali, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla loro ricchezza o dal loro potere. Significa che ogni Stato ha il diritto di partecipare pienamente alla comunità internazionale e di essere rispettato dagli altri Stati. | |||
Detto questo, se il Trattato di Westfalia ha stabilito la sovranità e l'uguaglianza sovrana come principi fondamentali del sistema internazionale, non significa che la guerra sia una conseguenza inevitabile di questi principi. Infatti, sebbene le controversie tra gli Stati possano portare a un conflitto armato, la guerra non è né l'unico né il più auspicabile mezzo di risoluzione delle controversie. I principi del diritto internazionale, come la risoluzione pacifica delle controversie, sono anche centrali per l'ordine internazionale emerso da Westfalia. Inoltre, nel corso dei secoli, le norme e le istituzioni internazionali si sono evolute per governare e regolare la condotta della guerra e per promuovere il dialogo, la negoziazione e la cooperazione tra gli Stati. Il sistema di Westfalia non è quindi una semplice licenza per la guerra, ma il quadro all'interno del quale gli Stati coesistono, collaborano e, a volte, si scontrano. | |||
== Dalla guerra totale alla guerra istituzionalizzata (Holsti) == | |||
Il XVII secolo è stato un periodo di significative trasformazioni nell'organizzazione politica e sociale di molti Paesi, che ha portato all'emergere dello Stato moderno. In questo periodo gli Stati iniziarono a consolidare il loro potere, a centralizzare l'autorità, a imporre sistematicamente le tasse e a sviluppare burocrazie più efficienti e strutturate. La centralizzazione e la burocratizzazione permisero agli Stati di accumulare risorse e di mobilitarle in modo più efficace, soprattutto in vista di una guerra. Man mano che gli Stati diventavano più potenti ed efficienti, erano in grado di condurre guerre su scala più ampia e con maggiore intensità. Ciò ha spianato la strada alla cosiddetta "guerra totale", in cui tutti gli aspetti della società sono mobilitati per lo sforzo bellico e la distinzione tra combattenti e non combattenti diventa meno netta. Parallelamente a questi cambiamenti, anche il sistema internazionale si stava evolvendo, con l'istituzione del sistema di Westfalia basato sulla sovranità statale. Questi due processi - l'evoluzione dello Stato e la trasformazione del sistema internazionale - si sono rafforzati a vicenda. Il consolidamento dello Stato ha contribuito all'ascesa del sistema di Westfalia, mentre quest'ultimo ha fornito un quadro di riferimento per lo sviluppo e il rafforzamento degli Stati. | |||
Se da un lato lo Stato moderno ha contribuito notevolmente alla riduzione della violenza interpersonale, stabilendo un ordine sociale interno e un monopolio sull'uso legittimo della forza, dall'altro la sua maggiore capacità di mobilitare e concentrare le risorse ha portato alla possibilità di conflitti su scala più ampia, spesso con conseguenze devastanti. Nel contesto delle relazioni internazionali, il sistema westfaliano ha creato un ambiente in cui gli Stati, cercando di proteggere i propri interessi e garantire la propria sicurezza, potevano ricorrere alla guerra come mezzo per risolvere le loro divergenze. Ciò ha portato a guerre sempre più distruttive, culminate nelle due guerre mondiali del XX secolo. | |||
L'evoluzione delle norme e delle regole sulla guerra ha portato a una più chiara distinzione tra combattenti e non combattenti, con lo sforzo di proteggere questi ultimi dagli effetti diretti della guerra. Questa idea è stata codificata nel diritto internazionale umanitario, in particolare nelle Convenzioni di Ginevra. Nel Medioevo, la distinzione tra civili e combattenti non era sempre chiara e i civili erano spesso direttamente colpiti dalla guerra. Tuttavia, con lo sviluppo dello Stato moderno e la codificazione della guerra, è emersa la norma secondo cui i civili devono essere risparmiati il più possibile durante i conflitti. Detto questo, sebbene la distinzione sia oggi ampiamente riconosciuta e rispettata in teoria, purtroppo è spesso ignorata nella pratica. Molti conflitti contemporanei hanno visto gravi violazioni di questa norma, con attacchi deliberati ai civili e sofferenze enormi per le popolazioni non combattenti. | |||
A partire dal XVII secolo, con l'ascesa dello Stato nazionale e la professionalizzazione degli eserciti, si è assistito a una riduzione dell'impatto diretto della guerra sui civili. I combattenti - generalmente soldati professionisti - sono diventati i principali partecipanti e vittime della guerra. Tuttavia, questa tendenza si è invertita nel corso del XX secolo, in particolare con le due guerre mondiali e altri grandi conflitti, in cui i civili sono stati spesso presi di mira o sono diventati vittime collaterali. La situazione si è intensificata dopo la fine della Guerra Fredda, con l'aumento dei conflitti interni agli Stati e dei gruppi armati non statali. In questi conflitti, i civili sono spesso direttamente presi di mira e costituiscono la maggior parte delle vittime. | |||
L'emergere della guerra moderna è intrinsecamente legato all'emergere dello Stato nazionale. Nel Medioevo, i conflitti erano caratterizzati da una fluidità di strutture e fazioni, che comprendevano città-stato, ordini religiosi come il papato, signori della guerra e altri gruppi che cambiavano spesso alleanze in base ai loro interessi del momento. Era un'epoca in cui la violenza era onnipresente, ma i confini del conflitto erano spesso sfumati e mutevoli. Con l'ascesa dello Stato-nazione, la natura della guerra cambiò in modo significativo. Gli Stati iniziarono a formare eserciti di soldati, identificabili dalle loro uniformi, che servivano come rappresentanti dello Stato sul campo di battaglia. Che si trattasse di professionisti pagati o di coscritti mobilitati per il servizio militare, questi soldati simboleggiavano la capacità e l'autorità dello Stato di proiettare forza e difendere i propri interessi. La guerra divenne così un'estensione delle relazioni interstatali e delle politiche statali, con regole e convenzioni più chiaramente definite. | |||
== Dalla guerra totale alla guerra istituzionalizzata (Holsti) == | |||
La Pace di Westfalia ha creato un nuovo sistema politico, noto come sistema di Westfalia, che ha formalizzato l'idea di Stati nazionali sovrani. In questo sistema, la guerra divenne uno strumento istituzionalizzato per risolvere i conflitti tra gli Stati. Invece di essere una serie di schermaglie caotiche e continue, la guerra divenne uno stato dichiarato e riconosciuto di conflitto aperto tra Stati sovrani. Questo ha portato anche alla nascita di regole e convenzioni di guerra, volte a limitare gli effetti distruttivi del conflitto e a proteggere i diritti dei combattenti e dei civili. Queste regole sono state formalizzate in trattati e convenzioni internazionali, come le Convenzioni di Ginevra. | |||
K. J. Holsti, nel suo libro "The State, War, and the State of War" (1996), distingue tra due tipi di guerra. Le "guerre di tipo 1" che definisce sono le guerre tradizionali tra Stati, che sono state la norma dal Trattato di Westfalia fino alla fine della Guerra fredda. Questi conflitti sono generalmente chiaramente definiti, con dichiarazioni di guerra formali, fronti militari chiari e la fine delle ostilità spesso segnata da trattati di pace. Le "guerre di tipo 2", secondo Holsti, sono invece le guerre moderne, che tendono a essere molto più caotiche e meno chiaramente definite. Possono coinvolgere attori non statali come gruppi terroristici, milizie o bande. Questi conflitti possono scoppiare all'interno dei confini statali, piuttosto che tra Stati diversi, e possono durare decenni, con una violenza costante piuttosto che un inizio e una fine chiaramente definiti. | |||
Il periodo tra il 1648 e il 1789 viene spesso definito come l'era della "guerra limitata" o della "guerra di gabinetto". Queste guerre avevano generalmente obiettivi chiari e limitati. Spesso venivano combattute per motivi specifici, come il controllo di particolari territori o la risoluzione di specifiche controversie tra Stati. Queste guerre erano solitamente combattute da eserciti professionali sotto il diretto controllo del governo statale, da cui il termine "guerra di gabinetto". L'idea era quella di utilizzare la guerra come strumento per raggiungere specifici obiettivi politici, piuttosto che cercare la distruzione totale del nemico. Ciò corrisponde al concetto clausewitziano di guerra come "continuazione della politica con altri mezzi". Queste guerre erano generalmente ben strutturate, con dichiarazioni di guerra formali, regole di condotta concordate e, infine, trattati di pace per risolvere formalmente il conflitto. Ciò riflette il livello di formalizzazione e istituzionalizzazione del concetto di guerra in questo periodo. Tuttavia, la situazione iniziò a cambiare con le guerre rivoluzionarie e napoleoniche della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo, caratterizzate da una mobilitazione di massa e da un livello di distruzione molto più elevato. Queste guerre hanno aperto la strada all'era delle "guerre totali" del XX secolo. | |||
Questo periodo storico, generalmente compreso tra il Trattato di Westfalia del 1648 e la Rivoluzione francese del 1789, ha visto un'importante codificazione delle strutture militari e delle regole di guerra. La comparsa di uniformi distintive è un segno di questa codificazione. Le uniformi aiutavano a identificare chiaramente i belligeranti sul campo di battaglia, contribuendo a una misura di disciplina e ordine. Questo periodo vide anche l'affermarsi di quella che potremmo definire una "cultura militare" professionale. Gli eserciti di questo periodo erano spesso comandati da membri della nobiltà, che venivano addestrati all'arte della guerra e vedevano il servizio militare come un'estensione dei loro obblighi sociali e politici. È spesso in questo periodo che si assiste all'emergere della "noblesse d'épée", una classe di nobili che traeva il proprio status e la propria reputazione dal servizio nell'esercito. Allo stesso tempo, le regole di guerra vennero codificate, portando a una maggiore attenzione ai diritti dei prigionieri di guerra, all'immunità diplomatica e ad altri aspetti del diritto di guerra. Questi codici di condotta furono rafforzati da trattati e convenzioni internazionali, gettando le basi del moderno diritto internazionale. | |||
Durante questo periodo storico, le guerre erano generalmente caratterizzate da obiettivi limitati e da impegni relativamente brevi. I belligeranti spesso cercavano di raggiungere obiettivi strategici specifici, come la conquista di un particolare territorio o di una fortezza, piuttosto che la distruzione totale del nemico. Questi conflitti erano spesso caratterizzati dalla "guerra di manovra", in cui gli eserciti cercavano di ottenere un vantaggio strategico attraverso il movimento e la posizione piuttosto che con il combattimento frontale. Le battaglie erano spesso l'eccezione piuttosto che la regola e molti conflitti si concludevano con negoziati piuttosto che con una vittoria militare totale. Questo modo di condurre la guerra era in parte una conseguenza dei vincoli logistici dell'epoca. Gli eserciti erano spesso limitati dalla loro capacità di rifornire le truppe di cibo, acqua e munizioni, il che limitava la durata e la portata degli impegni militari. | |||
In questo periodo di guerra limitata, l'obiettivo non era l'annientamento totale dell'avversario, ma piuttosto il raggiungimento di specifici obiettivi strategici. Le battaglie erano spesso orchestrate con cura e gli eserciti cercavano di ridurre al minimo le perdite di vite umane non necessarie. L'enfasi era sulla strategia e sulla tattica, non sulla distruzione indiscriminata. I civili venivano generalmente risparmiati, in parte perché la guerra era vista come un affare tra Stati, non tra popoli. Tuttavia, questo non significa che i civili non fossero mai colpiti. Lo sconvolgimento causato dalla guerra poteva portare a carestie, epidemie e altre forme di sofferenza per le popolazioni civili. | |||
La | La Guerra di successione spagnola (1701-1714) è un buon esempio di guerra di questo periodo. Fu scatenata dalla morte del re Carlo II di Spagna senza un erede diretto. Il conflitto contrappose le principali potenze europee che cercavano di controllare la successione al trono spagnolo e, di conseguenza, di aumentare la propria influenza e il proprio potere in Europa. La guerra fu limitata nel tempo e, sebbene fosse brutale e costosa in termini di vite umane, era regolata da regole e convenzioni accettate che ne limitavano l'intensità e la portata. Ad esempio, le battaglie furono generalmente combattute da eserciti regolari e i civili furono ampiamente risparmiati. Tuttavia, questa guerra fu significativa in termini di cambiamenti geopolitici. Vide l'ascesa della Gran Bretagna e segnò una svolta negli equilibri di potere in Europa. Essa portò anche al Trattato di Utrecht del 1713, che ridefinì i confini ed ebbe un impatto duraturo sulla politica europea. | ||
Il periodo che va dalla fine del XVII secolo al XVIII secolo fu caratterizzato dalla graduale codificazione degli eserciti. Questa codificazione riguardò molti aspetti della condotta militare. La struttura degli eserciti iniziò a essere formalizzata con l'introduzione di gerarchie chiaramente definite e di ruoli militari specifici. Questo portò a una migliore organizzazione e coordinamento delle forze armate. La codificazione delle uniformi fu un altro aspetto importante. Le uniformi militari non solo distinguevano i soldati dai civili, ma permettevano anche di distinguere gli alleati dai nemici e di identificare il grado e il ruolo di ciascun soldato. Anche il comportamento sul campo di battaglia fu regolamentato. Furono stabilite regole specifiche per disciplinare le azioni in tempo di guerra, compreso il trattamento dei prigionieri di guerra e la condotta nei confronti dei civili. Questa codificazione degli eserciti è stata una parte essenziale della formazione degli Stati nazionali moderni. Ha portato a una maggiore efficienza e a una migliore organizzazione nella conduzione della guerra, limitando al contempo alcune forme di violenza e proteggendo in una certa misura i non combattenti. | |||
Le uniformi militari hanno svolto un ruolo cruciale nell'identificazione e nell'organizzazione delle forze armate durante questo periodo. Svolgevano una serie di funzioni importanti. In primo luogo, l'identificazione. Le uniformi aiutavano a distinguere gli alleati dagli avversari sul campo di battaglia. Servivano anche a identificare il grado e la funzione di un individuo all'interno dell'esercito. Questo è un modo per creare chiarezza durante i conflitti, dove le situazioni possono essere caotiche e mutevoli. In secondo luogo, l'uniforme crea un senso di unità tra i soldati. Indossando gli stessi abiti, i soldati si sentono legati gli uni agli altri, condividendo un'identità comune. L'uniforme simboleggia la loro lealtà allo Stato e il loro impegno per la causa per cui combattono. In secondo luogo, l'uniforme promuove la disciplina e l'ordine. Imponendo l'abito uniforme, l'esercito rafforza la sua organizzazione gerarchica e strutturata. È un promemoria costante del rigore e della struttura che la vita militare richiede. Infine, l'uniforme è anche uno strumento per rappresentare il potere e il prestigio dello Stato. Spesso è progettata per impressionare o intimidire gli avversari. È una dichiarazione visiva della forza e del potenziale dello Stato. La standardizzazione dell'abbigliamento militare iniziò a verificarsi a partire dal XVII secolo, parallelamente allo sviluppo dello Stato moderno e degli eserciti permanenti. Questo processo è stato influenzato dai progressi tecnologici che hanno reso possibile la produzione di massa di abiti, nonché dalla necessità di una maggiore disciplina e organizzazione all'interno delle forze armate. | |||
== Il secondo tipo di guerra o guerra totale: 1789-1815 e 1914-1945 == | |||
[[File:Charles Meynier - Napoleon in Berlin.png|thumb|Napoleone a Berlino (Meynier). Dopo aver sconfitto le forze prussiane a Jena, l'esercito francese entrò a Berlino il 27 ottobre 1806.]] | |||
Continuando la tipologia di K.J. Holsti, le guerre del secondo tipo sono emerse con le guerre della Rivoluzione e dell'Impero all'inizio del XIX secolo. Questi conflitti si differenziano notevolmente dal primo tipo di guerre del XVII e XVIII secolo. | |||
Le guerre del secondo tipo, note anche come guerre di massa o guerre napoleoniche, erano caratterizzate da una mobilitazione senza precedenti di risorse umane e materiali. Sono definite dal desiderio di annientare il nemico, a differenza delle guerre del primo tipo, che miravano principalmente a raggiungere obiettivi politici limitati. Queste guerre sono spesso più lunghe, costose e distruttive. I conflitti non si limitano più a battaglie singole e limitate, ma si estendono a campagne militari su larga scala. Inoltre, la distinzione tra combattenti e civili è diventata meno netta, con intere popolazioni coinvolte nello sforzo bellico, sia attraverso la coscrizione che il sostegno allo sforzo bellico. Le guerre napoleoniche sono un classico esempio di questo tipo di guerra, con milioni di persone mobilitate in tutta Europa, una serie di conflitti durati oltre un decennio e importanti cambiamenti politici e territoriali come risultato. | |||
La | La Rivoluzione francese del 1789 segnò una svolta importante nel modo di combattere le guerre. Con l'emergere delle idee rivoluzionarie di libertà, uguaglianza e fraternità, la guerra divenne più di un semplice strumento di politica statale. Divenne un'espressione delle aspirazioni e delle ambizioni collettive della nazione. Il concetto di "nazione in armi" apparve per la prima volta in questo periodo. Questo concetto faceva parte dell'idea di una mobilitazione totale della popolazione in preparazione alla guerra. Non si trattava più solo di professionisti della guerra o di mercenari che combattevano, ma dell'intera popolazione, compresi i cittadini comuni. Questi cittadini sono chiamati a prendere le armi non solo per difendere il territorio, ma anche per difendere l'idea stessa di nazione e i principi su cui si basa. Ciò è stato reso possibile dalla levée en masse, una misura rivoluzionaria che ha permesso di arruolare un gran numero di cittadini nell'esercito. Questa misura permise alla Francia di mobilitare notevoli risorse umane per far fronte alla minaccia delle potenze europee schierate contro di lei. La conseguenza di questo nuovo approccio alla guerra fu un'escalation di violenza e distruzione senza precedenti e il crescente coinvolgimento dei civili nel conflitto. Questa tendenza sarebbe continuata e si sarebbe intensificata nei due secoli successivi, in particolare con le due guerre mondiali del XX secolo. | ||
Le | La Rivoluzione francese sconvolse l'ordine stabilito in Europa. Le monarchie tradizionali, minacciate dalle idee rivoluzionarie di sovranità popolare e democrazia, formarono coalizioni per cercare di ripristinare l'Ancien Régime in Francia. In risposta a queste minacce esterne, i leader rivoluzionari francesi decisero di costituire un grande esercito di cittadini. Si trattava di un'importante rottura con il passato, quando gli eserciti erano costituiti principalmente da mercenari o truppe professionali. Il decreto Levée en masse, adottato nel 1793, mobilitò tutti i cittadini francesi in età militare. L'obiettivo era quello di respingere gli eserciti delle monarchie europee che stavano invadendo la Francia. Questa mobilitazione di massa portò alla formazione di un esercito di diverse centinaia di migliaia di soldati, che alla fine riuscì a respingere le invasioni e a preservare la Rivoluzione. Questa mobilitazione di massa è considerata la prima mobilitazione nazionale della storia moderna. Trasformò la natura della guerra da un conflitto limitato tra guerrieri professionisti a una lotta che coinvolgeva l'intera nazione. Cambiò anche il rapporto tra i cittadini e lo Stato, poiché il loro ruolo non era più solo quello di obbedire, ma anche di difendere attivamente la nazione e i suoi ideali. | ||
Il passaggio a un esercito di leva richiedeva uno Stato moderno e organizzato, capace di fare il punto sulla popolazione, di addestrare ed equipaggiare rapidamente migliaia di soldati e di sostenere lo sforzo bellico a lungo termine. La mobilitazione di massa trasformò la natura della guerra rendendo possibile la mobilitazione di eserciti molto grandi. Sotto Napoleone, ad esempio, l'esercito francese arrivò a contare oltre 600.000 uomini, una cifra senza precedenti per l'epoca. Ciò aumentò anche la capacità dell'esercito di condurre operazioni su più fronti contemporaneamente. Tuttavia, ha anche aumentato la complessità della logistica militare, richiedendo la fornitura di cibo, armi e munizioni per molti più soldati. Ha quindi richiesto uno Stato più efficiente e organizzato, in grado di pianificare e sostenere queste operazioni su larga scala. Ha portato anche a un cambiamento nella natura stessa della guerra. Con eserciti così grandi, le battaglie sono diventate più distruttive e hanno provocato un maggior numero di vittime. La guerra divenne un affare di intere nazioni, coinvolgendo non solo i soldati, ma anche i civili che sostenevano lo sforzo bellico nelle retrovie. | |||
L'introduzione di un esercito di leva richiede uno Stato moderno, per diverse ragioni. In primo luogo, uno Stato moderno ha un'amministrazione efficiente. Questa amministrazione è necessaria per identificare la popolazione e gestire la coscrizione. Identificare, registrare, mobilitare e addestrare le reclute è un compito amministrativo enorme che richiede una burocrazia efficiente. In secondo luogo, lo Stato deve avere la capacità logistica di sostenere un grande esercito. Ciò significa che deve essere in grado di fornire cibo, vestiti, armi e munizioni a un gran numero di soldati. Deve anche avere la capacità di curare i feriti. Tutti questi compiti richiedono una solida infrastruttura logistica. In terzo luogo, uno Stato moderno ha generalmente un'economia abbastanza forte da sostenere un esercito di leva. Le guerre sono costose e occorre uno Stato in grado di finanziare queste spese. Infine, la mobilitazione di massa richiede un certo grado di coesione e solidarietà sociale. Lo Stato deve avere la legittimità di chiedere ai suoi cittadini di combattere e morire per lui. Questo è generalmente più facile in uno Stato nazionale, dove i cittadini condividono un senso di appartenenza comune. Infine, il passaggio a un esercito di leva è una manifestazione della modernità di uno Stato, che illustra la sua capacità di esercitare potere sui propri cittadini e di mobilitare le proprie risorse per raggiungere i propri obiettivi. | |||
Il secondo tipo di guerra, secondo la tipologia di Holsti, è caratterizzato da eserciti di leva su larga scala e non più da eserciti professionali basati su mercenari. Queste guerre sono emerse dopo la Rivoluzione francese e hanno raggiunto il loro apogeo con le guerre napoleoniche. L'idea di fondo è che l'intera nazione, piuttosto che una casta di guerrieri o un'élite professionale, viene mobilitata per la guerra. I soldati non combattevano più per la paga, ma per la difesa della nazione e dei suoi valori. Si tratta di una grande trasformazione nella natura della guerra, che comporta un grado molto maggiore di impegno e sacrificio da parte dei cittadini. Questa nuova forma di guerra ha reso possibile la costituzione di eserciti molto più grandi e potenti rispetto al passato, che hanno contribuito al dominio di Napoleone sull'Europa. Inoltre, questi eserciti nazionalisti cambiarono il modo in cui la guerra veniva percepita e vissuta dalla popolazione. La guerra non era più un affare professionale, ma una causa per la quale ogni cittadino era pronto a dare la propria vita. Ciò ebbe anche un impatto significativo sulla natura dei conflitti e sull'entità delle distruzioni e delle perdite di vite umane che potevano causare. | |||
La natura ideologica delle guerre rivoluzionarie porta a un'intensificazione del conflitto. A differenza delle guerre cosiddette "tradizionali", dove gli obiettivi sono spesso territoriali o materiali, le guerre rivoluzionarie tendono ad avere obiettivi più astratti e fondamentali. Non si tratta più semplicemente di conquistare un territorio o di appropriarsi di risorse, ma di difendere un'idea, un ideale o addirittura un'identità. In questo contesto, il nemico non è solo un avversario militare, ma anche una minaccia all'esistenza stessa della nazione e dei suoi valori. Di conseguenza, l'obiettivo non è solo quello di sconfiggere il nemico sul campo di battaglia, ma di annientarlo completamente, perché la sua sola esistenza è percepita come una minaccia. Questo può portare a un'escalation di violenza e a guerre particolarmente letali e distruttive. Anche il fatto che l'intera popolazione sia mobilitata per la guerra contribuisce all'intensificazione dei conflitti, poiché tutti si sentono coinvolti in prima persona e pronti a sacrificarsi per la causa. D'altra parte, queste guerre possono anche essere percepite come più legittime o giustificate da chi le conduce, perché combatte per una causa in cui crede profondamente e non semplicemente per il potere o il profitto. Questo può contribuire a rafforzare l'unità nazionale e la determinazione a combattere. | |||
Nelle guerre del secondo tipo, come quelle rivoluzionarie, la natura degli obiettivi cambia significativamente rispetto ai conflitti più tradizionali. Gli obiettivi non sono più puramente materiali, come la conquista del territorio o il controllo delle risorse, ma diventano ideologici e astratti. Questi obiettivi, come "liberazione", "democrazia" o "lotta di classe", non sono solo aperti, ma anche vaghi e soggettivi. Non possono essere misurati o raggiunti in termini concreti, il che può rendere difficile definire o raggiungere la fine del conflitto. Inoltre, questi obiettivi più astratti possono anche portare a conflitti più intensi e prolungati. Poiché questi obiettivi sono spesso percepiti come essenziali per l'identità o la sopravvivenza di una nazione, i combattenti sono spesso disposti a spingersi oltre e a correre maggiori rischi per raggiungerli. Infine, questi obiettivi ideologici possono anche rendere più difficile il raggiungimento di un accordo di pace. Essendo spesso assoluti e non negoziabili, questi obiettivi richiedono spesso la resa incondizionata dell'avversario, il che può complicare i negoziati e prolungare la durata dei conflitti. | |||
La | La Seconda guerra mondiale è una perfetta illustrazione del concetto di "guerra del secondo tipo". L'obiettivo principale non era solo quello di sconfiggere militarmente la Germania nazista, ma anche di eliminare la stessa ideologia nazista. Questa guerra non era semplicemente una questione di territorio o di risorse, ma una lotta ideologica. L'obiettivo non era una resa tradizionale, in cui le forze nemiche depongono le armi e tornano a casa. Al contrario, l'obiettivo era lo sradicamento totale del nazismo come sistema politico e ideologico. Questo portò alla richiesta di "resa incondizionata" da parte degli Alleati, il che significa che i nazisti non avevano alcuna possibilità di negoziare i termini della loro resa. Si trattava di una richiesta insolita nel contesto storico dei conflitti, che illustrava la natura eccezionale e totale di questa guerra. Inoltre, dopo la fine della guerra, la Germania fu occupata e divisa e fu intrapreso un processo di "denazificazione" per eliminare l'influenza nazista dalla società tedesca. Ciò dimostrò la portata dell'impegno degli Alleati nell'eliminare non solo la minaccia militare nazista, ma anche la stessa ideologia nazista. | ||
Il passaggio a questo tipo di guerra totale fu strettamente legato all'evoluzione dello Stato. Con l'emergere dello Stato nazionale moderno e del nazionalismo nel XVIII e XIX secolo, la guerra divenne sempre più una questione di tutto il popolo, non solo dell'esercito. Nelle guerre totali del XX secolo, come le due guerre mondiali, tutti gli aspetti della società e dell'economia furono mobilitati per lo sforzo bellico. I civili divennero obiettivi di guerra, sia direttamente attraverso i bombardamenti, sia indirettamente attraverso i blocchi e le carestie. Inoltre, la ragion d'essere di queste guerre era spesso espressa in termini ideologici o esistenziali, come la difesa della democrazia contro il fascismo o la lotta per la sopravvivenza della nazione. In questo contesto, una semplice vittoria sul campo di battaglia non era sufficiente: il nemico doveva essere completamente sconfitto e il suo sistema politico e ideologico smantellato. | |||
Il regime nazista fu in grado di salire al potere e di commettere atrocità su scala così massiccia soprattutto grazie alle infrastrutture e all'apparato statale della Germania di allora. Le strutture statali moderne, comprese le istituzioni burocratiche, militari ed economiche altamente centralizzate, possono essere potenzialmente dirottate per scopi nefasti, come è accaduto con il nazismo in Germania. Senza uno Stato così potente e ben organizzato, sarebbe stato molto più difficile, se non impossibile, per ideologie totalitarie come il nazismo attuare i propri piani distruttivi su scala così massiccia. Allo stesso modo, senza la potenza industriale e militare di uno Stato moderno, il regime nazista non sarebbe stato in grado di lanciare una guerra su scala globale. | |||
La Seconda guerra mondiale ha segnato una svolta significativa nel modo di condurre la guerra, soprattutto in termini di obiettivi. Con la diffusione dei bombardamenti aerei e l'industrializzazione della guerra, i civili divennero bersagli diretti. Questa guerra ha visto la maggior parte delle vittime spostarsi dai soldati ai civili. In questo contesto, le armi di distruzione di massa, come le bombe atomiche, possono causare distruzioni massicce e la morte di migliaia, persino centinaia di migliaia di civili in un istante. Inoltre, lo sforzo bellico coinvolge l'intera popolazione e l'industria degli armamenti è spesso un obiettivo prioritario, con conseguente aumento del numero di vittime civili. Il secondo tipo di guerra ha visto anche l'attuazione di politiche genocide e di crimini contro l'umanità su larga scala, che richiedono risorse industriali e organizzazione statale. I campi di concentramento e di sterminio nazisti sono un tragico esempio di come la capacità industriale e la burocrazia statale possano essere utilizzate per scopi disumani. Tutto ciò illustra ancora una volta quanto lo Stato moderno e la sua capacità di organizzare e mobilitare risorse possano avere conseguenze drammatiche quando vengono utilizzati in modo improprio. | |||
La storia del XX secolo mostra chiaramente che guerra e industrializzazione sono intrinsecamente legate. Durante le due guerre mondiali, le nazioni hanno dovuto trasformare rapidamente le loro economie per sostenere lo sforzo bellico, portando a una significativa accelerazione dell'industrializzazione. Le fabbriche che in precedenza erano state dedicate alla produzione di beni di consumo furono convertite per produrre armi, veicoli militari, munizioni e altro materiale bellico. Queste industrie dovettero essere modernizzate e razionalizzate per raggiungere un livello di produzione senza precedenti, il che incoraggiò lo sviluppo di nuove tecnologie e tecniche di produzione. Durante la Prima guerra mondiale, ad esempio, la produzione di acciaio e di altri materiali essenziali aumentò in modo esponenziale per soddisfare le esigenze belliche. Questa maggiore capacità produttiva è stata poi riutilizzata dopo la guerra per stimolare la crescita economica. | |||
Dalla fine del XVIII secolo, con l'emergere delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche, abbiamo assistito a una grande trasformazione nella natura dei conflitti. Queste guerre del secondo tipo sono diventate guerre totali, che coinvolgono non solo gli eserciti ma l'intera società. In queste guerre totali, la mobilitazione della popolazione diventa essenziale. Gli Stati istituiscono sistemi di coscrizione per reclutare un gran numero di soldati, trasformando la guerra in un vero e proprio sforzo nazionale. Le risorse economiche, industriali e tecnologiche di ogni Paese furono mobilitate per sostenere lo sforzo bellico. Ciò significa che l'intera società fu interessata dalla guerra. I civili erano direttamente coinvolti, sia come combattenti al fronte, sia come lavoratori nelle fabbriche di armamenti, sia come supporto logistico nelle infrastrutture di comunicazione, di trasporto e sanitarie. Anche i civili subiscono le conseguenze della guerra, tra cui la distruzione materiale, lo sfollamento forzato, le privazioni e la perdita di vite umane. Queste guerre totali influenzano profondamente la vita delle società coinvolte. Hanno rafforzato il legame tra lo Stato e la popolazione, trasformando la guerra in un impegno collettivo e nazionale. La distinzione tra fronte e retrovie si è attenuata e la guerra è diventata una realtà onnipresente nella vita quotidiana dei civili. | |||
Tra il 1815 e il 1914, l'Europa visse un periodo di relativa stabilità e pace, spesso definito "pace dei cento anni" o "lungo XIX secolo". Durante questo periodo, le principali potenze europee evitarono i grandi conflitti tra loro, il che portò a una certa stabilità politica, economica e sociale nel continente. Tuttavia, questo periodo di relativa pace non fu privo di tensioni e conflitti più limitati. Durante questo periodo sono scoppiate guerre e crisi regionali, conflitti coloniali e lotte per l'indipendenza nazionale. Inoltre, le rivalità e le tensioni tra le potenze europee si sono sviluppate nel tempo, in particolare a causa dell'imperialismo, delle rivalità coloniali e delle tensioni nazionaliste. L'apparente stabilità di questo periodo fu infranta dallo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914. Questo grande conflitto fu un punto di svolta nella storia e segnò la fine della pace relativa in Europa. Seguì una serie di grandi sconvolgimenti politici, sociali ed economici che segnarono il XX secolo. | |||
Dopo le guerre napoleoniche, nel 1814-1815 si tenne il Congresso di Vienna. Il Congresso riunì le principali potenze europee dell'epoca con l'obiettivo di riorganizzare l'Europa dopo gli sconvolgimenti causati dalle guerre napoleoniche e di prevenire nuovi conflitti. Il Congresso di Vienna stabilì il principio del "Concerto delle Nazioni", noto anche come "Sistema di Vienna". Si trattava di un sistema di diplomazia multilaterale in cui le principali potenze europee si incontravano regolarmente per discutere di questioni internazionali e mantenere la pace in Europa. L'idea era quella di creare un equilibrio di potere ed evitare le guerre distruttive che avevano caratterizzato il periodo napoleonico. Il Concerto delle Nazioni fu un tentativo di stabilire un sistema di relazioni internazionali basato sulla cooperazione, la consultazione e la diplomazia. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, il sistema mostrò i suoi limiti nel tempo, in particolare quando si trattò di affrontare i cambiamenti politici e le aspirazioni nazionaliste emerse nel corso del XIX secolo. Il periodo successivo al Congresso di Vienna fu segnato da tensioni e conflitti, tra cui l'ascesa del nazionalismo, le rivoluzioni del 1848 e le rivalità coloniali. Questi sviluppi portarono alla fine della "pace dei cento anni" e allo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914. | |||
Il Concerto delle Nazioni, noto anche come Sistema Metternich, fu istituito dopo la caduta di Napoleone nel 1815 al Congresso di Vienna. I vincitori della guerra contro Napoleone - Gran Bretagna, Austria, Prussia e Russia, le principali potenze dell'epoca - definirono nuove regole per la gestione delle relazioni internazionali. Queste regole stabilirono un sistema concertato per la gestione delle controversie tra gli Stati, basato sull'equilibrio dei poteri, sul rispetto dei trattati e sulla non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. L'idea era quella di evitare il ripetersi delle devastanti guerre che avevano caratterizzato l'epoca napoleonica. Di conseguenza, pur non essendo un vero e proprio sistema di sicurezza collettiva, il Concerto delle Nazioni favorì la cooperazione tra le potenze e contribuì a mantenere la stabilità in Europa per gran parte del XIX secolo. In effetti, il sistema funzionò relativamente bene per un certo periodo, con una notevole riduzione del numero di guerre importanti in Europa. Tuttavia, è stato anche criticato per aver sostenuto e rafforzato lo status quo, impedendo così il progresso sociale e politico. Inoltre, alla fine non è riuscito a prevenire lo scoppio di guerre mondiali nel XX secolo. Il Concerto delle Nazioni ha rappresentato una pietra miliare nella storia delle relazioni internazionali, gettando le basi della moderna diplomazia multilaterale e fungendo da precursore di organizzazioni internazionali come la Società delle Nazioni e le Nazioni Unite. | |||
== L'era post-1945 == | |||
Sebbene durante la Guerra Fredda vi siano state notevoli tensioni, in particolare tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, dal 1945 l'Europa ha goduto di un periodo di pace senza precedenti. Questo periodo, spesso definito "Pax Europaea" o pace europea, ha segnato il più lungo periodo di pace sul continente nella storia moderna. Dopo le guerre napoleoniche, l'Europa ha goduto di un periodo relativamente pacifico, noto come la Pace dei Cento Anni, tra il 1815 e il 1914, nonostante alcuni conflitti di rilievo come la guerra di Crimea e la guerra franco-prussiana. Questo periodo è stato caratterizzato dalla stabilità generale garantita dal Concerto delle Nazioni, che ha promosso l'equilibrio di potere e la risoluzione diplomatica dei conflitti. Allo stesso modo, nonostante le tensioni della guerra fredda e la minaccia di distruzione nucleare dopo il 1945, l'Europa ha goduto di un periodo di pace straordinariamente lungo. Questa "Pax Europaea" può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui la deterrenza nucleare, la creazione e l'espansione dell'Unione Europea, la presenza delle forze della NATO e del Patto di Varsavia e i consistenti aiuti economici forniti dal Piano Marshall. Questi elementi hanno contribuito ad aumentare l'interdipendenza tra le nazioni europee, rendendo il conflitto diretto non solo indesiderabile, ma sempre più impensabile. Di conseguenza, nonostante le sfide e le tensioni del dopoguerra, l'Europa è riuscita a mantenere una pace duratura e significativa. | |||
[[File:United Nations General Assembly Hall (3).jpg|thumb|left|267px| | Fino ai recenti conflitti in Ucraina, la pace in Europa è stata ampiamente mantenuta. Il conflitto in Ucraina, iniziato nel 2014, rappresenta una rottura significativa di questa pace. Tuttavia, è importante notare che questo conflitto è più localizzato e non è sfociato in una guerra su larga scala che ha coinvolto molti Paesi europei, come è avvenuto durante le due guerre mondiali. La crisi ucraina ha messo in luce alcune delle tensioni che ancora esistono in Europa, in particolare tra la Russia e le nazioni occidentali. La situazione in Ucraina è complessa e ha sollevato molte sfide per la stabilità e la sicurezza in Europa. Ha messo in discussione l'efficacia di alcune strutture e accordi che hanno contribuito a mantenere la pace in Europa per decenni. Tuttavia, anche con il conflitto in Ucraina, il periodo successivo al 1945 rimane uno dei più pacifici della storia europea, soprattutto se confrontato con i secoli precedenti, segnati da guerre frequenti e devastanti.[[File:United Nations General Assembly Hall (3).jpg|thumb|left|267px|Sala dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.]] | ||
Mentre l'Europa e altre parti del mondo sviluppato hanno goduto di un periodo di relativa pace dopo la Seconda guerra mondiale, molti altri luoghi hanno subito violenti conflitti durante la Guerra fredda e oltre. Questo periodo è stato caratterizzato da una serie di guerre per procura, in cui le grandi potenze hanno sostenuto le parti opposte in conflitti locali senza impegnarsi direttamente in una guerra. Esempi di queste guerre per procura sono la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, la guerra civile in Angola e le guerre in Afghanistan, tra le altre. Questi conflitti hanno spesso causato pesanti perdite tra i civili e hanno avuto un impatto a lungo termine sulla stabilità e sullo sviluppo delle regioni interessate. È un importante promemoria del fatto che, sebbene la "Pax Europaea" e la pace tra le grandi potenze siano importanti, non rappresentano l'intera storia della guerra e della pace nel XX secolo e oltre. I conflitti continuano a interessare molte parti del mondo, spesso con conseguenze devastanti per le popolazioni locali. | |||
Storicamente, i conflitti più importanti erano spesso il risultato di guerre dirette tra grandi potenze. Tuttavia, dalla fine della Seconda guerra mondiale nel 1945, queste potenze hanno in gran parte evitato di entrare in conflitto diretto tra loro. Questa transizione può essere attribuita a diversi fattori. Lo sviluppo e la proliferazione delle armi nucleari hanno creato un deterrente reciproco, dove il costo di un conflitto diretto sarebbe la distruzione totale. Inoltre, la crescente interdipendenza economica ha reso la guerra meno attraente per le grandi potenze, in quanto avrebbe interrotto il commercio mondiale e i mercati finanziari. Inoltre, la creazione di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite ha fornito meccanismi per la risoluzione pacifica delle controversie. Infine, anche la diffusione della democrazia può aver contribuito a questa tendenza, poiché le democrazie tendono a evitare di entrare in guerra tra loro, un concetto noto come "pace democratica". | |||
Dalla fine della Prima guerra mondiale, si è registrata una crescente tendenza a considerare la guerra come illegale o, comunque, da evitare. Si tratta di un cambiamento importante nel modo in cui la guerra è stata percepita storicamente. La creazione della Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale è stato un primo passo verso questa idea. Sebbene la Società delle Nazioni non sia riuscita a prevenire la Seconda guerra mondiale, il suo successore, le Nazioni Unite, è stato fondato su principi simili di risoluzione pacifica delle controversie e di prevenzione della guerra. Inoltre, l'evoluzione del diritto internazionale umanitario e le Convenzioni di Ginevra hanno stabilito alcune regole sulla condotta della guerra, con l'idea di ridurne al minimo gli effetti dannosi. Più recentemente, è stata sviluppata l'idea della "responsabilità di proteggere" (R2P) per giustificare l'intervento internazionale in situazioni in cui uno Stato non è in grado o non vuole proteggere la propria popolazione. | |||
Il filosofo Immanuel Kant abbozzò un piano per la "pace perpetua" in un trattato pubblicato nel 1795. Kant formulò l'idea che le democrazie liberali hanno meno probabilità di entrare in guerra tra loro, una teoria che fu ripresa da altri pensatori politici e divenne nota come "pace democratica". Secondo questa teoria, le democrazie sono meno inclini alla guerra perché i loro governi sono responsabili nei confronti dei cittadini, che sostengono i costi umani ed economici dei conflitti. Kant promosse anche l'idea di una federazione di nazioni libere, una sorta di precursore delle odierne organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. L'obiettivo di questa "federazione di pace" sarebbe stato quello di risolvere i conflitti attraverso la negoziazione e il diritto internazionale piuttosto che con la guerra. | |||
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, le nazioni del mondo hanno cercato di creare strutture per mantenere la pace e prevenire futuri conflitti. Questo ha portato alla creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che mira a facilitare la cooperazione internazionale e a prevenire i conflitti. L'ONU è un esempio del cosiddetto sistema di sicurezza collettiva. In questo sistema, gli Stati si impegnano a cooperare per garantire la sicurezza di tutti. Se uno Stato attacca un altro, ci si aspetta che gli altri Stati si schierino con lo Stato attaccato e intervengano per scoraggiare o fermare l'aggressore. Oltre alle Nazioni Unite, sono state istituite altre organizzazioni e trattati per promuovere la sicurezza collettiva, come l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e l'Unione Europea. Questi meccanismi hanno contribuito a prevenire i principali conflitti tra le grandi potenze dal 1945. Tuttavia, hanno anche i loro limiti e non sono sempre efficaci nel prevenire i conflitti, come dimostrano i numerosi conflitti regionali e le guerre civili che hanno avuto luogo dal 1945. | |||
La | La Carta delle Nazioni Unite, istituita nel 1945, stabilisce le norme essenziali per regolare l'uso della forza tra gli Stati. In generale, vieta l'uso della forza nelle relazioni internazionali, tranne che in due circostanze specifiche. In primo luogo, l'articolo 51 della Carta sancisce il diritto intrinseco degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva in caso di attacco armato. Ciò significa che uno Stato ha il diritto di difendersi se viene attaccato, o se viene attaccato un altro Stato con cui ha concluso un accordo di difesa. In secondo luogo, il Capitolo VII della Carta consente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare misure per preservare o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. Questo può includere l'uso della forza ed è stato alla base dell'autorizzazione di diversi interventi militari, come la Guerra del Golfo del 1991. Sebbene questi principi siano stati concepiti per limitare l'uso della forza e incoraggiare la risoluzione pacifica dei conflitti, sono stati anche controversi, soprattutto per quanto riguarda la loro interpretazione e applicazione in situazioni concrete. | ||
Dal 1945, c'è stata una tendenza crescente verso la regolamentazione e la proibizione della guerra. La Carta delle Nazioni Unite ha rappresentato un'importante pietra miliare in questo sviluppo, vietando l'uso della forza nelle relazioni internazionali se non per autodifesa o su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Oltre alla Carta delle Nazioni Unite, anche altri trattati e convenzioni hanno contribuito a questa tendenza. Ad esempio, le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi hanno stabilito regole severe per la condotta della guerra, con l'obiettivo di limitare le sofferenze umane. Allo stesso modo, i trattati sul controllo degli armamenti, come il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, hanno cercato di limitare la proliferazione delle armi più distruttive. Allo stesso tempo, si è assistito a un crescente movimento verso la risoluzione pacifica dei conflitti. I meccanismi di risoluzione pacifica delle controversie, come la mediazione, l'arbitrato e la composizione giudiziaria, sono sempre più utilizzati per risolvere le controversie internazionali. Tuttavia, sebbene questi sforzi abbiano contribuito a limitare e regolare la guerra, non sono riusciti a eliminarla completamente. I conflitti continuano a verificarsi in molte parti del mondo, sottolineando la sfida persistente di raggiungere una pace duratura e universale. | |||
= | = Le trasformazioni contemporanee della guerra = | ||
La | La fine della Guerra Fredda nel 1989, segnata dalla caduta del Muro di Berlino, ha rappresentato un importante punto di svolta nella storia della guerra moderna. Durante questo periodo di tensione bipolare tra Est e Ovest, il mondo era stato diviso tra le due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Sebbene queste due superpotenze non siano mai state in conflitto diretto, hanno sostenuto guerre per procura in tutto il mondo, portando a conflitti prolungati e costosi. La fine della Guerra Fredda ha cambiato le dinamiche della guerra moderna in diversi modi. In primo luogo, ha segnato la fine del bipolarismo che aveva caratterizzato la politica mondiale per quasi mezzo secolo. Di conseguenza, la natura dei conflitti è cambiata, passando dalle guerre tra Stati alle guerre civili e ai conflitti non statali. In secondo luogo, la fine della Guerra Fredda ha dato il via a una nuova ondata di ottimismo sulla possibilità di una pace mondiale duratura. Si sperava che, senza la costante tensione della Guerra Fredda, il mondo potesse compiere progressi significativi verso la risoluzione dei conflitti e la prevenzione delle guerre. Infine, la fine della Guerra Fredda ha portato anche a una serie di nuove sfide, tra cui la proliferazione delle armi nucleari, l'ascesa del terrorismo internazionale e il crescente problema degli Stati falliti. Queste sfide hanno influenzato la natura della guerra moderna e continuano ad essere questioni importanti per la sicurezza globale. | ||
La | La fine della Guerra Fredda nel 1989 ha segnato una svolta significativa nella storia mondiale, con profonde implicazioni per la natura della guerra e dello Stato moderno. Fino ad allora, l'evoluzione della guerra moderna era strettamente legata all'emergere e al consolidarsi dello Stato nazionale moderno. Questo Stato era caratterizzato da una sovranità territoriale chiaramente definita, dal monopolio della violenza legittima e da una struttura di governo centralizzata. Le guerre erano principalmente scontri tra questi Stati nazionali. Tuttavia, dopo il 1989, molti ricercatori hanno osservato un cambiamento significativo in questa dinamica. Le guerre sono diventate meno frequentemente scontri diretti tra Stati nazionali e più spesso conflitti interni, guerre civili o guerre che coinvolgono attori non statali come gruppi terroristici o milizie. Inoltre, la nozione stessa di sovranità statale ha iniziato a essere messa in discussione. Gli interventi umanitari, le operazioni di mantenimento della pace e la dottrina della "responsabilità di proteggere" hanno messo in discussione l'idea tradizionale di non interferenza negli affari interni di uno Stato. Di conseguenza, si può affermare che la fine della Guerra Fredda ha inaugurato una nuova era in cui il rapporto tra guerra e Stato sta cambiando. I contorni precisi di questa nuova era sono ancora oggetto di dibattito tra studiosi e analisti. | ||
Dalla fine della Guerra Fredda, molti ricercatori ed esperti militari hanno suggerito che la guerra ha subito una significativa trasformazione. Queste trasformazioni sono state attribuite a una serie di fattori, tra cui gli sviluppi della tecnologia militare, la globalizzazione, i cambiamenti nella natura dello Stato e il relativo declino della guerra interstatale. Le guerre di oggi sono spesso descritte come "postmoderne", per riflettere la loro differenza rispetto alle guerre tradizionali dei secoli precedenti. Le guerre postmoderne sono spesso caratterizzate dalla loro complessità, in quanto coinvolgono una moltitudine di attori statali e non statali, e talvolta anche imprese private e organizzazioni non governative. Spesso si svolgono in ambienti urbani, piuttosto che su campi di battaglia tradizionali, e possono coinvolgere attori asimmetrici, come gruppi terroristici o cyber-attaccanti. Queste guerre postmoderne hanno messo in discussione anche le norme e le regole tradizionali della guerra. Ad esempio, come si possono applicare i principi del diritto internazionale umanitario, concepiti per le guerre tra Stati, a conflitti che coinvolgono attori non statali o attacchi informatici? Questo non significa che le vecchie forme di guerra siano completamente scomparse. Ci sono ancora conflitti che assomigliano alle guerre tradizionali. Tuttavia, queste nuove forme di conflitto hanno aggiunto uno strato di complessità all'arte della guerra, richiedendo una riflessione costante e un adattamento alle nuove realtà del XXI secolo. | |||
== | == Il nuovo (dis)ordine mondiale == | ||
La | La caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 hanno segnato la fine della Guerra Fredda e del sistema bipolare che aveva dominato la politica mondiale per quasi mezzo secolo. Durante questo periodo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, in quanto superpotenze, avevano creato due blocchi distinti di influenza globale. Nonostante le costanti tensioni e le numerose crisi, il conflitto aperto tra queste due potenze è stato evitato, soprattutto grazie alla minaccia della distruzione reciproca assicurata (MAD) in caso di guerra nucleare. Tuttavia, la fine della Guerra Fredda non ha portato a un "nuovo ordine mondiale" di pace e stabilità, come alcuni avevano sperato. Al contrario, sono emerse nuove sfide e conflitti. Stati falliti, guerre civili, terrorismo internazionale e proliferazione delle armi di distruzione di massa sono diventati problemi importanti. Anche la natura dei conflitti è cambiata, con un aumento della guerra asimmetrica e dei conflitti che coinvolgono attori non statali. | ||
La | La fine della Guerra Fredda ha inaugurato una nuova era nella politica mondiale, caratterizzata da un certo ottimismo. Molti esperti e politici speravano che la fine della rivalità tra superpotenze avrebbe portato a un'era di maggiore pace e cooperazione internazionale. Il filosofo politico Francis Fukuyama ha addirittura descritto questo periodo come "la fine della storia", suggerendo che la democrazia liberale era finalmente emersa come sistema di governo indiscusso e definitivo. Con la scomparsa dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti si ritrovarono ad essere l'unica superpotenza mondiale, inaugurando quella che alcuni hanno definito l'"iperpotenza" americana. Molti ritenevano che questa nuova era unipolare avrebbe portato maggiore stabilità e pace nel mondo. Allo stesso tempo, la fine della rivalità tra le due superpotenze ha permesso alle Nazioni Unite di svolgere un ruolo più efficace nella prevenzione dei conflitti e nella promozione della pace. L'ostruzione sistematica da parte di uno dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che aveva spesso paralizzato l'organizzazione durante la Guerra Fredda, è stata in gran parte eliminata. Ciò ha portato a un aumento significativo delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite negli anni Novanta. | ||
Con la fine della Guerra Fredda, gli anni '90 hanno visto un aumento significativo delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Le forze di pace delle Nazioni Unite sono state dispiegate nei conflitti di tutto il mondo, con l'obiettivo di mantenere o ripristinare la pace e promuovere la riconciliazione e la ricostruzione. L'idea era che queste operazioni di mantenimento della pace potessero aiutare a prevenire l'escalation dei conflitti, a proteggere i civili, a facilitare la fornitura di aiuti umanitari e a sostenere il processo di pace. In altre parole, queste missioni avrebbero dovuto aiutare a "raccogliere il dividendo della pace" dopo la fine della Guerra Fredda. | |||
La | La fine della Guerra Fredda e l'emergere di un nuovo sistema internazionale sono stati accompagnati da un crescente discorso sul "disordine globale". Questo termine si riferisce all'idea che il mondo post-Guerra Fredda sia caratterizzato da una maggiore incertezza, da sfide globali complesse e interconnesse e dall'assenza di un quadro chiaro e stabile per la governance internazionale. Diversi fattori hanno contribuito a questa percezione di "disordine globale". In primo luogo, la fine del bipolarismo della Guerra Fredda ha eliminato il quadro chiaro che aveva precedentemente strutturato le relazioni internazionali. Invece di un mondo diviso tra due superpotenze, abbiamo assistito a un panorama più complesso e multipolare con molti attori importanti, tra cui non solo gli Stati nazionali, ma anche le organizzazioni internazionali, le imprese multinazionali, i gruppi non governativi e altri. In secondo luogo, il mondo post-Guerra Fredda è stato caratterizzato da una serie di sfide globali, tra cui il terrorismo transnazionale, le crisi finanziarie, i cambiamenti climatici, le pandemie, la sicurezza informatica e altri problemi che non rispettano i confini nazionali e non possono essere risolti da un singolo Paese o addirittura da un gruppo di Paesi. Infine, è cresciuta la consapevolezza dei limiti e delle contraddizioni delle istituzioni internazionali esistenti. Ad esempio, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e altre organizzazioni sono state criticate per la loro mancanza di rappresentatività, la loro inefficienza e la loro incapacità di rispondere efficacemente alle sfide globali. In questo contesto, la questione di come gestire questo "disordine globale" e costruire un sistema internazionale più equo, efficiente e resistente è diventata una questione centrale della politica mondiale. | ||
Nel suo libro molto discusso "Lo scontro delle civiltà", l'analista politico Samuel P. Huntington ha proposto un nuovo modo di guardare al mondo post-Guerra Fredda. Egli ha sostenuto che le future fonti di conflitto internazionale non riguarderanno tanto le ideologie politiche o economiche, quanto piuttosto le differenze tra le varie grandi civiltà del mondo. Secondo Huntington, il mondo potrebbe essere diviso in circa otto grandi civiltà, basate sulla religione e sulla cultura. Egli prevedeva che i maggiori conflitti del XXI secolo sarebbero stati tra queste civiltà, in particolare tra quella occidentale e quelle islamica e confuciana (quest'ultima rappresentata principalmente dalla Cina). | |||
La | La fine della guerra fredda ha segnato una transizione significativa nella natura dei conflitti. Mentre il periodo della Guerra Fredda è stato dominato dai conflitti interstatali e dalle guerre per procura tra le due superpotenze, il periodo successivo alla Guerra Fredda ha visto un aumento significativo delle guerre civili e dei conflitti interni. Questi conflitti hanno spesso coinvolto una varietà di attori non statali, come gruppi di ribelli, milizie, gruppi terroristici e bande criminali. Inoltre, sono stati spesso caratterizzati da violenze intense e prolungate, massicce violazioni dei diritti umani e gravi crisi umanitarie. Queste tendenze hanno posto serie sfide alla comunità internazionale. Da un lato, è stato più difficile gestire e risolvere questi conflitti, poiché spesso coinvolgono questioni profondamente radicate come l'identità etnica o religiosa, la governance, la disuguaglianza e l'accesso alle risorse. Inoltre, questi conflitti hanno spesso effetti destabilizzanti che trascendono i confini nazionali, come i flussi di rifugiati, la diffusione di gruppi estremisti e la destabilizzazione regionale. | ||
Storicamente, lo Stato nazionale è stato il principale attore dei conflitti armati e la maggior parte delle guerre è stata combattuta tra Stati. Tuttavia, con il crollo dell'ordine mondiale bipolare alla fine della Guerra Fredda, la natura della guerra ha iniziato a cambiare. La guerra civile, un tempo un tipo di conflitto relativamente raro, è diventata sempre più comune. Questi conflitti interni spesso coinvolgono una varietà di attori non statali, come gruppi di ribelli, milizie, gruppi terroristici e bande criminali. L'aumento delle guerre civili ha posto nuove sfide alla gestione dei conflitti e alla sicurezza internazionale. A differenza delle guerre tra Stati, le guerre civili sono spesso più complesse e difficili da risolvere. Possono coinvolgere problemi profondamente radicati come le divisioni etniche o religiose, la governance, la disuguaglianza e l'accesso alle risorse. Inoltre, questi conflitti hanno spesso conseguenze destabilizzanti che trascendono i confini nazionali, come i flussi di rifugiati, la diffusione di gruppi estremisti e la destabilizzazione regionale. | |||
Dalla fine della Guerra Fredda nel 1989, la natura dei conflitti è cambiata in modo significativo. Mentre un tempo le guerre tra Stati erano la forma di conflitto dominante, l'era post-Guerra Fredda ha visto un aumento delle guerre civili e dei conflitti interni. Queste guerre civili hanno spesso coinvolto una serie di attori non statali, tra cui gruppi armati, milizie, gruppi terroristici e bande. Di conseguenza, spesso si ha la percezione che lo Stato non sia più l'attore principale nei conflitti armati. Questo rappresenta una sfida significativa per il sistema internazionale, che è stato costruito sul principio della sovranità statale e progettato per gestire i conflitti tra Stati. Le guerre civili sono spesso più complesse, più difficili da risolvere e con maggiori probabilità di causare crisi umanitarie rispetto alle guerre tra Stati. | |||
L' | L'era post-Guerra Fredda è stata segnata dall'emergere e dalla proliferazione di una varietà di attori non statali che sono diventati protagonisti di molti conflitti in tutto il mondo. Gruppi terroristici, milizie e organizzazioni criminali come mafie e bande sono diventati i principali protagonisti della violenza e dei conflitti. Questi attori sono spesso riusciti a sfruttare le debolezze dello Stato, in particolare nei Paesi in cui lo Stato è debole o fragile, dove non ha la capacità di controllare efficacemente il territorio o di fornire servizi di base alla popolazione. Spesso hanno usato la violenza per raggiungere i loro obiettivi, sia per minare l'autorità dello Stato, sia per controllare il territorio o le risorse, sia per promuovere una causa politica o ideologica. Ciò ha avuto molte implicazioni per la sicurezza internazionale. Da un lato, ha reso i conflitti più complessi e più difficili da risolvere. Dall'altro, ha portato a un aumento della violenza e dell'instabilità, con conseguenze devastanti per le popolazioni civili. | ||
Il concetto di sovranità, che per lungo tempo è stato fondamentale per strutturare il sistema interstatale e regolare la violenza, è stato messo seriamente in discussione nel contesto post-Guerra Fredda. L'ascesa di attori non statali violenti, come gruppi terroristici e organizzazioni criminali, è spesso avvenuta in aree in cui l'autorità statale è debole o assente, evidenziando i limiti della sovranità come mezzo per mantenere l'ordine e la sicurezza. Inoltre, la proliferazione di conflitti interni e guerre civili ha sollevato importanti questioni sulla responsabilità dello Stato di proteggere la propria popolazione e sul diritto della comunità internazionale di intervenire negli affari di uno Stato sovrano per prevenire o porre fine a gravi violazioni dei diritti umani. Queste sfide hanno portato a importanti discussioni e dibattiti sulla natura e sul significato della sovranità nel XXI secolo. Tra i concetti emersi da questi dibattiti c'è il principio della "responsabilità di proteggere", che afferma che la sovranità non è solo un diritto, ma anche una responsabilità, e che se uno Stato non è in grado o non vuole proteggere la sua popolazione da crimini di massa, la comunità internazionale ha la responsabilità di intervenire. | |||
Gli "Stati falliti" sono Stati che non sono più in grado di mantenere l'ordine e la sicurezza sul loro territorio, di fornire servizi essenziali alla popolazione o di rappresentare il potere legittimo agli occhi dei cittadini. Questi Stati, sebbene siano ancora riconosciuti come sovrani sulla scena internazionale, devono spesso affrontare la perdita di controllo su una parte significativa del loro territorio, insurrezioni o violenti conflitti interni, oltre a corruzione e cattiva governance. Dagli anni Novanta, un gran numero di conflitti, soprattutto in Africa ma anche in altre parti del mondo, ha avuto luogo in questi Stati falliti. Questi conflitti sono spesso caratterizzati da violenze massicce contro i civili, diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e spesso hanno un impatto destabilizzante sui Paesi e le regioni circostanti. | |||
L' | L'aumento dei conflitti interni e delle guerre civili a partire dagli anni Novanta ha indotto a rivalutare il concetto tradizionale di sovranità nel discorso internazionale. Mentre in precedenza la sovranità era vista come una garanzia di ordine e stabilità, che proteggeva gli Stati da interferenze esterne, ha iniziato a essere percepita in modo più problematico. In questo contesto, la sovranità è stata talvolta vista come un ostacolo all'intervento internazionale in situazioni in cui le popolazioni erano minacciate da violenze di massa, genocidi o crimini contro l'umanità. Ciò ha dato origine a dibattiti sulla "responsabilità di proteggere" e sulla questione di quando e come la comunità internazionale debba intervenire per proteggere le popolazioni civili, anche in violazione del tradizionale principio di non interferenza negli affari interni di uno Stato sovrano. Inoltre, la sovranità è stata messa in discussione anche come fonte di legittimità, quando regimi autoritari o dispotici l'hanno usata per giustificare le violazioni dei diritti umani o per resistere alle richieste di riforme democratiche. Pertanto, sebbene la sovranità rimanga un principio fondamentale del sistema internazionale, il suo significato e la sua applicazione sono diventati sempre più contestati nel contesto contemporaneo. | ||
== L' | == L'emergere di nuove guerre == | ||
Mary Kaldor, | Mary Kaldor, specialista in relazioni internazionali e teoria della guerra, ha introdotto l'idea di "nuove guerre" nel suo libro New and Old Wars: Organised violence in a global era (1999). L'autrice sostiene che i conflitti emersi dopo la fine della Guerra Fredda hanno caratteristiche diverse dalle tradizionali "vecchie guerre", soprattutto a causa dell'impatto della globalizzazione e dei cambiamenti politici, economici e tecnologici. | ||
Le "nuove guerre", secondo Kaldor, sono tipicamente caratterizzate da: | |||
* La | * La degradazione della guerra in violenza diffusa e spesso decentralizzata, che coinvolge una varietà di attori non statali, come milizie, gruppi terroristici, bande criminali e signori della guerra. | ||
* | * L'attenzione all'identità piuttosto che all'ideologia come motore del conflitto, spesso utilizzando la retorica etnica, religiosa o nazionalista per mobilitare il sostegno e giustificare la violenza. | ||
* | * La crescente importanza dei crimini contro l'umanità e degli attacchi ai civili, piuttosto che dei combattimenti convenzionali tra forze armate. | ||
* | * Il crescente coinvolgimento di attori internazionali e transnazionali, sia in termini di finanziamenti e sostegno alle parti in conflitto, sia in termini di sforzi per risolvere i conflitti o mitigarne l'impatto umanitario. | ||
Queste "nuove guerre" presentano sfide diverse in termini di prevenzione, risoluzione e ricostruzione post-conflitto e richiedono strategie e approcci diversi da quelli efficaci nelle "vecchie guerre". | |||
Nella sua analisi delle nuove guerre, Mary Kaldor sostiene che l'era post-1989 è caratterizzata da tre elementi chiave. Il primo è la globalizzazione. La fine del XX secolo è stata caratterizzata da un'accelerazione della globalizzazione, che ha trasformato profondamente le relazioni economiche, politiche e culturali a livello globale. Questa globalizzazione ha ripercussioni dirette sulla natura dei conflitti. Il finanziamento transnazionale dei gruppi armati, la diffusione di ideologie estremiste attraverso i media digitali e il coinvolgimento delle forze internazionali nelle operazioni di mantenimento della pace sono tutti fenomeni che ne sono derivati. In secondo luogo, l'era post-1989 è segnata da una grande trasformazione delle strutture politiche. Con la fine della Guerra Fredda, molti regimi comunisti e autoritari sono crollati, dando vita a nuove democrazie. Allo stesso tempo, sono aumentati gli interventi internazionali negli affari interni degli Stati, spesso giustificati dalla necessità di proteggere i diritti umani o di prevenire un genocidio. Infine, Kaldor sottolinea un cambiamento fondamentale nella natura della violenza. I conflitti sono diventati più diffusi e decentrati, coinvolgendo una moltitudine di attori non statali. Gli attacchi deliberati contro i civili, lo sfruttamento dell'identità etnica o religiosa a fini di mobilitazione e l'uso di tattiche di terrore sono diventati comuni. Secondo Kaldor, questi tre elementi interagiscono per creare un nuovo tipo di guerra, profondamente diverso dalle tradizionali guerre interstatali del passato. | |||
Secondo Mary Kaldor, l'era moderna ha visto uno spostamento dalle ideologie alle identità come principali motori di conflitto. In questo contesto, le battaglie non sono più combattute per ideali politici, ma per l'affermazione e la difesa di particolari identità, spesso etniche. Questo sviluppo segna un passo verso l'esclusione, in quanto può portare a una maggiore polarizzazione e divisione della società. A differenza di un dibattito ideologico in cui possono esserci compromessi e consenso, la difesa dell'identità può creare una dinamica "noi contro loro", che può essere estremamente distruttiva. | |||
Mary Kaldor | Mary Kaldor sottolinea questo cambiamento cruciale nei motivi di conflitto. Quando le lotte erano incentrate sulle ideologie, come il socialismo internazionale, erano più inclusive. L'obiettivo era convincere e radunare il maggior numero possibile di persone a una causa, a un sistema di pensiero o a una visione del mondo. Al contrario, quando i conflitti si basano sull'identità, in particolare sull'identità etnica, tendono a essere più esclusivi. La lotta per una specifica identità etnica delimita un particolare gruppo come "noi", che inevitabilmente implica un "loro" distinto e diverso. Questo crea una dinamica di esclusione che può essere profondamente divisiva e portare alla violenza intercomunitaria. Si tratta di un cambiamento profondo rispetto ai conflitti ideologici del passato. | ||
D'altra parte, secondo Kaldor, la guerra non è più per il popolo, ma contro il popolo, il che significa che ci troviamo sempre più spesso di fronte ad attori che non rappresentano lo Stato e che non aspirano nemmeno ad esserlo. In precedenza, i conflitti erano generalmente combattuti dagli Stati o da attori che aspiravano a controllare lo Stato. La guerra veniva quindi combattuta "per il popolo", nel senso che l'obiettivo era ottenere il controllo del governo per servire, teoricamente, gli interessi del popolo. Nel contesto odierno, l'autrice sostiene che la guerra è spesso combattuta "contro il popolo". Ciò significa che attori non statali come gruppi terroristici, milizie o bande sono sempre più coinvolti nei conflitti. Questi gruppi non cercano necessariamente di controllare lo Stato e possono di fatto impegnarsi in atti di violenza diretti principalmente contro le popolazioni civili. Di conseguenza, la natura della guerra si è evoluta fino a diventare meno una lotta per il controllo dello Stato e più una fonte di violenza contro la popolazione. | |||
È sempre più una guerra di banditi, in cui l'obiettivo è estrarre le risorse naturali dei Paesi per l'arricchimento personale di alcuni gruppi. Mary Kaldor descrive questa trasformazione come una forma di "guerra dei banditi". In questo contesto, la guerra non è condotta per raggiungere obiettivi politici tradizionali, come il controllo dello Stato o la difesa di un'ideologia, ma piuttosto per l'arricchimento personale o di gruppo. Questa nuova forma di conflitto è spesso caratterizzata dall'estrazione e dallo sfruttamento delle risorse naturali nelle regioni in conflitto. Queste "guerre dei banditi" possono avere conseguenze disastrose per le popolazioni locali, non solo per la violenza diretta che comportano, ma anche per la destabilizzazione economica e sociale che generano. Spesso, le risorse che potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo economico e sociale vengono invece dirottate verso interessi o gruppi privati, il che può esacerbare la povertà e le disuguaglianze. | |||
L' | L'era post-Guerra Fredda ha visto l'emergere di un'economia di guerra globale, con attori non statali come organizzazioni criminali, gruppi terroristici e milizie private che giocano un ruolo sempre più importante. Questi gruppi spesso si affidano a reti transnazionali per finanziare le loro operazioni, attraverso il traffico di droga, il commercio illegale di armi, il contrabbando di merci e altre forme di criminalità organizzata. Questa economia di guerra ha l'effetto di prolungare i conflitti, fornendo ai gruppi armati un mezzo per finanziare le loro attività senza bisogno del sostegno statale o popolare. Allo stesso tempo, contribuisce all'instabilità regionale, poiché i profitti di queste attività illegali sono spesso utilizzati per finanziare altre forme di violenza e disordine. Inoltre, queste reti transnazionali rendono più difficile il controllo e la risoluzione dei conflitti da parte delle autorità statali e delle organizzazioni internazionali. Spesso operano al di fuori dei quadri giuridici tradizionali e possono diffondersi in diversi Paesi o regioni, complicando gli sforzi per combatterle. Infine, il coinvolgimento di attori non statali nei conflitti può avere effetti destabilizzanti sugli Stati, minando la loro autorità e la capacità di mantenere l'ordine e la sicurezza. Ciò può a sua volta aggravare le tensioni e i conflitti, creando un circolo vizioso di violenza e instabilità.[[File:Death of Pablo Escobar.jpg|thumb|right|Membri del blocco di ricerca del colonnello Hugo Martínez festeggiano davanti al corpo di Pablo Escobar il 2 dicembre 1993. La sua morte pose fine a quindici mesi di ricerche costate centinaia di milioni di dollari e che coinvolsero il coordinamento tra il Comando congiunto per le operazioni speciali degli Stati Uniti, la Drug Enforcement Administration, la polizia colombiana e il gruppo di vigilantes Los Pepes.]] | ||
L' | L'approccio di Mary Kaldor alla guerra può essere visto come depoliticizzante. L'autrice sostiene che i conflitti contemporanei sono motivati principalmente da fattori etnici, religiosi o identitari piuttosto che da ideologie politiche. Questo segna una rottura con le guerre del passato, spesso combattute in nome di un'ideologia politica, come il comunismo o il fascismo. In questa prospettiva, la guerra non è più una continuazione della politica con altri mezzi, come diceva il teorico militare Carl von Clausewitz, ma piuttosto un atto di violenza motivato da differenze di identità. Ciò suggerisce che le soluzioni tradizionali, come i negoziati politici o gli accordi di pace, potrebbero non essere sufficientemente efficaci per risolvere questi conflitti. | ||
La | La visione tradizionale della guerra, descritta da Carl von Clausewitz, la vede come "la continuazione della politica con altri mezzi". Da questa prospettiva, la guerra è vista come uno strumento che gli Stati utilizzano per raggiungere specifici obiettivi politici. Tuttavia, secondo Mary Kaldor e altri studiosi simili, questa dinamica è cambiata. Essi sostengono che nei conflitti contemporanei, gli obiettivi politici tradizionali sono spesso messi in ombra da altre motivazioni, come l'identità etnica o religiosa, o il desiderio di accedere a risorse economiche. In questi casi, la guerra non è più al servizio della politica, ma sembra piuttosto essere motivata da interessi economici o identitari. | ||
Ci troviamo di fronte a Stati emersi dalla decolonizzazione, soprattutto nelle regioni meridionali, che hanno subito difficili processi di nation-building. Spesso questi Stati non hanno ricevuto gli strumenti necessari per costruire una struttura solida e duratura. Di conseguenza, sono diventati fragili e instabili, una situazione che favorisce l'emergere di conflitti e violenze. Quando questi Stati iniziano a disintegrarsi, lasciano spazio a un certo grado di caos in cui i gruppi etnici possono trovarsi in conflitto tra loro. Allo stesso tempo, banditi e altri attori non statali approfittano di questa instabilità per promuovere i propri interessi. L'assenza di un'autorità statale forte ed efficace contribuisce a perpetuare questo disordine e impedisce l'instaurazione di una pace duratura. | |||
La | La prospettiva avanzata da Mary Kaldor, che suggerisce la scomparsa del conflitto politico a favore di una forma di disordine globale, ha avuto un impatto significativo sulla nostra comprensione delle trasformazioni belliche contemporanee. Secondo questa visione, gli Stati deboli o in crisi sarebbero incapaci di garantire la stabilità sul loro territorio, aprendo così la porta a tutta una serie di minacce e pericoli. In assenza di una struttura e di un controllo statali, può emergere il caos, generando spesso conflitti etnici, attività criminali e accesso illimitato alle risorse naturali da parte di vari gruppi non statali. È in questo contesto che assistiamo a un aumento delle guerre civili e dei conflitti interni, alimentati da reti transnazionali come le mafie. L'assenza di uno Stato forte e stabile porta a un panorama conflittuale complesso, in cui i tradizionali conflitti politici lasciano il posto a una moltitudine di minacce più diffuse e decentrate. Questo approccio ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare la nostra comprensione dei conflitti moderni e delle sfide alla pace e alla sicurezza globale. | ||
Il disordine che si è verificato in Medio Oriente ha suscitato molte preoccupazioni, spesso legate al concetto di Stato e al suo ruolo di entità stabilizzatrice. Quando lo Stato sembra incapace di mantenere il controllo e l'ordine, ciò può portare a una moltitudine di minacce e rischi. Nel caso del Medio Oriente, queste minacce sono diverse. Vanno dall'instabilità sociale ed economica all'interno dei Paesi, all'aumento dei conflitti settari ed etnici, al rischio di terrorismo internazionale. Questi conflitti possono anche portare a crisi umanitarie, spostamenti massicci di popolazione e problemi di rifugiati su scala globale. L'assenza di un controllo statale efficace può anche consentire ad attori non statali, come i gruppi terroristici, di acquisire influenza e potere. Ad esempio, lo Stato Islamico (EI) è riuscito a emergere e a prendere il controllo di vasti territori in Iraq e Siria sfruttando la debolezza degli Stati locali e il caos imperante. Ciò illustra chiaramente la complessità delle questioni legate all'assenza di controllo statale e all'instabilità e le sfide che esse pongono alla sicurezza internazionale. | |||
La nostra concezione del sistema internazionale è fortemente radicata nel concetto di Stato. Lo Stato è generalmente considerato l'attore principale della politica internazionale, che garantisce sicurezza, ordine e stabilità all'interno dei propri confini. Il collasso di uno Stato o la sua incapacità di esercitare efficacemente la propria autorità può avere conseguenze destabilizzanti sia per il Paese interessato sia per la comunità internazionale. Il crollo di uno Stato può portare a un vuoto di potere, creando un terreno fertile per l'emergere di gruppi armati non statali, conflitti interni e violenza diffusa. Può anche portare a una crisi umanitaria, con rifugiati in fuga dalla violenza e dalla povertà, che a sua volta può creare tensioni nei Paesi vicini e oltre. L'incapacità di uno Stato di controllare il proprio territorio può anche rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale. Può creare uno spazio in cui il terrorismo, la criminalità organizzata e altre attività illecite possono prosperare, con conseguenze potenzialmente gravi oltre i confini dello Stato interessato. Per questi motivi, il collasso degli Stati è spesso considerato una delle principali fonti di instabilità e insicurezza del sistema internazionale. È quindi fondamentale che la comunità internazionale collabori per prevenire il collasso degli Stati e per contribuire a ripristinare la stabilità quando questo si verifica. | |||
Nella storia delle relazioni internazionali, ci sono stati casi in cui le potenze straniere hanno sostenuto regimi autoritari o dittatoriali per preservare la stabilità regionale, contenere un'ideologia concorrente, ottenere accesso alle risorse o per ragioni strategiche. Tuttavia, questa pratica pone problemi etici significativi e può essere in contraddizione con i principi democratici e i diritti umani che queste potenze straniere spesso affermano di difendere. Nel contesto della politica internazionale, il sostegno a un regime autoritario può talvolta riflettere la preferenza per uno Stato che controlla saldamente il proprio Paese, anche se ciò avviene a spese dei diritti umani o della democrazia. Questa tendenza deriva spesso da una preoccupazione per la stabilità regionale e la sicurezza internazionale. L'idea è che, sebbene questi regimi possano essere repressivi e antidemocratici, possano anche fornire un certo grado di stabilità e prevedibilità. Possono prevenire il caos o la violenza che potrebbero altrimenti emergere in assenza di un forte controllo statale e possono anche fungere da contrappeso ad altre forze regionali o internazionali percepite come una minaccia. | |||
Lo Stato nazionale rimane una struttura fondamentale per organizzare e comprendere le nostre società e il mondo in cui viviamo. È attraverso lo Stato che generalmente definiamo la nostra identità nazionale, è lo Stato che rappresenta i cittadini sulla scena internazionale ed è attraverso gli Stati che più spesso strutturiamo le nostre interazioni e relazioni internazionali. Lo Stato nazionale è anche uno strumento fondamentale per mantenere l'ordine pubblico, garantire i diritti e le libertà dei cittadini, fornire servizi pubblici essenziali e assicurare la sicurezza nazionale. Rappresenta quindi un grado di stabilità e prevedibilità in un mondo altrimenti complesso e in costante cambiamento. | |||
Il concetto di "guerra postmoderna" si riferisce a un'evoluzione fondamentale dell'arte della guerra, che si allontana dai paradigmi tradizionali legati agli Stati nazionali in conflitto per ragioni politiche o territoriali. Il cuore della guerra postmoderna è la depoliticizzazione del conflitto, in cui le motivazioni politiche o il controllo del territorio sono sostituiti da una moltitudine di fattori come le dispute etniche, religiose, economiche o ambientali. Questa nuova era della guerra è caratterizzata anche dalla deterritorializzazione, in cui i conflitti non sono più limitati a regioni specifiche, ma possono diventare transnazionali o globali, come nel caso del terrorismo internazionale o dei conflitti informatici. Uno degli aspetti più inquietanti della guerra postmoderna è la privatizzazione della violenza, con attori non statali come gruppi terroristici, milizie private e organizzazioni criminali che giocano un ruolo sempre più importante. Allo stesso tempo, si è intensificato l'impatto dei conflitti sui civili, con effetti diretti devastanti, come la violenza, e indiretti, come lo spostamento della popolazione, la carestia e le malattie. | |||
Sebbene le democrazie abbiano meno probabilità di entrare in guerra tra loro - un concetto noto come "pace democratica" - continuano a essere coinvolte in conflitti militari. Questi conflitti spesso coinvolgono Paesi non democratici o fanno parte di missioni internazionali di mantenimento della pace o di lotta al terrorismo. I Paesi del Nord tendono anche a utilizzare mezzi diversi dalla guerra convenzionale per raggiungere i loro obiettivi di politica estera. Ad esempio, possono utilizzare la diplomazia, le sanzioni economiche, gli aiuti allo sviluppo e altri strumenti di "soft power" per influenzare altre nazioni. Inoltre, la tecnologia ha cambiato la natura della guerra. I Paesi del Nord, in particolare, tendono a fare molto affidamento sulla tecnologia avanzata nella loro condotta di guerra. L'uso di droni, attacchi informatici e altre forme di guerra non convenzionale è sempre più comune. In definitiva, sebbene la natura e la condotta della guerra possano cambiare, l'uso della forza militare rimane purtroppo una caratteristica della politica internazionale. È quindi fondamentale continuare a cercare modi per prevenire i conflitti e promuovere la pace e la sicurezza globale. | |||
== | == Verso una guerra postmoderna == | ||
[[File:MQ-9 Reaper taxis.jpg|thumb|MQ-9 Reaper taxiing.]] | [[File:MQ-9 Reaper taxis.jpg|thumb|MQ-9 Reaper taxiing.]] | ||
I modelli di guerra sono cambiati in modo significativo, soprattutto nei Paesi occidentali. Le caratteristiche principali di questo cambiamento sono state un maggiore uso della tecnologia, una maggiore professionalizzazione degli eserciti e una crescente avversione per le perdite umane, spesso definita "allergia al rischio". Il concetto di "Western Way of War" sottolinea la preferenza per la tecnologia avanzata e la superiorità aerea nella conduzione della guerra. La tecnologia è diventata un elemento chiave nella conduzione della guerra, con lo sviluppo di armi sempre più sofisticate, l'uso di droni e la crescente importanza della guerra informatica. Inoltre, la crescente professionalizzazione delle forze armate ha portato a un addestramento più avanzato e a una maggiore specializzazione del personale militare. Gli eserciti professionali sono sempre più diffusi e la coscrizione o la leva sono sempre meno frequenti nei Paesi occidentali. L'"allergia al rischio" è stata esacerbata dal fatto che le società occidentali hanno sempre più difficoltà ad accettare la perdita di vite umane in guerra. Questo ha portato a preferire gli attacchi aerei e l'uso dei droni, che permettono di condurre operazioni militari senza mettere in pericolo la vita dei soldati. | |||
Attualmente si assiste a un chiaro declino dell'accettazione sociale della perdita di vite umane nelle guerre combattute all'estero. Le persone sono sempre meno disposte a sostenere conflitti che comportano la perdita di vite umane, in particolare dei propri cittadini. Questa situazione è in parte alimentata dalla copertura mediatica onnipresente e istantanea dei conflitti, che rende i costi umani della guerra più visibili e reali per la popolazione generale. Allo stesso tempo, i progressi tecnologici hanno reso possibile combattere le guerre da una distanza maggiore. L'uso di droni, missili di precisione e altre tecnologie all'avanguardia consente di effettuare attacchi a distanza, senza alcun rischio diretto per le truppe a terra. Questa forma di guerra tecnologica è in gran parte il risultato di sviluppi tecnologici facilitati dai governi. | |||
L' | L'uso dei droni nei conflitti moderni ha cambiato radicalmente la natura della guerra. Il pilotaggio dei droni consente di condurre operazioni militari, compresi attacchi letali, a migliaia di chilometri di distanza. Il personale che controlla questi droni spesso lo fa da basi situate al di fuori del campo di battaglia, a volte persino in un altro Paese. Ciò solleva una serie di questioni etiche e morali. Da un lato, riduce al minimo i rischi per le forze militari che controllano i droni. Dall'altro, può creare un distacco tra l'atto di uccidere e la realtà della guerra, che a sua volta può avere conseguenze psicologiche per gli operatori dei droni. Inoltre, può rendere il processo decisionale sull'uso della forza meno immediato e meno personale, abbassando potenzialmente la soglia dell'uso della forza. L'uso dei droni ha anche implicazioni strategiche. Permette di effettuare attacchi precisi con un rischio minimo per le forze militari, ma può anche causare vittime civili e danni collaterali. L'uso dei droni solleva quindi importanti questioni di diritto umanitario internazionale e di responsabilità. | ||
La | La domanda è se questo allontanamento stia cambiando la natura della guerra, se si tratti di un'evoluzione, di una rivoluzione negli affari militari con il concetto di guerra "a morte zero", se dobbiamo andare oltre Clausewitz quando parliamo di Mary Kaldor, per esempio. Mettere la guerra a distanza grazie alla tecnologia, in particolare ai droni, solleva la questione se la natura stessa della guerra stia cambiando. La possibilità di condurre operazioni militari senza mettere direttamente in pericolo la vita dei propri soldati cambia innegabilmente l'esperienza della guerra e può influenzare il processo decisionale sull'uso della forza. Il concetto di "guerra a zero morti" può sembrare attraente dal punto di vista di coloro che fanno la guerra, ma non dovrebbe oscurare il fatto che anche una guerra combattuta a distanza può avere conseguenze devastanti per i civili e causare la perdita di vite umane. Se dobbiamo "andare oltre Clausewitz" è una questione dibattuta tra i teorici militari. Clausewitz sosteneva che la guerra è un'estensione della politica con altri mezzi. Sebbene la tecnologia abbia cambiato il modo di combattere la guerra, si può sostenere che l'obiettivo finale rimane lo stesso: raggiungere obiettivi politici. Da questo punto di vista, il pensiero di Clausewitz è ancora attuale. Detto questo, il lavoro di studiosi come Mary Kaldor ha evidenziato che le forme contemporanee di violenza organizzata possono differire dai modelli tradizionali di guerra previsti da Clausewitz. Le "nuove guerre", secondo Kaldor, sono caratterizzate dalla violenza all'interno degli Stati, dal coinvolgimento di attori non statali e dalla crescente importanza delle identità piuttosto che delle ideologie. Queste trasformazioni potrebbero portarci a ripensare alcune delle teorie classiche della guerra. | ||
La | La guerra sta davvero cambiando? È qualcosa che sta diventando sempre più spoliticizzato nei Paesi del Sud, e in definitiva è qualcosa di eminentemente tecnologico in cui non c'è più alcun legame con ciò che accade sul campo? La percezione della guerra come qualcosa di lontano e tecnologico, soprattutto in Occidente, può essere un fenomeno in crescita. Tuttavia, affermare che la guerra si stia "depoliticizzando" richiede un'analisi più sfumata. | ||
Nei Paesi del Sud, nonostante l'aumento dei conflitti intrastatali e della violenza perpetrata da attori non statali, questi conflitti rimangono profondamente politici. Possono essere legati a lotte per il controllo delle risorse, a differenze etniche o religiose, ad aspirazioni di autodeterminazione o a reazioni alla corruzione e al malgoverno. Inoltre, la violenza organizzata può avere importanti implicazioni politiche, influenzando le strutture di potere, alterando le relazioni tra i gruppi e plasmando il futuro politico di un Paese. Nei Paesi del Nord, l'uso di tecnologie come i droni può dare l'impressione di una "disumanizzazione" della guerra, in cui gli atti di violenza sono commessi a distanza e in modo apparentemente distaccato. Tuttavia, questo approccio alla guerra può avere le sue implicazioni politiche. Ad esempio, l'apparente facilità con cui la violenza può essere inflitta a distanza può influenzare le decisioni su quando e come usare la forza. Inoltre, il modo in cui queste tecnologie vengono utilizzate e regolate può dare origine a importanti dibattiti politici. È quindi fondamentale capire che, sebbene la natura e la condotta della guerra possano evolversi, la guerra rimane un'impresa profondamente politica e le sue conseguenze si fanno sentire ben oltre il campo di battaglia. | |||
Stiamo parlando di tutte le guerre che vediamo sugli schermi, come la Guerra del Golfo negli anni '90, che sembrano lontane perché non le viviamo nemmeno attraverso le nostre famiglie o le nostre esperienze. La Guerra del Golfo degli anni '90 ha segnato un punto di svolta nel modo in cui la guerra viene percepita dal pubblico. La guerra è stata ampiamente coperta dai media, con immagini della guerra trasmesse in diretta dalla televisione. Questo ha contribuito a creare una certa distanza tra il pubblico e il conflitto reale. Guardando la guerra attraverso lo schermo televisivo, essa può sembrare distante e scollegata dalla nostra vita quotidiana. Questa distanza può essere accentuata anche dal fatto che sempre meno persone nei Paesi occidentali hanno un'esperienza diretta di servizio militare. Mentre un tempo il servizio militare era un'esperienza comune per molti uomini (e alcune donne), oggi molti Paesi hanno eserciti completamente professionali. Ciò significa che la guerra è vissuta direttamente da una percentuale minore della popolazione. Sebbene la guerra possa sembrare lontana per molte persone nei Paesi occidentali, ha conseguenze molto reali per coloro che ne sono direttamente coinvolti, sia che si tratti dei militari dispiegati nelle zone di conflitto che delle popolazioni locali colpite. Inoltre, anche se un conflitto può sembrare geograficamente lontano, può avere conseguenze indirette attraverso fenomeni come i flussi di rifugiati, l'impatto economico o le minacce alla sicurezza internazionale. | |||
= Appendici = | = Appendici = | ||
| Ligne 468 : | Ligne 460 : | ||
[[Category:relations internationales]] | [[Category:relations internationales]] | ||
[[Category:sécurité]] | [[Category:sécurité]] | ||
Version actuelle datée du 7 juillet 2023 à 12:09
Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu ● Le origini della caduta della Repubblica di Weimar ● Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto ● La nozione di "concetto" nelle scienze sociali ● Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni ● Marxismo e strutturalismo ● Funzionalismo e Sistemismo ● Interazionismo e Costruttivismo ● Teorie dell'antropologia politica ● Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee ● Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica ● Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica ● Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica ● Teorie della guerra nella scienza politica ● Guerra: concezioni e sviluppi ● Ragion di Stato ● Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello ● Teorie della violenza nella scienza politica ● Welfare state e biopotere ● Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione ● Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze ● Il sistema di governo delle democrazie ● Morfologia delle contestazioni ● L'azione nella teoria politica ● Introduzione alla politica svizzera ● Introduzione al comportamento politico ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda ● Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione ● Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali ● Introduzione alla teoria politica
La guerra è un fenomeno complesso che ha subito numerose concezioni ed evoluzioni nel corso della storia. Epoche e società diverse hanno avuto prospettive diverse sulla guerra e queste concezioni si sono evolute in risposta ai cambiamenti politici, economici, tecnologici e sociali.
La guerra è un conflitto armato tra Stati o gruppi, spesso caratterizzato da estrema violenza, disordine sociale e dissesto economico. In genere comporta il dispiegamento e l'uso di forze militari e l'applicazione di strategie e tattiche per sconfiggere l'avversario. La guerra può avere molte cause, tra cui disaccordi territoriali, politici, economici o ideologici. Si ritiene che la guerra moderna abbia avuto origine con la nascita dello Stato nazionale nel XVII secolo. Il Trattato di Westfalia del 1648 segnò la fine della Guerra dei Trent'anni in Europa e stabilì il concetto di sovranità nazionale. Questo ha creato un sistema internazionale basato su Stati nazionali indipendenti che potevano legittimamente ricorrere alla guerra. L'aumento delle dimensioni degli eserciti, il miglioramento della tecnologia militare e l'evoluzione di tattiche e strategie hanno contribuito alla nascita della guerra moderna. In un'epoca di terrorismo e globalizzazione, la natura della guerra sta cambiando. Oggi ci troviamo di fronte a conflitti asimmetrici in cui attori non statali, come i gruppi terroristici, svolgono un ruolo importante. Inoltre, l'ascesa della cibernetica ha portato all'emergere della guerra informatica. Infine, la guerra dell'informazione, in cui le informazioni vengono utilizzate per manipolare o fuorviare l'opinione pubblica o l'avversario, è diventata una tattica comune.
L'idea della fine della guerra è dibattuta. Alcuni sostengono che la globalizzazione, l'interdipendenza economica e la diffusione dei valori democratici abbiano reso la guerra meno probabile. Altri sostengono che la guerra non stia per scomparire, citando l'esistenza di conflitti armati in corso, la persistenza di tensioni internazionali e la possibilità di futuri conflitti per risorse limitate o a causa dell'instabilità climatica. Inoltre, mentre i conflitti tradizionali tra Stati possono diminuire, persistono nuove forme di conflitto, come il terrorismo o la cibernetica. Il futuro della guerra è incerto, ma ciò che è certo è che il perseguimento della diplomazia, del dialogo e del disarmo è essenziale per prevenire la guerra e promuovere una pace duratura.
In primo luogo, esploreremo la natura fondamentale della guerra, prima di esaminare l'emergere della guerra moderna. Vedremo che la guerra trascende la semplice violenza e agisce come elemento regolatore del nostro sistema internazionale, che si è formato nel corso di diversi secoli. Esamineremo poi gli sviluppi contemporanei della guerra, in particolare nel contesto del terrorismo e della globalizzazione, e ci chiederemo se la natura della guerra stia cambiando e se i suoi principi fondamentali si stiano evolvendo. Infine, esamineremo il futuro della guerra: sta finendo o persiste in altre forme?
Che cos'è la guerra?[modifier | modifier le wikicode]
Definizione di guerra[modifier | modifier le wikicode]
Ci chiederemo che cos'è la guerra ed esamineremo alcuni avvertimenti e idee preconcette sulla guerra. Esistono molte definizioni di guerra, ma una delle più rilevanti è quella di Hedley Bull, il fondatore della scuola inglese, che, nel suo libro del 1977 The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, dà la seguente definizione: "una violenza organizzata portata avanti da unità politiche le une contro le altre".
La definizione di guerra di Hedley Bull mette in luce diversi aspetti chiave di questo complesso fenomeno.
1 "Violenza organizzata": l'uso di questa espressione suggerisce che la guerra non è una serie casuale o caotica di atti violenti. È organizzata e pianificata, spesso nei minimi dettagli. Questa organizzazione può comportare la mobilitazione delle truppe, lo sviluppo di strategie e tattiche, la produzione e l'acquisizione di armi e molti altri aspetti logistici. La violenza in questione è anche estrema e generalmente comporta morti e feriti gravi, distruzione di proprietà e instabilità sociale.
2. "Condotta da unità politiche": qui Bull sottolinea che la guerra è un atto commesso da attori politici - tipicamente Stati nazionali, ma anche gruppi non statali potenzialmente organizzati politicamente. Ciò riflette il fatto che la guerra è spesso il prodotto di decisioni politiche e viene utilizzata per raggiungere obiettivi politici. Questi possono includere obiettivi quali la conquista del territorio, il cambio di regime, l'affermazione del potere nazionale o la difesa da una minaccia percepita.
3. "Questa parte della definizione sottolinea che la guerra implica un conflitto. Non si tratta di atti di violenza unilaterali, ma di una situazione in cui diverse parti si oppongono attivamente. Ciò implica una dinamica interattiva in cui le azioni di ciascuna parte influenzano le azioni dell'altra, creando un ciclo di violenza che può essere difficile da interrompere.
Questa definizione, pur essendo semplice, comprende molti aspetti della guerra. Tuttavia, è importante notare che la guerra è un fenomeno complesso che non può essere pienamente compreso o spiegato da un'unica definizione. Molte altre prospettive e teorie possono fornire indicazioni preziose sulla natura della guerra, sulla sua origine, sul suo corso e sulle sue conseguenze.
La distinzione tra la violenza interpersonale, come il crimine e l'aggressione, e la guerra, come violenza organizzata condotta da unità politiche, è fondamentale:
- Violenza interpersonale: si riferisce ad atti di violenza commessi da singoli individui o da piccoli gruppi, spesso nell'ambito di reati come furto, aggressione, omicidio, ecc. In genere non è coordinato o organizzato su larga scala e non è finalizzato al raggiungimento di obiettivi politici. Le motivazioni possono essere varie, dal conflitto personale alla ricerca di guadagni materiali.
- Guerra: a differenza della violenza interpersonale, la guerra è una forma di violenza su larga scala accuratamente organizzata e pianificata da unità politiche, solitamente Stati nazionali o gruppi politici strutturati. La guerra mira a raggiungere obiettivi specifici, spesso politici, attraverso l'uso della forza. I combattenti sono solitamente soldati o militanti addestrati ed equipaggiati e i conflitti sono spesso combattuti secondo determinate regole o convenzioni.
L'osservazione di Hedley Bull sulla natura ufficiale della guerra è fondamentale per comprenderne la natura. A suo avviso, la guerra è condotta da unità politiche, di solito Stati, contro altre entità politiche. È un'azione ufficialmente sancita e condotta in nome dello Stato. Questa distinzione è importante perché separa la nozione di guerra da quella di lotta al crimine, che è anch'essa una forma di violenza organizzata, ma opera in un contesto diverso. Mentre la guerra è generalmente un conflitto tra Stati o gruppi politici, il controllo della criminalità è un'azione intrapresa dallo Stato all'interno dei propri confini per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il controllo della criminalità è generalmente svolto dalle forze dell'ordine, come la polizia, la cui missione è prevenire e reprimere il crimine. Lo scopo non è raggiungere obiettivi politici o strategici, come nel caso della guerra, ma piuttosto proteggere i cittadini e far rispettare la legge. Questa differenziazione sottolinea l'eccezionalità della guerra come atto di violenza organizzata che trascende i confini politici, si contrappone alla violenza interna ed è sanzionata dallo Stato o da un'entità politica. La guerra è intrinsecamente un fenomeno politico, volto a cambiare lo status quo, spesso attraverso l'uso della forza armata, e rappresenta quindi una dimensione distinta della violenza nella società.
La definizione di guerra di Hedley Bull è abbastanza completa e precisa. Descrive in modo appropriato la natura della guerra moderna, evidenziandone gli aspetti chiave: è una violenza organizzata, condotta da unità politiche, tra di loro, e generalmente diretta al di fuori di queste unità politiche. Questa definizione coglie ciò che molti intendono per "guerra", compresi coloro che la studiano in un contesto accademico o militare. Coglie l'idea che la guerra sia un fenomeno strutturato, con attori specifici (unità politiche), un carattere ufficiale e un orientamento esterno. Questa definizione serve anche come base per comprendere la complessità dei conflitti moderni, in cui i confini tra attori statali e non statali possono essere sfumati e in cui i conflitti possono coinvolgere attori internazionali e trascendere i confini nazionali.
Tuttavia, va notato che questa definizione, pur essendo utile, è solo uno dei tanti modi possibili di definire e comprendere la guerra. Altre prospettive possono enfatizzare altri aspetti della guerra, come le sue dimensioni sociali, economiche o psicologiche. Come per ogni fenomeno complesso, una comprensione completa della guerra richiede un approccio multidimensionale che tenga conto delle sue molteplici sfaccettature e implicazioni.
Decostruire la saggezza convenzionale[modifier | modifier le wikicode]
Il concetto di guerra si è infiltrato nella nostra coscienza collettiva attraverso la storia, i media, la letteratura e altre forme di comunicazione culturale. Tuttavia, le nostre percezioni intuitive della guerra possono essere modellate da preconcetti che non riflettono necessariamente la complessità della realtà.
L'approccio di Thomas Hobbes: "la guerra di tutti contro tutti"[modifier | modifier le wikicode]
Per Thomas Hobbes ne Il Leviatano, pubblicato nel 1651, la guerra è "la guerra di tutti contro tutti". In questo libro, Hobbes descrive lo stato di natura, una condizione ipotetica in cui non esiste un governo o un'autorità centrale che imponga l'ordine. Egli definisce lo stato di natura come una "guerra di tutti contro tutti" (bellum omnium contra omnes in latino), in cui gli individui sono in costante competizione tra loro per la sopravvivenza e le risorse. Secondo Hobbes, senza un'autorità centrale che mantenga l'ordine, gli esseri umani sarebbero in costante conflitto e la vita sarebbe "solitaria, povera, sgradevole, brutale e breve". Per questo motivo, secondo lui, gli esseri umani accettano di rinunciare a parte della loro libertà a favore di un governo o sovrano (il Leviatano), capace di imporre pace e ordine.
Nel "Leviatano", Hobbes sostiene che senza uno Stato o un'autorità centrale, la vita degli individui sarebbe in un costante stato di "guerra di tutti contro tutti". È l'anarchia, sostiene Hobbes, che regna in assenza dello Stato. Anarchia, in questo contesto, non significa necessariamente caos o disorganizzazione, ma piuttosto l'assenza di un'autorità centrale che imponga regole e norme di comportamento. Per Hobbes, lo Stato è quindi uno strumento necessario per regolare le relazioni interindividuali, prevenire i conflitti e garantire la sicurezza degli individui. Secondo Hobbes, gli individui accettano di rinunciare a parte della loro libertà in cambio della sicurezza e della stabilità che lo Stato può fornire.
In realtà, anche in situazioni di estrema instabilità sociale o politica, gli esseri umani tendono a formare strutture e organizzazioni per preservare l'ordine e facilitare la sopravvivenza. La guerra perpetua, come descritta da Hobbes ne Lo stato di natura, è praticamente impossibile da un punto di vista empirico. Inoltre, fare la guerra richiede un grado di organizzazione e coordinamento che gli individui in uno stato di anarchia difficilmente riuscirebbero a raggiungere. Gli individui sono più inclini a raggrupparsi per la propria difesa o per raggiungere obiettivi comuni, il che di per sé può essere visto come una forma primitiva di Stato o di governo. È importante notare che Hobbes utilizza lo stato di natura e la "guerra di tutti contro tutti" come strumenti concettuali per sostenere l'importanza dello Stato e del contratto sociale. Non suggerisce necessariamente che questo stato di natura sia mai esistito letteralmente.
I conflitti armati, in particolare quelli che raggiungono il livello di guerra, implicano dinamiche molto più complesse della semplice aggressione o del conflitto individuale. Richiedono un'organizzazione significativa, una pianificazione strategica e risorse sostanziali.
Le guerre coinvolgono generalmente attori politici - Stati o gruppi che cercano di raggiungere obiettivi politici specifici. Pertanto, la guerra non è solo un'estensione dell'aggressività o dell'egoismo individuale, ma è anche fortemente legata alla politica, all'ideologia e alle strutture di potere. Inoltre, le guerre hanno spesso conseguenze sociali e politiche di vasta portata. Possono ridisegnare i confini, rovesciare i governi, provocare importanti cambiamenti sociali e avere effetti duraturi sugli individui e sulle comunità. Per questo motivo, lo studio della guerra richiede una comprensione approfondita di molti aspetti diversi della società umana, tra cui la politica, la psicologia, l'economia, la tecnologia e la storia.
La visione di Hobbes della "guerra di tutti contro tutti" si concentra sull'egoismo e sul conflitto come aspetti intrinseci della natura umana. Tuttavia, la guerra, così come la conosciamo, non è semplicemente il prodotto dell'egoismo o dell'aggressività individuale. È infatti una complessa creazione sociale che richiede un'organizzazione e un coordinamento sostanziali. L'idea che la guerra sia in realtà un prodotto della nostra socialità, e non del nostro egoismo, è molto illuminante. Per fare la guerra non servono solo le risorse, ma anche una struttura organizzativa per coordinare gli sforzi, un'ideologia o un obiettivo per unificare i partecipanti e norme o regole per disciplinare la condotta. Tutti questi elementi sono il prodotto della vita in società. Questa prospettiva suggerisce che, per comprendere la guerra, dobbiamo guardare oltre i semplici istinti o i comportamenti individuali e considerare le strutture sociali, politiche e culturali che permettono e danno forma ai conflitti armati. Sottolinea inoltre che la prevenzione della guerra richiede attenzione a queste strutture, e non solo alla natura umana.
Sebbene la teoria hobbesiana della "guerra di tutti contro tutti" suggerisca che la guerra sia radicata nella natura egoistica degli individui, la realtà è molto più complessa. La guerra richiede un certo grado di organizzazione, pianificazione e coordinamento, tutte caratteristiche delle società umane piuttosto che di individui isolati. Di conseguenza, la guerra può essere meglio compresa come un fenomeno sociale, piuttosto che come una semplice estensione dell'egoismo o dell'aggressività individuale. La guerra è spesso influenzata da, e a sua volta influenza, una serie di strutture e processi sociali, tra cui la politica, l'economia, la cultura, le norme e i valori sociali. I conflitti armati non si verificano nel vuoto, ma sono profondamente radicati in specifici contesti sociali e storici.
La guerra è molto più di una semplice manifestazione di aggressività o egoismo umano. È piuttosto il risultato di una vasta gamma di fattori sociali e organizzativi che permettono, facilitano e motivano i conflitti su larga scala. Per scatenare una guerra, è necessario molto di più di una semplice volontà o desiderio di combattere. Sono necessarie strutture organizzative in grado di mobilitare risorse, coordinare strategie e dirigere le forze armate. Queste strutture comprendono, tra l'altro, amministrazioni burocratiche, catene di comando militari e sistemi di supporto logistico. Queste organizzazioni non possono esistere senza il quadro sociale che le sostiene. Inoltre, deve esistere anche un certo tipo di cultura e ideologia che giustifichi e valorizzi la guerra. Credenze, valori e norme sociali giocano un ruolo cruciale nella creazione e nel mantenimento di queste organizzazioni, così come nel motivare gli individui a partecipare alla guerra. La guerra è quindi un fenomeno profondamente sociale e strutturale. È il prodotto della nostra capacità di vivere insieme in società, e non del nostro egoismo o della nostra aggressività individuale. Questa prospettiva può offrire importanti spunti per prevenire i conflitti e promuovere la pace.
L'approccio di Eraclito: la guerra è il padre di tutte le cose e di tutte le cose è il re[modifier | modifier le wikicode]
Abbiamo appena visto come fare la guerra e come renderla possibile; ora, con il secondo preconcetto, ci occuperemo del "quando". Il secondo preconcetto è quello della guerra perpetua di Eraclito, che postula che "la guerra è il padre di tutte le cose e di tutte è il re". Tuttavia, questa visione semplifica eccessivamente la realtà.
La guerra, così come la conosciamo oggi, è un fenomeno specifico che richiede un certo livello di struttura sociale e organizzativa, come abbiamo detto in precedenza. In altre parole, la guerra non è semplicemente una manifestazione della violenza umana, ma piuttosto una forma organizzata e strutturata di conflitto che si è evoluta nel tempo in funzione di fattori sociali, politici, economici e tecnologici. La presenza di violenza organizzata non è una caratteristica universale di tutte le società umane nel corso della storia. Alcune società hanno vissuto periodi prolungati di pace, mentre altre hanno sperimentato livelli più elevati di violenza e conflitto. Inoltre, anche la natura stessa della guerra è cambiata in modo significativo nel corso del tempo. La guerra antica, ad esempio, era molto diversa da quella moderna in termini di strategia, tecnologia, tattica e conseguenze.
Se adottiamo una visione un po' più sociologica, potremmo dire che la guerra è un fenomeno relativamente recente nella storia dell'umanità, o almeno non è una caratteristica senza tempo. Le prove archeologiche e antropologiche indicano che la guerra, così come la intendiamo oggi come conflitto organizzato su larga scala tra entità politiche, è un fenomeno relativamente recente nella storia umana. È solo con l'emergere di società più complesse e gerarchiche, spesso accompagnate dalla sedentarizzazione e dall'agricoltura, che iniziamo a vedere chiari segni di guerra organizzata. Prima di allora, sebbene esistessero certamente la violenza interpersonale e i conflitti su piccola scala, non ci sono prove convincenti di conflitti su larga scala che comportassero un coordinamento complesso e obiettivi politici. Questo non significa che le società umane fossero pacifiche o prive di violenza, ma piuttosto che la natura di questa violenza era diversa e non corrispondeva a quella che generalmente chiamiamo "guerra".
L'idea che la guerra sia un fenomeno recente nella scala della storia umana è supportata da numerosi studi antropologici e archeologici. Prima dell'avvento dell'agricoltura durante la rivoluzione neolitica, intorno al 7000 a.C., gli esseri umani vivevano generalmente in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori. Questi gruppi avevano conflitti, ma erano generalmente di piccola entità e non assomigliavano alle guerre organizzate che conosciamo oggi. Non possiamo parlare di guerra. La guerra, come la definiamo oggi, richiede una certa organizzazione sociale e una specializzazione del lavoro, compresa la formazione di gruppi dedicati al combattimento. Inoltre, la guerra spesso implica conflitti per il controllo delle risorse, che diventano più rilevanti con l'emergere dell'agricoltura e la sedentarizzazione delle popolazioni, quando le risorse diventano più localizzate e limitate. Per questo motivo la maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che la guerra, come fenomeno strutturato e organizzato, probabilmente non esisteva prima della rivoluzione neolitica, circa 10.000 anni fa. Ciò significa che per la maggior parte della storia dell'umanità la guerra come la conosciamo non esisteva, il che mette in discussione l'idea che sia un aspetto naturale e inevitabile della società umana. Quindi, se ipotizziamo che l'uomo sia comparso 200.000 anni fa, la guerra avrebbe riguardato solo il 5% della nostra storia. Siamo ben lontani da un fenomeno antistorico e universale che è sempre esistito.
È importante evitare di essenzializzare la guerra come qualcosa che è in noi. Se guardiamo empiricamente ai fatti, la guerra non è sempre esistita ed è legata a un'organizzazione sociale sviluppata. Questa forma di organizzazione sociale è apparsa a partire dal Neolitico e ha coinciso con la specializzazione funzionale, cioè con la comparsa delle prime città. Pertanto, la guerra come fenomeno organizzato e istituzionalizzato è intrinsecamente legata all'emergere di società più complesse, in particolare con la nascita delle prime città. La vita nelle città ha portato a una divisione del lavoro molto più marcata, con individui specializzati in mestieri specifici, alcuni dei quali erano legati alla difesa e alla guerra. Le società di cacciatori-raccoglitori hanno spesso una divisione del lavoro basata sul sesso e sull'età, ma la diversità dei ruoli è generalmente limitata rispetto a quella che si osserva nelle società agricole più complesse. Con lo sviluppo dell'agricoltura e delle prime città, la divisione del lavoro si è notevolmente ampliata, permettendo la formazione di classi di guerrieri specializzati. Questo coincide anche con l'emergere dei primi Stati, che dispongono delle risorse e dell'organizzazione necessarie per condurre guerre su larga scala. È in questo periodo che si assiste all'emergere di forme di violenza organizzata e prolungata che riconosciamo come guerre.
Si tratta di un'idea fondamentale per la costruzione di uno Stato e per lo sviluppo delle nostre società. La capacità di organizzare e condurre guerre è diventata un elemento chiave nella formazione degli Stati. In molti casi, la minaccia della violenza o della guerra ha contribuito all'unificazione di gruppi diversi sotto un'autorità centrale, portando alla creazione degli Stati nazionali. Ciò si riflette nella teoria del contratto sociale di Hobbes, in cui si postula che gli individui accettino di rinunciare a certe libertà e di concedere l'autorità a un'entità suprema (lo Stato) in cambio di sicurezza e ordine. In questo senso, la guerra (o la minaccia di guerra) può fungere da catalizzatore per la formazione degli Stati. Inoltre, la gestione della guerra, attraverso la costituzione di eserciti, la difesa del territorio, l'applicazione del diritto internazionale e la diplomazia, è diventata una parte essenziale delle responsabilità degli Stati moderni. Ciò si riflette nello sviluppo di burocrazie dedicate, di sistemi fiscali per finanziare gli sforzi militari e di politiche interne ed esterne incentrate su questioni militari e di sicurezza. Pertanto, la guerra e la formazione dello Stato sono profondamente intrecciate, ognuna delle quali influenza e modella l'altra nel corso della storia umana.
La specializzazione professionale è stata un fattore chiave nello sviluppo delle società umane. Questo è noto come divisione del lavoro, un concetto che è stato ampiamente esplorato da pensatori come Adam Smith ed Emile Durkheim. La divisione del lavoro può essere descritta come un processo attraverso il quale i compiti necessari alla sopravvivenza e al funzionamento di una società vengono suddivisi tra i suoi membri. Ad esempio, alcune persone possono specializzarsi nell'agricoltura, mentre altre si specializzano nell'edilizia, nel commercio, nell'insegnamento o nella sicurezza. Questa specializzazione consente a ciascun individuo di sviluppare competenze e conoscenze specifiche per il proprio ruolo, che in genere aumentano l'efficienza e la produttività della società nel suo complesso. A loro volta, gli individui dipendono gli uni dagli altri per soddisfare i propri bisogni, creando una complessa rete di interdipendenza. In termini di sicurezza e applicazione della violenza, la specializzazione ha portato alla creazione di forze di polizia ed eserciti. Queste entità sono responsabili del mantenimento dell'ordine, della protezione della società e dell'applicazione di leggi e regolamenti. Questa specializzazione ha avuto implicazioni significative anche sulla conduzione della guerra e sulla strutturazione delle società moderne.
La guerra, come la intendiamo oggi, coincide con la rivoluzione neolitica, un periodo in cui gli esseri umani iniziarono a stabilirsi e a creare strutture sociali più complesse. Prima di allora esistevano conflitti tra gruppi, ma probabilmente non avevano la stessa scala o lo stesso livello di organizzazione di ciò che oggi classifichiamo come "guerra". La rivoluzione neolitica ha visto gli esseri umani evolversi da cacciatori-raccoglitori nomadi ad agricoltori sedentari. Ciò ha portato alla creazione della prima densità di popolazione significativa - le città - e all'emergere di nuove forme di struttura sociale e politica. Questa maggiore densità di popolazione e strutture più complesse hanno probabilmente aumentato la competizione per le risorse, che può aver portato a conflitti più organizzati. Inoltre, con l'emergere delle città, iniziò a svilupparsi la specializzazione delle occupazioni. Questa specializzazione comprendeva ruoli dedicati alla protezione e alla difesa della comunità, come i guerrieri o i soldati, che potevano dedicarsi interamente a questi compiti invece di doversi preoccupare anche dell'agricoltura o della caccia. Questa specializzazione portò alla nascita di forze militari più organizzate ed efficaci, contribuendo all'intensificarsi della guerra come fenomeno sociale.
Dopo la rivoluzione neolitica, abbiamo assistito a un rapido aumento della complessità sociale e politica. La sedentarizzazione e l'agricoltura hanno portato a società più stabili e ricche, in grado di sostenere una popolazione in crescita. Con l'aumento della popolazione e della ricchezza, la competizione per le risorse si intensificò, portando a un aumento dei conflitti. Le prime città-stato, come quelle di Sumer in Mesopotamia intorno al 5000 a.C., sono un ottimo esempio di questo aumento di complessità. Queste città-stato erano società altamente organizzate e gerarchiche, con una chiara divisione del lavoro, compresi i ruoli militari. Avevano governi, sistemi giuridici e religioni propri e, molto spesso, possedevano e controllavano il proprio territorio. Queste città-stato competevano per il controllo delle risorse e del territorio e questa competizione spesso sfociava in una guerra. Le guerre dell'epoca erano spesso affari ufficiali, condotti da re o governanti simili, e costituivano una parte importante della politica del tempo. Nel corso del tempo, queste città-stato si sono evolute in regni e imperi più grandi e complessi, come l'Impero egizio, l'Impero assiro e successivamente l'Impero persiano, greco e romano. Questi imperi portarono a guerre ancora più grandi e complesse, che spesso coinvolgevano migliaia o addirittura decine di migliaia di soldati.
La falange: le origini della violenza organizzata moderna[modifier | modifier le wikicode]
Durante l'antichità classica, e soprattutto durante l'epoca dell'Impero romano, la guerra fece un salto di qualità in termini di complessità organizzativa e tecnologica.
In termini organizzativi, l'esercito romano divenne una vera e propria macchina da guerra, con una chiara gerarchia, una rigida disciplina, un addestramento rigoroso e una logistica sofisticata. Il modello dell'esercito romano, basato sulla legione come unità di base, permetteva ai Romani di dispiegare le forze in modo rapido ed efficiente su un vasto territorio. In termini di tecnologia, il periodo vide anche l'introduzione e la diffusione di nuove armi e attrezzature belliche. I Romani, ad esempio, svilupparono il pilum, un tipo di giavellotto progettato per penetrare scudi e armature. Innovarono anche nella costruzione di macchine d'assedio, come catapulte e arieti.
La dimensione tecnologica della guerra non si limitava alle armi e alle attrezzature. I Romani furono particolarmente efficaci nell'utilizzare l'ingegneria a sostegno dei loro sforzi militari. Per esempio, costruirono una vasta rete di strade e ponti per facilitare il rapido movimento delle loro truppe. Utilizzarono inoltre le loro conoscenze ingegneristiche per costruire fortezze e fortificazioni e per condurre complesse operazioni di assedio. Queste innovazioni organizzative e tecnologiche resero la guerra un'impresa sempre più complessa e costosa. Tuttavia, hanno anche contribuito a rafforzare il potere di imperi come Roma, consentendo loro di conquistare e controllare vasti territori.
L'evoluzione della guerra è strettamente legata alla crescente complessità delle società. La falange ne è un esempio perfetto. La falange era una formazione da combattimento utilizzata dagli eserciti dell'antica Grecia. Si trattava di un'unità di fanteria pesante composta da soldati (opliti) che stavano fianco a fianco in ranghi serrati. Ogni soldato portava uno scudo ed era dotato di una lunga lancia (sarissa), che usava per attaccare il nemico rimanendo protetto dietro lo scudo del suo vicino. La falange era una formazione altamente organizzata e disciplinata che richiedeva un addestramento intensivo e un coordinamento preciso. Il suo obiettivo principale era quello di schiacciare il nemico al primo impatto, utilizzando la forza collettiva dei soldati per sfondare le linee nemiche.
Ciò rappresentava un grande progresso rispetto ai metodi di combattimento più aleatori utilizzati in precedenza. Questa organizzazione di combattimento più complessa rifletteva la struttura più complessa della società greca dell'epoca. Gli eserciti di cittadini-soldato dovevano essere ben disciplinati e ben addestrati per poter utilizzare efficacemente la falange. Durante le sue campagne militari, Alessandro Magno perfezionò l'uso della falange, aggiungendo elementi di cavalleria e fanteria leggera per creare una forza militare più flessibile e adattabile. Ciò contribuì ai suoi successi militari e all'espansione del suo impero.
L'evoluzione della guerra è stata fortemente influenzata dal progresso tecnologico. Man mano che le società si sviluppavano e diventavano più complesse, la tecnologia giocava un ruolo sempre più importante nel modo in cui le guerre venivano combattute. Dalle falangi dell'antica Grecia all'uso delle catapulte e di altre macchine d'assedio nel Medioevo, fino all'uso della polvere da sparo in Cina e in Europa, la tecnologia ha sempre contribuito a plasmare le strategie militari. Questa tendenza è proseguita nell'era moderna con l'avvento dell'artiglieria, delle navi da guerra a vapore, dei sottomarini, degli aerei, dei carri armati e infine delle armi nucleari. Più recentemente, la guerra cibernetica e i droni armati sono diventati elementi chiave del campo di battaglia contemporaneo. La tecnologia non solo ha influenzato le tattiche e le strategie di combattimento, ma ha anche trasformato la logistica, le comunicazioni e l'intelligence militare. Ha permesso di intraprendere azioni militari in modo più rapido, efficace e su scala più ampia.
Il Medioevo fu segnato da un cambiamento nel modo di condurre la guerra. La caduta dell'Impero romano ha comportato la perdita dell'organizzazione militare e della tecnologia avanzata dei Romani. I conflitti in questo periodo erano spesso di natura più feudale, coinvolgendo cavalieri e signori locali, e le battaglie erano spesso più piccole e disperse. La guerra si concentrava più sugli assedi ai castelli e sulle incursioni che su grandi battaglie campali.
Nel XV secolo, con l'inizio del Rinascimento e la formazione dei primi Stati nazionali moderni, si assiste a una nuova trasformazione della guerra. L'innovazione tecnologica, in particolare l'introduzione dell'artiglieria e delle armi da fuoco, ha cambiato le dinamiche della guerra. L'organizzazione militare è diventata più centralizzata e strutturata, con eserciti permanenti comandati dallo Stato.
Anche lo Stato moderno ha svolto un ruolo importante nella trasformazione della guerra. Gli Stati nazionali hanno iniziato ad assumersi la responsabilità della difesa e della sicurezza dei propri cittadini. Ciò ha portato alla creazione di burocrazie militari, di sistemi di reclutamento e addestramento e di un'infrastruttura logistica a supporto degli eserciti permanenti. Lo Stato moderno ha anche permesso di mobilitare risorse su scala molto più ampia di quanto fosse possibile nei precedenti sistemi feudali. Questi cambiamenti hanno avuto una profonda influenza sulla natura della guerra e hanno gettato le basi per la guerra come la conosciamo oggi.
L'influenza della guerra sulla modernità politica[modifier | modifier le wikicode]
Se si considera la lunga storia dell'umanità, la guerra come la intendiamo oggi è un fenomeno relativamente recente. La sua presenza è strettamente legata all'emergere e allo sviluppo di strutture sociali e politiche più complesse. Risalendo all'età della pietra, troviamo poche prove di violenza organizzata su larga scala. La comparsa della guerra è generalmente associata all'avvento della civiltà, iniziata con la rivoluzione neolitica, quando gli esseri umani iniziarono a stabilirsi e a creare società più organizzate. Con la comparsa delle prime città-stato, intorno al 5000 a.C., la guerra divenne un fenomeno più comune, poiché queste entità politiche competevano per il territorio e le risorse. La guerra assunse una forma più organizzata e strutturata, con eserciti permanenti e una strategia militare. Lo sviluppo della guerra moderna a partire dal XVII secolo coincide con l'emergere dello Stato moderno. Con maggiori risorse e una struttura amministrativa centralizzata, gli Stati nazionali sono stati in grado di condurre guerre su una scala e con un'intensità senza precedenti.
La storia della guerra è anche la storia dello Stato. Da un lato, la minaccia della guerra può incoraggiare la creazione di Stati. Di fronte a vicini ostili, le comunità possono scegliere di unirsi sotto un'unica autorità politica per difendersi. Lo Stato moderno è spesso nato da questo processo, come dimostra la famosa frase di Thomas Hobbes: "L'uomo è un lupo per l'uomo". D'altra parte, la conduzione della guerra richiede un'organizzazione e un coordinamento su larga scala. Gli Stati hanno fornito questa struttura, radunando eserciti, imponendo tasse per finanziare le campagne militari e stabilendo strategie e politiche militari. In tempo di guerra, gli Stati hanno spesso aumentato il loro potere e la loro portata, sia sui propri cittadini sia sul territorio che controllano. Infine, le guerre hanno spesso cambiato la forma e la natura degli Stati. I conflitti possono portare alla dissoluzione o alla creazione di nuovi Stati, come dimostra la storia del XX secolo, che ha visto la fine di molti imperi coloniali e la creazione di nuovi Stati nazionali. È difficile comprendere la storia dello Stato senza considerare il ruolo della guerra e viceversa.
La guerra e lo Stato moderno sono profondamente legati nella storia politica. Questa relazione è fondamentale per comprendere l'evoluzione delle società umane e la forma che assume il conflitto armato. Lo Stato moderno, così come si è sviluppato in Europa a partire dal XVII secolo, è caratterizzato dalla centralizzazione del potere e dal monopolio dell'uso legittimo della forza. La formazione degli Stati nazionali e l'emergere del sistema di Westfalia hanno coinciso con un'importante trasformazione della natura della guerra. In primo luogo, lo Stato moderno ha istituzionalizzato la guerra. Lo Stato ha il monopolio dell'uso legittimo della forza e la guerra è diventata un affare di Stato. Questo sviluppo ha portato alla creazione di regole e strutture per la conduzione della guerra. In secondo luogo, lo Stato moderno ha professionalizzato la guerra. Con la centralizzazione del potere, gli Stati hanno potuto mantenere eserciti permanenti. Questo ha portato a una guerra sempre più organizzata e tecnologicamente avanzata. In terzo luogo, lo Stato moderno ha nazionalizzato la guerra. Nelle società premoderne, le guerre erano spesso combattute da signori o capi che agivano in nome proprio. Con lo Stato moderno, la guerra è diventata una questione che riguarda l'intera nazione. La guerra, come la intendiamo oggi, è una creazione dello Stato moderno. È il prodotto dell'evoluzione dell'organizzazione politica umana e della concentrazione del potere nelle mani dello Stato.
Lo Stato, come lo intendiamo oggi, è una forma specifica di organizzazione politica emersa in un particolare periodo storico. Esistono molte altre forme di organizzazione politica che sono esistite nel corso della storia e che esistono ancora oggi in alcune parti del mondo. Gli imperi, ad esempio, erano una forma comune di organizzazione politica nell'antichità e fino all'inizio del XX secolo. Erano caratterizzati da un'autorità centrale (di solito un imperatore o un re) che dominava una serie di territori e popoli diversi. Le città-stato erano un'altra forma di organizzazione politica, particolarmente diffusa nell'antica Grecia e nell'Italia rinascimentale. In questo sistema, una città e il suo territorio circostante costituivano un'entità politica indipendente. Anche le colonie sono una forma di organizzazione politica, anche se spesso sotto il dominio di un'altra entità politica (come un impero o uno Stato). Le colonie erano particolarmente comuni durante l'epoca dell'imperialismo europeo, dal XVI al XX secolo. Detto questo, lo Stato è una forma specifica e relativamente recente di organizzazione politica, ma ha avuto una profonda influenza sulla natura della guerra e sul modo in cui viene condotta. Ecco perché lo studio dello Stato è così importante per comprendere la guerra moderna.
Lo Stato è spesso visto come una struttura necessaria per garantire la stabilità sociale, la sicurezza, il rispetto della legge e la fornitura di servizi pubblici essenziali come l'istruzione, la sanità, i trasporti, ecc. Tuttavia, questa percezione positiva dello Stato non deve impedirci di comprendere gli aspetti più complessi e talvolta problematici della sua esistenza. Un aspetto riguarda il monopolio della violenza legittima dello Stato, secondo la teoria sociologica classica di Max Weber. Questo monopolio permette allo Stato di mantenere l'ordine e di far rispettare la legge, ma anche di fare la guerra. Il fatto che la guerra sia generalmente condotta dagli Stati, e che sia intrinsecamente legata alla nascita e allo sviluppo dello Stato moderno, ci ricorda che lo Stato non è solo una forza di stabilità e benessere, ma può anche essere fonte di violenza e conflitto. Questo è un aspetto che dobbiamo tenere presente quando pensiamo allo Stato e al suo ruolo nella società. La guerra, la violenza e il conflitto non sono semplici aberrazioni, ma parte integrante della natura dello Stato. Ecco perché la comprensione della guerra è così essenziale per capire lo Stato.
Una delle funzioni principali dello Stato è quella di mantenere la pace e l'ordine all'interno dei suoi confini. Ciò avviene attraverso una serie di istituzioni, come le forze di polizia e il sistema giudiziario, che hanno il compito di far rispettare la legge e di prevenire o risolvere i conflitti tra i cittadini. Lo Stato è spesso visto come il garante della sicurezza e della stabilità e questo è uno dei motivi per cui i cittadini accettano di cedere ad esso parte della loro libertà e del loro potere. Tuttavia, la situazione è molto diversa al di là dei confini dello Stato. A livello internazionale, non esiste un'entità paragonabile a uno Stato che sia in grado di far rispettare la legge e l'ordine. Le relazioni tra gli Stati sono spesso descritte come in uno stato di "anarchia", nel senso che non esiste un'autorità centrale superiore. Questo può portare a conflitti e guerre, poiché ogni Stato ha la libertà di agire come meglio crede per difendere i propri interessi.
Lo Stato svolge un ruolo importante nel mantenimento della pace internazionale. In quanto partecipante a organizzazioni internazionali come l'ONU, l'OMC, la NATO e altre, lo Stato contribuisce a formulare e rispettare norme e regole internazionali, essenziali per prevenire e gestire i conflitti tra le nazioni. Inoltre, firmando e rispettando i trattati internazionali, gli Stati partecipano attivamente alla creazione di un ordine mondiale basato su regole, che contribuisce alla stabilità e alla sicurezza internazionale. In questo senso, lo Stato è visto come un attore essenziale della civiltà moderna, capace di stabilire e mantenere l'ordine, promuovere la cooperazione ed evitare il caos e l'anarchia. Questo è generalmente visto come uno sviluppo positivo rispetto ai periodi storici precedenti, quando la violenza e la guerra erano mezzi più comuni per risolvere i conflitti.
Una delle principali giustificazioni dell'esistenza dello Stato è la sua capacità di mantenere l'ordine e prevenire il caos. Il concetto di "monopolio della violenza legittima" è fondamentale in questo caso. Secondo questo concetto, formulato dal sociologo tedesco Max Weber, lo Stato ha il diritto esclusivo di usare, minacciare o autorizzare la forza fisica entro i limiti del suo territorio. In questo senso, lo Stato è spesso visto come un antidoto allo "stato di natura" hobbesiano, dove, in assenza di un potere centralizzato, la vita sarebbe "solitaria, povera, brutale e breve". Lo Stato è quindi spesso visto come l'attore che permette di mantenere l'ordine, prevenire il caos e l'anarchia e garantire la sicurezza dei suoi cittadini.
Uno Stato efficace è generalmente in grado di mantenere l'ordine pubblico, garantire la sicurezza dei suoi cittadini e fornire servizi pubblici essenziali, contribuendo così alla stabilità sociale e alla pace. Tuttavia, nelle aree in cui lo Stato è debole, assente o inefficace, possono verificarsi situazioni di caos. Le zone di conflitto, ad esempio, sono spesso caratterizzate dall'assenza di uno Stato funzionante in grado di mantenere l'ordine pubblico. Allo stesso modo, negli Stati falliti o in via di fallimento, l'incapacità di fornire sicurezza e servizi di base può portare ad alti livelli di violenza, criminalità e instabilità.
La violenza di massa, come il genocidio, è un fenomeno che è stato notevolmente facilitato dall'emergere dello Stato moderno e della tecnologia industriale. L'efficienza burocratica, la capacità di mobilitare e controllare vaste risorse, caratteristiche tipiche degli Stati moderni, possono purtroppo essere abusate per scopi distruttivi. Prendiamo l'esempio della Shoah durante la Seconda guerra mondiale. Lo sterminio sistematico e su larga scala degli ebrei e di altri gruppi da parte dei nazisti è stato reso possibile dal moderno Stato industriale e dai suoi apparati burocratici. Allo stesso modo, il genocidio ruandese del 1994, in cui sono stati uccisi circa 800.000 Tutsi nel giro di pochi mesi, è stato perpetrato su vasta scala e con un'efficienza terrificante in gran parte grazie alla mobilitazione di strutture e risorse statali.
Le due guerre mondiali sono esempi tipici di guerra totale, un concetto che descrive un conflitto in cui le nazioni coinvolte mobilitano tutte le loro risorse economiche, politiche e sociali per condurre la guerra, e in cui la distinzione tra civili e combattenti militari è sfumata, esponendo l'intera popolazione agli orrori della guerra. La Prima guerra mondiale ha introdotto l'industrializzazione e la meccanizzazione della guerra su una scala senza precedenti, con l'uso massiccio di nuove tecnologie come l'artiglieria pesante, gli aerei, i carri armati e i gas velenosi. La violenza di questa guerra fu amplificata dal coinvolgimento totale delle nazioni belligeranti, con le loro economie e società completamente mobilitate per lo sforzo bellico. La Seconda guerra mondiale intensificò ulteriormente il concetto di guerra totale. Fu caratterizzata dal bombardamento massiccio di intere città, dallo sterminio sistematico delle popolazioni civili e dall'uso di armi nucleari. Questa guerra vide anche l'uso su larga scala della propaganda, lo sfruttamento dell'economia di guerra e la massiccia mobilitazione della forza lavoro. La guerra totale è un'altra manifestazione del modo in cui la modernità e lo Stato moderno hanno permesso l'emergere di nuove forme di violenza su vasta scala.
Il XX secolo è stato segnato da una violenza senza precedenti, come risultato di due guerre mondiali, numerosi conflitti regionali, genocidi e regimi totalitari. Questo livello di violenza è spesso attribuito a una combinazione di fattori, tra cui l'emergere di potenti Stati moderni, la disponibilità di armi di distruzione di massa e ideologie estreme. Le guerre mondiali hanno causato decine di milioni di morti. Inoltre, altri conflitti come la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, il genocidio armeno, l'Olocausto, il genocidio ruandese e le purghe staliniane e maoiste hanno causato la morte di altri milioni di persone. Anche la violenza politica interna, spesso perpetrata da regimi totalitari, è stata una delle principali fonti di violenza nel XX secolo. Regimi come quello di Stalin in Unione Sovietica, di Mao in Cina, di Pol Pot in Cambogia e molti altri hanno usato la violenza politica per eliminare gli oppositori, raggiungere obiettivi ideologici o mantenere il potere. In breve, la violenza del XX secolo dimostra quanto la modernità e lo Stato moderno siano stati a doppio taglio: da un lato, hanno permesso un livello di sviluppo, prosperità e stabilità senza precedenti in molte parti del mondo; dall'altro, hanno permesso un livello di violenza e distruzione senza precedenti.
Lo Stato moderno, con la sua sovranità, il suo territorio definito, la sua popolazione e il suo governo, dovrebbe offrire ai suoi cittadini protezione dalla violenza. Dovrebbe garantire ordine e stabilità attraverso lo stato di diritto, un'amministrazione efficiente e la protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini. Tuttavia, la storia del XX secolo dimostra che lo Stato moderno può anche essere una delle principali fonti di violenza. Guerre mondiali, conflitti regionali, genocidi ed epurazioni politiche sono stati in gran parte perpetrati o favoriti dagli Stati moderni. Queste forme di violenza sono spesso legate all'esercizio del potere statale, alla difesa dell'ordine costituito o all'applicazione di determinate ideologie o politiche. Lo Stato moderno ha quindi due facce. Da un lato, può garantire ordine, sicurezza e stabilità e fornire un quadro di riferimento per la prosperità e lo sviluppo. Dall'altro, può essere una fonte importante di violenza e oppressione, soprattutto quando viene utilizzato a fini bellici, di repressione politica o per raggiungere determinati obiettivi ideologici. Comprendere questo paradosso è importante per capire la complessità delle sfide politiche e sociali che dobbiamo affrontare nel mondo moderno.
L'evoluzione della guerra nella storia[modifier | modifier le wikicode]
La guerra come costruttore dello Stato moderno[modifier | modifier le wikicode]
Per studiare la guerra, dobbiamo innanzitutto concentrarci sui suoi legami con lo Stato moderno come organizzazione politica. Vedremo come la guerra di oggi sia plasmata da e attraverso l'emergere dello Stato moderno. Inizieremo con il constatare che la guerra è una questione di Stato. Per introdurre l'idea che la guerra è legata alla costruzione stessa dello Stato e all'emergere dello Stato come forma di organizzazione politica in Europa a partire dalla fine del Medioevo, il modo migliore per farlo è quello indicato dal socio-storico Charles Tilly nel suo articolo War Making and State Making as Organised Crime, che sviluppa l'idea di war making/state making: è facendo la guerra che si è creato lo Stato, e viceversa.
In "War Making and State Making as Organized Crime", Charles Tilly offre una provocatoria analisi storico-sociale della costruzione dello Stato moderno in Europa occidentale. Sostiene che i processi di costruzione dello Stato e di guerra sono intrinsecamente legati e paragona gli Stati a organizzazioni criminali per evidenziare gli aspetti coercitivi e di sfruttamento della loro formazione. Secondo Tilly, la formazione degli Stati moderni è in gran parte guidata dagli sforzi delle élite al potere per mobilitare le risorse necessarie alla guerra. A tal fine, queste élite ricorrono a mezzi come la tassazione, la coscrizione e l'espropriazione, che possono essere paragonati a forme di racket ed estorsione. Inoltre, Tilly sostiene che la costruzione dello Stato è stata facilitata anche dalla monopolizzazione dell'uso della forza legittima. In altre parole, i governanti cercavano di eliminare o subordinare tutte le altre fonti di potere e autorità nel loro territorio, compresi i signori feudali, le corporazioni, le corporazioni e le bande armate. Questo processo ha spesso comportato l'uso della violenza, della coercizione e della manipolazione politica. Infine, Tilly sottolinea che la costruzione dello Stato richiedeva anche la costruzione di un consenso sociale, o almeno l'acquiescenza delle popolazioni, attraverso lo sviluppo di un'identità nazionale, la creazione di istituzioni sociali e politiche e la fornitura di servizi e protezioni. Questa analisi offre una prospettiva critica e critica sulla costruzione degli Stati moderni, evidenziando le loro radici violente e coercitive e sottolineando il loro ruolo chiave nella strutturazione delle nostre società contemporanee.
La concezione dello Stato moderno, così come lo conosciamo oggi, si basa principalmente sul modello europeo, emerso durante il periodo rinascimentale e moderno, tra il XIV e il XVII secolo. Questa evoluzione è stata caratterizzata dalla centralizzazione del potere politico, dalla formazione di confini nazionali definiti, dallo sviluppo di una burocrazia amministrativa e dalla monopolizzazione dell'uso della forza legittima da parte dello Stato. Tuttavia, è importante notare che in altre parti del mondo esistono altri modelli politici, basati su traiettorie storiche, culturali, sociali ed economiche diverse. Ad esempio, in alcune società la struttura politica può essere più decentralizzata o basata su principi diversi, come la reciprocità, la gerarchia o l'uguaglianza. Inoltre, il processo di esportazione del modello statale europeo, in particolare attraverso la colonizzazione e, più recentemente, la costruzione dello Stato o della nazione, ha spesso incontrato resistenza e può aver portato a conflitti e tensioni. Ciò è spesso dovuto al fatto che questi processi possono non tenere conto delle realtà locali e possono talvolta essere percepiti come forme di imposizione culturale o politica.
Nel suo articolo "War Making and State Making as Organized Crime", Charles Tilly propone un quadro di riferimento per comprendere il processo di formazione degli Stati, concentrandosi in particolare sull'Europa tra il XV e il XIX secolo. Tilly vede l'emergere dello Stato come il prodotto di due dinamiche interconnesse: il war making e lo state making.
- Fare la guerra: Tilly ipotizza che gli Stati siano stati plasmati dalla costante necessità di preparare, condurre e finanziare la guerra. Le guerre, in particolare nel contesto europeo, sono state fattori chiave nello sviluppo delle strutture statali, non da ultimo a causa delle risorse necessarie per combatterle.
- Creazione dello Stato: è il processo attraverso il quale si consolida il potere centrale di uno Stato. Per Tilly, si tratta di controllare e neutralizzare i rivali interni (in particolare i signori feudali) e di imporre la propria autorità sull'intero territorio sotto il suo controllo.
Questi due processi sono strettamente collegati, in quanto le guerre forniscono l'impulso per il consolidamento dello Stato e sono esse stesse rese possibili da questo consolidamento. Per esempio, per finanziare le guerre, gli Stati hanno dovuto creare sistemi fiscali e amministrativi più efficienti, che hanno rafforzato la loro autorità.
La guerra e lo Stato moderno[modifier | modifier le wikicode]
Il sistema feudale era una complessa struttura di relazioni tra i signori e il re, basata sulla proprietà della terra (o "feudi") e sulla fedeltà. I signori avevano una grande autonomia sulle loro terre ed erano generalmente responsabili della sicurezza e della giustizia nelle loro terre. In cambio del loro feudo, dovevano giurare fedeltà al re e fornirgli supporto militare quando ne aveva bisogno. Questo sistema di vassallaggio costituiva la base del potere durante il Medioevo. Tuttavia, con l'avvento dello Stato moderno, questo sistema fu gradualmente sostituito. Il consolidamento dello Stato è stato accompagnato da uno sforzo di centralizzazione del potere, che spesso ha comportato l'abolizione o la riduzione del potere dei signori feudali. Un elemento chiave di questo processo fu la necessità di finanziare e sostenere le guerre. I re iniziarono a sviluppare strutture amministrative e fiscali per raccogliere fondi e reclutare direttamente gli eserciti, anziché affidarsi ai signori feudali. Questo rafforzò la loro autorità e permise la formazione di Stati più centralizzati e burocratici.
Secondo Charles Tilly, la guerra è stata una potente forza trainante per la formazione dello Stato moderno. Nel Medioevo, la competizione tra i signori per espandere il proprio territorio e accrescere il proprio potere portava spesso al conflitto. I signori erano costantemente in guerra tra loro, cercando di ottenere il controllo delle rispettive terre e risorse. Inoltre, questi conflitti locali erano spesso collegati a conflitti più ampi tra regni. I re avevano bisogno di una solida base di potere per sostenere i loro sforzi bellici, il che li portava a cercare di rafforzare il controllo sui loro signori. Queste dinamiche crearono una pressione costante per una maggiore centralizzazione e un'organizzazione più efficiente. I re svilupparono amministrazioni più sofisticate e sistemi fiscali più efficienti per sostenere i loro sforzi bellici. Allo stesso tempo, cercarono di limitare il potere dei feudatari e di affermare la propria autorità. Questi processi gettarono le basi dello Stato moderno.
Norbert Elias, sociologo tedesco, ha sviluppato il concetto di "lotta eliminatoria" nella sua opera "Il processo di civilizzazione". In questo contesto, si riferisce a una competizione in cui i giocatori si eliminano l'un l'altro finché non ne rimangono solo pochi, o addirittura uno. Nel contesto della formazione degli Stati, questa può essere vista come una metafora del modo in cui i signori feudali combattevano per il potere e il territorio durante il Medioevo. Nel corso del tempo, alcuni signori sono stati eliminati, sia per sconfitta militare sia per assimilazione a entità più grandi. Questo processo di eliminazione contribuì alla centralizzazione del potere e alla formazione dello Stato moderno.
Nel corso dei secoli, molti re francesi rafforzarono gradualmente il loro potere, sottraendo territori alla nobiltà feudale e consolidando l'autorità centrale. Questi sforzi furono spesso sostenuti da alleanze matrimoniali strategiche, conquiste militari, accordi politici e, in alcuni casi, dall'estinzione naturale o forzata di alcune linee nobiliari. Luigi XI, in particolare, svolse un ruolo cruciale in questo processo. Re dal 1461 al 1483, fu soprannominato "l'Universelle Aragne" o "il Ragno Universale" per la sua politica astuta e manipolatrice. Luigi XI si impegnò a fondo per centralizzare il potere reale, riducendo l'influenza dei grandi feudatari e istituendo un'amministrazione più efficiente e diretta in tutto il regno. Ciò contribuì alla formazione dello Stato moderno, con un potere centralizzato e un'amministrazione organizzata, che si sarebbe rafforzato nel corso dei secoli, in particolare con Francesco I e Luigi XIV, il "Re Sole".
La Francia e la Gran Bretagna sono spesso citate come esempi tipici della nascita dello Stato moderno. In Francia, i re hanno gradualmente accentrato il potere, creando un'amministrazione più diretta ed efficiente. L'apogeo di questa centralizzazione fu probabilmente raggiunto durante il regno di Luigi XIV, che dichiarò "Io sono lo Stato" e governò direttamente dal suo palazzo di Versailles. Tuttavia, questo processo fu intervallato da periodi di conflitto e di rivolta, come la Fronde e, successivamente, la Rivoluzione francese. La Gran Bretagna, invece, ha seguito un percorso leggermente diverso verso la formazione dello Stato moderno. Il re Enrico VIII consolidò il potere reale istituendo la Chiesa d'Inghilterra e abolendo i monasteri, ma la Gran Bretagna vide anche un forte movimento per limitare il potere reale. Questo culminò nella Gloriosa Rivoluzione del 1688 e nell'istituzione di un sistema costituzionale in cui il potere era condiviso tra il Re e il Parlamento. In entrambi i casi, la guerra ha giocato un ruolo importante nella formazione dello Stato. La necessità di radunare eserciti, di imporre tasse per finanziare le guerre e di mantenere l'ordine interno contribuì notevolmente alla centralizzazione del potere e alla creazione di strutture amministrative efficienti.
La concorrenza esterna, soprattutto a partire dal Rinascimento e durante l'età moderna, è stata una forza motrice importante nella formazione degli Stati e nella strutturazione del sistema internazionale come lo conosciamo oggi. Ciò si può notare nello sviluppo della diplomazia, delle alleanze e dei trattati, delle guerre per la conquista e il controllo dei territori e persino dell'espansione coloniale. Inoltre, ha portato a una più chiara definizione dei confini nazionali e al riconoscimento della sovranità degli Stati. In particolare, il coinvolgimento di Luigi XI e dei suoi successori nelle guerre in Italia e contro l'Inghilterra ebbe un ruolo importante nel consolidamento della Francia come Stato e nella definizione dei suoi confini e interessi nazionali. Allo stesso modo, anche la competizione tra le potenze europee per i territori all'estero durante l'epoca della colonizzazione ha contribuito a plasmare il sistema internazionale.
Le ambizioni imperiali di governanti come Luigi XI erano in parte motivate dal desiderio di consolidare il proprio potere e la propria autorità, sia all'interno che all'esterno. Avevano bisogno di risorse per condurre guerre, il che significava spesso esigere tasse più alte dai loro sudditi. Queste guerre avevano spesso anche una dimensione religiosa, con l'idea di riunificare il mondo cristiano. Man mano che questi regni si sviluppavano e iniziavano a scontrarsi tra loro, iniziava a prendere forma un sistema internazionale. Fu un processo lento e spesso conflittuale, con molte guerre e conflitti politici. Col tempo, però, questi Stati hanno iniziato a riconoscere la sovranità reciproca, a stabilire regole per le interazioni internazionali e a sviluppare istituzioni per facilitare queste interazioni.
Tutto ciò ha portato alla formazione di un sistema di Stati nazionali interconnessi, in cui ogni Stato ha i propri interessi e obiettivi, ma anche un certo obbligo di rispettare la sovranità degli altri Stati. Questo è il fondamento del sistema internazionale che abbiamo oggi, anche se le sue specificità si sono evolute nel tempo.
Il ruolo della guerra nel sistema interstatale[modifier | modifier le wikicode]
Per fare la guerra (war-making), uno Stato deve mobilitare risorse significative. Queste includono risorse materiali, come il denaro per finanziare l'esercito e comprare le armi, il cibo per nutrire l'esercito e i materiali per costruire fortificazioni e altre infrastrutture militari. Servono anche risorse umane, come i soldati per combattere e i lavoratori per produrre i beni necessari. Per ottenere queste risorse, lo Stato deve essere in grado di esercitare un controllo effettivo sul suo territorio e sui suoi abitanti. È qui che entra in gioco la creazione dello Stato. Lo Stato deve istituire sistemi di tassazione efficaci per raccogliere il denaro necessario a finanziare la guerra. Deve anche essere in grado di reclutare o arruolare soldati, il che può richiedere sforzi per instillare un senso di lealtà o di dovere verso lo Stato. Inoltre, deve essere in grado di mantenere l'ordine e risolvere i conflitti all'interno dei propri confini, in modo da potersi concentrare sulla guerra all'esterno. La guerra e la costruzione dello Stato sono quindi intimamente legate. L'una richiede l'altra e le due cose si rafforzano a vicenda. Come ha scritto Charles Tilly, "gli Stati fanno le guerre e le guerre fanno gli Stati".
La necessità di fare la guerra ha portato gli Stati a sviluppare una burocrazia efficiente in grado di raccogliere risorse e organizzare un esercito. Questo processo ha rafforzato la capacità dello Stato di governare il suo territorio e i suoi abitanti, in altre parole la sua sovranità. Per registrare la popolazione, riscuotere le tasse e reclutare i soldati, lo Stato doveva creare un'amministrazione in grado di gestire questi compiti. Ciò comportava lo sviluppo di sistemi di registrazione delle informazioni sugli abitanti, la definizione di leggi sulle tasse e sulla coscrizione e la creazione di organismi per l'applicazione di tali leggi. Con il tempo, questi sistemi burocratici si sono evoluti diventando sempre più efficienti e sofisticati. Inoltre, contribuirono a rafforzare l'autorità dello Stato, garantendo che la sua legittimità fosse accettata dal popolo. Le persone erano più inclini a pagare le tasse e a servire nell'esercito se credevano che lo Stato avesse il diritto di chiedere loro di farlo. La guerra ha svolto un ruolo centrale nel processo di costruzione dello Stato, non solo incoraggiando lo sviluppo di una burocrazia efficiente, ma anche rafforzando l'autorità e la legittimità dello Stato.
Secondo Charles Tilly, lo Stato moderno si è sviluppato attraverso un processo di lungo periodo noto come "war making" e "state making". Questa teoria sostiene che le guerre sono state la principale forza motrice della crescita del potere e dell'autorità dello Stato nella società. La teoria di Tilly suggerisce che lo Stato moderno si è formato in un contesto di conflitto e violenza, dove la capacità di fare la guerra e di controllare efficacemente il territorio erano fattori chiave per la sopravvivenza e il successo dello Stato.
Dopo la fine del Medioevo, l'Europa entrò in un periodo di intensa competizione tra gli Stati nazionali emergenti. Questi Stati cercavano di estendere la loro influenza e di affermare il loro dominio sugli altri, il che spesso portava a guerre. Uno degli esempi più emblematici di quest'epoca è Napoleone Bonaparte. Come imperatore di Francia, Napoleone cercò di stabilire il dominio francese sul continente europeo, creando un impero che si estendeva dalla Spagna alla Russia. Il suo tentativo di creare un impero senza confini e inclusivo era in realtà un tentativo di sottomettere le altre nazioni alla volontà della Francia. Tuttavia, questo periodo di rivalità e guerra vide anche il consolidamento dello Stato nazionale come principale forma di organizzazione politica. Gli Stati rafforzarono il loro controllo sul territorio, centralizzarono la loro autorità e svilupparono istituzioni burocratiche per amministrare i loro affari. L'emergere dello Stato nazionale moderno nel periodo post-medievale è stato in gran parte il prodotto delle ambizioni imperiali e delle rivalità interstatali. Questi fattori hanno portato alla creazione di un sistema interstatale basato sulla sovranità e sulla guerra come mezzo per risolvere i conflitti. Questo sviluppo ha avuto un profondo impatto sul mondo di oggi.
Dopo un periodo di guerre e conflitti intensi, si stabilì un certo equilibrio di potere tra gli Stati nazionali europei. Questo equilibrio, spesso definito "equilibrio di potenza", è diventato un principio fondamentale della politica internazionale. L'equilibrio di potere presuppone che la sicurezza nazionale sia garantita quando le capacità militari ed economiche sono distribuite in modo tale che nessuno Stato sia in grado di dominare gli altri. Ciò incoraggia la cooperazione e la competizione pacifica e, in teoria, aiuta a prevenire le guerre scoraggiando le aggressioni. Questo processo ha portato anche alla stabilizzazione dei confini. Gli Stati hanno finalmente riconosciuto e rispettato i confini reciproci, il che ha contribuito ad allentare le tensioni e a mantenere la pace.
Da qui è emersa l'idea di sovranità, ovvero l'idea che l'autorità sul territorio fosse divisa tra aree su cui venivano esercitate sovranità che si escludevano a vicenda. La sovranità è un principio fondamentale del sistema internazionale moderno, basato sul concetto che ogni Stato ha un'autorità suprema ed esclusiva sul proprio territorio e sulla propria popolazione. Questa autorità comprende il diritto di fare leggi, di farle rispettare e di punire chi le infrange, di controllare i confini, di intrattenere relazioni diplomatiche con altri Stati e, se necessario, di dichiarare guerra. La sovranità è intrinsecamente legata alla nozione di Stato nazionale ed è fondamentale per comprendere le dinamiche delle relazioni internazionali. Si ritiene che ogni Stato abbia il diritto di gestire i propri affari interni senza interferenze esterne, diritto riconosciuto dagli altri Stati del sistema internazionale.
In definitiva, il principio di sovranità ha dato vita a un universalismo dello Stato nazionale che non era quello dell'Impero, poiché il principio di sovranità è stato riconosciuto da tutti come principio organizzatore del sistema internazionale. Il principio di sovranità e di uguaglianza tra tutti gli Stati è il fondamento del sistema internazionale e delle Nazioni Unite. Ciò significa che, in teoria, ogni Stato, grande o piccolo, ricco o povero, ha un solo voto, ad esempio all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ciò deriva dal principio dell'uguaglianza sovrana, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. L'articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite afferma che l'Organizzazione si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri.
L'idea delle Nazioni Unite nasce dall'idea del principio di sovranità come organizzatore del sistema internazionale. Il sistema interstatale che si stava creando era organizzato intorno all'idea che esistesse una logica di equilibrio interno, in cui lo Stato amministrava un territorio, cioè la "polizia", e di equilibrio esterno, in cui erano gli Stati stessi a regolare i loro affari. Questa distinzione è centrale per il concetto di sovranità statale. È lo Stato che ha la prerogativa e il dovere di gestire gli affari interni, compresa l'attuazione delle leggi, garantire l'ordine pubblico, fornire servizi pubblici e amministrare la giustizia. Questa è la cosiddetta sovranità interna. La sovranità esterna è il diritto e la capacità di uno Stato di agire autonomamente sulla scena internazionale. Ciò include il diritto di entrare in relazione con altri Stati, di firmare trattati internazionali, di partecipare a organizzazioni internazionali e di condurre la propria politica estera secondo i propri interessi.
Una volta costituiti, tutti questi Stati devono comunicare tra loro. Poiché ciascuno di essi deve sopravvivere come Stato e ci sono altri Stati, come faranno a comunicare? Se partiamo dal principio che la guerra è un'istituzione, serve proprio a questo. La guerra, in quanto istituzione, è stata un modo per gli Stati di comunicare tra loro. Questo non significa necessariamente che la guerra sia auspicabile o inevitabile, ma certamente ha svolto un ruolo nella formazione degli Stati e nella definizione delle relazioni tra di essi. Nella storia europea, ad esempio, le guerre sono state spesso utilizzate per risolvere dispute su territorio, potere, risorse o ideologia. I risultati di queste guerre hanno spesso portato a cambiamenti nei confini, nelle alleanze e nell'equilibrio di potere tra gli Stati.
Secondo John Vasquez, la guerra è una modalità appresa di decisione politica attraverso la quale due o più unità politiche assegnano beni materiali o beni di valore simbolico sulla base di una competizione violenta. La definizione di John Vasquez sottolinea l'aspetto di competizione violenta della guerra. Secondo questa visione, la guerra è un meccanismo attraverso il quale le unità politiche, di solito gli Stati, risolvono i loro disaccordi o rivalità. Ciò può riguardare questioni di potere, territorio, risorse o ideologie. Questa definizione sottolinea una visione della guerra saldamente radicata nella tradizione di pensiero realista delle relazioni internazionali, che vede la politica internazionale come una lotta di tutti contro tutti, dove il conflitto è inevitabile e la guerra è uno strumento naturale della politica.
Ci stiamo allontanando dall'idea della guerra come qualcosa di anarchico o violento; la guerra è qualcosa che è stato sviluppato nella sua concezione moderna per risolvere le controversie tra gli Stati, è un meccanismo di risoluzione dei conflitti. Ciò sembra controintuitivo perché la guerra è generalmente associata all'anarchia e alla violenza. Tuttavia, nel contesto delle relazioni internazionali e della teoria politica, la guerra può essere intesa come un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra Stati, nonostante le sue tragiche conseguenze. Questa prospettiva non cerca di minimizzare la violenza e la distruzione causate dalla guerra, ma piuttosto di capire come e perché gli Stati scelgono di usare la forza militare per risolvere i loro disaccordi. Secondo questa prospettiva, la guerra non è uno stato di caos, ma una forma di condotta politica regolata da determinate norme, regole e strategie. Per questo motivo la guerra viene spesso descritta come una "continuazione della politica con altri mezzi" - una famosa frase del teorico militare Carl von Clausewitz. Ciò significa che la guerra viene utilizzata dagli Stati come strumento per raggiungere obiettivi politici quando altri mezzi falliscono.
La guerra può essere intesa come un meccanismo estremo di risoluzione dei conflitti, utilizzato quando i disaccordi non possono essere risolti con altri mezzi. Questo processo richiede la mobilitazione di risorse significative, come le forze armate, finanziate dal gettito fiscale degli Stati belligeranti. L'obiettivo finale è il raggiungimento di un accordo, spesso determinato dall'esito dei combattimenti. Tuttavia, la vittoria non significa necessariamente una soluzione definitiva del conflitto a favore del vincitore. L'esito della guerra può portare a compromessi, cambiamenti politici e territoriali e talvolta anche alla nascita di nuove dispute.
La guerra può essere vista da diversi punti di vista, a seconda della prospettiva adottata. Vista da una prospettiva umanitaria, è spesso considerata in termini di sofferenza e perdita di vite umane che provoca. Da questa prospettiva, emergono domande sulla protezione dei civili, sui diritti umani e sulle conseguenze per lo sviluppo socio-economico delle aree colpite. Da un punto di vista giuridico, la guerra comporta un complesso insieme di norme e leggi internazionali, tra cui il diritto umanitario internazionale, il diritto di guerra e vari accordi e trattati internazionali. Queste norme mirano a limitare l'impatto della guerra, in particolare proteggendo i civili e vietando alcune pratiche e armi. Tuttavia, nonostante queste norme, la posta in gioco legale rimane alta, soprattutto quando si tratta di determinare la legittimità di un intervento armato, di valutare le responsabilità in caso di violazione del diritto internazionale e di gestire le conseguenze postbelliche, come la giustizia di transizione e la ricostruzione.
In breve, la guerra, come meccanismo di risoluzione dei conflitti, è un fenomeno complesso che coinvolge questioni umanitarie, politiche, economiche e legali. Questo corso si pone in un'ottica di scienza politica per analizzare l'origine di questo fenomeno e il suo utilizzo. Non siamo interessati alla dimensione normativa della guerra.
Ci avviciniamo all'idea che la guerra è un meccanismo di risoluzione dei conflitti e che quindi, se la strategia ha un fine, il fine e l'obiettivo di tale strategia è la pace. Il fine ultimo della strategia militare è spesso quello di stabilire o ristabilire la pace, anche se il percorso per raggiungerla comporta l'uso della forza. Questa idea ha origine negli scritti di diversi pensatori militari, il più famoso dei quali è forse Carl von Clausewitz. Nel suo libro "Sulla guerra", Clausewitz descriveva la guerra come "la continuazione della politica con altri mezzi". Questa prospettiva suggerisce che la guerra non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere obiettivi politici, che possono includere l'instaurazione della pace. Inoltre, nella tradizione della teoria delle relazioni internazionali, la guerra è spesso vista come uno strumento che gli Stati possono utilizzare per risolvere le controversie quando non riescono a raggiungere un accordo con mezzi pacifici. Pertanto, sebbene la guerra sia un atto violento e distruttivo, può essere vista come parte di un processo più ampio volto a ripristinare la stabilità e la pace.
Le due cose sono collegate. Abbiamo un concetto in cui la pace è intimamente legata alla guerra e, soprattutto, la definizione di pace è intimamente legata alla guerra. La pace è intesa come assenza di guerra. È interessante vedere come l'obiettivo della strategia sia vincere e tornare a uno stato di pace. In realtà è la guerra a determinare questo stato. C'è una dialettica molto forte tra le due cose. Ci interessa il rapporto tra guerra e Stato, ma anche tra guerra e pace. Si tratta di una relazione fondamentale che non esamineremo oggi. In molti quadri teorici, la pace è definita in opposizione alla guerra. In altre parole, la pace è spesso concettualizzata come assenza di conflitto armato. Questa visione è chiamata "pace negativa", nel senso che la pace è definita da ciò che non è (cioè la guerra) piuttosto che da ciò che è. La strategia militare spesso mira a ripristinare questo stato di "pace negativa" vincendo la guerra o raggiungendo condizioni favorevoli alla fine del conflitto.
Parliamo di pace perché ciò che è importante è che nella concezione della guerra che si sta instaurando con l'emergere di questo sistema interstatale, cioè con gli Stati che si formano all'interno e competono tra loro all'esterno, la guerra non è fine a se stessa, l'obiettivo non è la condotta della guerra in sé, ma la pace; la guerra si fa per ottenere qualcosa. Questo è il punto di vista di Raymond Aron. Raymond Aron, filosofo e sociologo francese, è famoso per il suo lavoro sulla sociologia delle relazioni internazionali e sulla teoria politica. Secondo lui, la guerra non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere la pace. Ciò significa che la guerra è uno strumento politico, un mezzo utilizzato dagli Stati per raggiungere obiettivi specifici, generalmente allo scopo di risolvere i conflitti e raggiungere la pace. In questa prospettiva, la guerra è una forma estrema di diplomazia e di negoziazione tra Stati. È un'estensione della politica, attuata quando i mezzi pacifici non riescono a risolvere le controversie. È per questo motivo che Aron ha dichiarato che "la pace è il fine, la guerra è il mezzo".
Il concetto di guerra come meccanismo di risoluzione dei conflitti si basa sull'idea che la guerra sia uno strumento della politica, una forma di dialogo tra gli Stati. Vi si ricorre quando i mezzi pacifici di risoluzione dei conflitti sono falliti o quando gli obiettivi non possono essere raggiunti con altri mezzi. Da questo punto di vista, gli Stati usano la guerra per raggiungere i loro obiettivi strategici, che si tratti di proteggere i loro interessi territoriali, estendere la loro influenza o rafforzare la loro sicurezza. Questi obiettivi sono generalmente guidati da una strategia militare chiaramente definita, che mira a massimizzare l'efficacia dell'uso della forza riducendo al minimo le perdite e i costi.
L'approccio alla guerra di Carl von Clausewitz[modifier | modifier le wikicode]
Carl von Clausewitz, ufficiale prussiano dell'inizio del XIX secolo, ha svolto un ruolo decisivo nella teorizzazione della guerra. Scrisse "Sulla guerra" (Vom Kriege in tedesco), che è diventato uno dei testi più influenti sulla strategia militare e sulla teoria della guerra.
Carl von Clausewitz prestò servizio nell'esercito prussiano durante le guerre napoleoniche, che durarono dal 1803 al 1815. Durante questo periodo, acquisì una preziosa esperienza di combattimento e di strategia militare, che influenzò le sue teorie sulla guerra. Clausewitz partecipò a diverse importanti battaglie contro l'esercito di Napoleone e fu testimone dei drammatici cambiamenti nel modo di combattere le guerre all'inizio del XIX secolo. Fu in questo periodo che iniziò a sviluppare la sua teoria secondo cui la guerra è un'estensione della politica. Dopo la fine delle guerre napoleoniche, Clausewitz continuò a servire nell'esercito prussiano e iniziò a scrivere la sua opera principale, "Sulla guerra". Tuttavia, morì prima di poter completare l'opera, che fu pubblicata postuma dalla moglie.
Clausewitz disse che la guerra è "la continuazione della politica con altri mezzi". Questa citazione, probabilmente la più famosa di Clausewitz, esprime l'idea che la guerra è uno strumento della politica nazionale e che gli obiettivi militari devono essere guidati da obiettivi politici. In altre parole, la guerra è uno strumento politico, non un fine in sé. Clausewitz sottolineò anche l'importanza della "nebbia di guerra" e dell'"attrito" nella conduzione delle operazioni militari. Egli sosteneva che la guerra è intrinsecamente incerta e imprevedibile e che i comandanti e gli strateghi devono essere in grado di gestire queste incertezze. Nonostante la sua morte nel 1831, il pensiero di Clausewitz continua a esercitare una grande influenza sulla teoria militare e strategica. La sua opera è studiata nelle accademie militari di tutto il mondo e rimane un riferimento essenziale nel campo della strategia militare.
Clausewitz definisce la guerra come un atto di violenza volto a costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà. Si tratta di un quadro molto razionale, non della logica di un "pazzo di guerra". La guerra si combatte per ottenere qualcosa. Carl von Clausewitz concepiva la guerra come un atto di violenza volto a costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà. Secondo lui, la guerra non è un'impresa irrazionale o caotica, ma piuttosto uno strumento di politica, un mezzo razionale per perseguire gli obiettivi di uno Stato. Nella sua opera principale "Sulla guerra", Clausewitz sviluppa questa idea affermando che la guerra è semplicemente la continuazione della politica con altri mezzi. In altre parole, gli Stati usano la guerra per raggiungere obiettivi politici che non possono ottenere con mezzi pacifici.
Immaginiamo uno Stato che è un governo con l'obiettivo di acquisire terre fertili per migliorare la propria economia o la sicurezza alimentare. Poiché il suo vicino non è disposto a cedere volontariamente questa terra, lo Stato sceglie di ricorrere alla guerra per raggiungere il suo obiettivo. Se lo Stato belligerante vince, è probabile che venga redatto un trattato di pace per formalizzare il trasferimento della terra. Questo trattato potrebbe includere anche altre disposizioni, come indennità di guerra, accordi per le popolazioni sfollate e una promessa di non aggressione futura. L'obiettivo iniziale (l'acquisizione di terre fertili) è stato quindi raggiunto attraverso la guerra, utilizzata come strumento di politica.
Questa concezione della guerra, espressa da Clausewitz, evidenzia il fatto che la guerra è un'estensione della politica con altri mezzi. In questo contesto, la guerra è vista come uno strumento della politica, un'opzione che può essere utilizzata quando altri metodi, come la diplomazia o il commercio, non sono riusciti a risolvere i conflitti tra gli Stati.
È essenziale capire che, secondo Clausewitz, la guerra non è un'entità autonoma, ma piuttosto uno strumento di politica controllato e diretto dalle autorità politiche. In altre parole, la decisione di dichiarare guerra, così come la gestione e la conduzione della guerra, sono responsabilità dei leader politici. Gli obiettivi militari sono quindi subordinati a quelli politici. Nel pensiero clausewitziano, la guerra è un mezzo per raggiungere obiettivi politici che non possono essere raggiunti con altri metodi. Tuttavia, è sempre vista come una soluzione temporanea e non come uno stato permanente. La guerra non è quindi un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere un fine: l'obiettivo politico definito dallo Stato. Una volta raggiunto questo obiettivo, o quando non è più possibile raggiungerlo, la guerra finisce e si torna a uno stato di pace. Ecco perché la nozione di pace è intrinsecamente legata a quella di guerra: la guerra mira a creare un nuovo stato di pace più favorevole allo Stato che la conduce.
Il sistema westfaliano[modifier | modifier le wikicode]
Il sistema di Westfalia, che prende il nome dal Trattato di Westfalia che pose fine alla Guerra dei Trent'anni nel 1648, ha influenzato profondamente la struttura politica internazionale e la comprensione della guerra. Questa serie di trattati ha sancito il concetto di sovranità statale, stabilendo l'idea che ogni Stato ha l'autorità esclusiva sul proprio territorio e sulla propria popolazione, senza interferenze esterne. Inoltre, formalizzò l'idea di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. Per quanto riguarda la guerra, il sistema di Westfalia ha contribuito a formalizzarla come attività tra Stati, piuttosto che tra fazioni o individui. Inoltre, ha incoraggiato lo sviluppo di regole e norme che disciplinano la condotta della guerra, anche se questo processo è decollato nei secoli successivi con lo sviluppo del diritto internazionale umanitario. Così, mentre la guerra continuava a essere vista come uno strumento di politica estera, il sistema di Westfalia iniziò a introdurre vincoli e regole per il suo utilizzo. Questi vincoli furono rafforzati dallo sviluppo del diritto internazionale nei secoli successivi.
Hugo Grotius, noto anche come Hugo de Groot, fu una figura centrale nello sviluppo del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda le leggi di guerra e di pace. La sua opera più famosa, "De Jure Belli ac Pacis" ("Sul diritto di guerra e di pace"), pubblicata nel 1625, è considerata uno dei testi fondamentali del diritto internazionale. In quest'opera, Grozio cerca di definire un insieme di regole che disciplinano il comportamento degli Stati in tempo di guerra e di pace. Esamina in dettaglio quando la guerra è giustificata (jus ad bellum), come deve essere condotta (jus in bello) e come può essere ripristinata una pace giusta dopo il conflitto (jus post bellum).
Queste idee hanno avuto un'influenza significativa sul modo in cui la guerra viene percepita e condotta, introducendo il concetto che anche in guerra alcune azioni sono inaccettabili e che la condotta della guerra deve essere regolata da determinati principi etici e legali. I principi stabiliti da Grozio hanno continuato a evolversi e a svilupparsi nel corso dei secoli, culminando nella formulazione di convenzioni internazionali più dettagliate e complete, come le Convenzioni di Ginevra, che oggi regolano il comportamento in guerra.
L'organizzazione del sistema interstatale ha portato all'adozione di norme rigorose per regolare la condotta della guerra. Lo scopo di queste norme è quello di limitare, per quanto possibile, le conseguenze distruttive della guerra e di proteggere le persone che non vi sono direttamente coinvolte, come i civili o i prigionieri di guerra. Per questo motivo, secondo il diritto internazionale, una guerra deve essere dichiarata prima del suo inizio. Lo scopo di questa dichiarazione è quello di inviare un chiaro segnale a tutte le parti interessate, compresi altri Paesi e organizzazioni internazionali, che un conflitto armato è iniziato. Durante la guerra, i combattenti sono tenuti a rispettare alcune regole. Ad esempio, non devono prendere deliberatamente di mira i civili, gli edifici civili come scuole o ospedali, né usare armi proibite dal diritto internazionale, come le armi chimiche o biologiche. Infine, dopo la guerra, deve essere messo in atto un processo di pace per risolvere le controversie, punire i crimini di guerra e riparare i danni causati dal conflitto. Sebbene queste regole siano spesso violate, la loro esistenza e il loro riconoscimento universale sono un importante tentativo di civilizzare un'attività che, per sua natura, è violenta e distruttiva.
La guerra, nonostante le sue conseguenze spesso devastanti, è stata integrata nel sistema interstatale come strumento di risoluzione delle controversie politiche. È importante notare, tuttavia, che l'idea non è quella di promuovere o glorificare la guerra, ma piuttosto di cercare di contenerla e regolarla. A partire dal XVII secolo, sono state stabilite numerose regole per cercare di limitare le devastazioni della guerra. Tra queste vi è il diritto internazionale umanitario, che stabilisce limiti al modo in cui la guerra può essere condotta, proteggendo le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità, come i civili, gli operatori sanitari e i prigionieri di guerra. Inoltre, il diritto internazionale ha anche stabilito regole su come dichiarare la guerra, condurre le ostilità e concludere la pace. Questo include il diritto di guerra, che stabilisce le regole per la condotta delle ostilità, e il diritto di pace, che regola la conclusione dei trattati di pace e la risoluzione dei conflitti internazionali. Questi sforzi per regolamentare la guerra riflettono il riconoscimento che, sebbene la guerra possa talvolta essere inevitabile, deve essere condotta in modo da ridurre al minimo le sofferenze umane e la distruzione materiale.
Il Trattato di Westfalia, concluso nel 1648 per porre fine alla Guerra dei Trent'anni, era composto da due accordi separati: il Trattato di Osnabrück e il Trattato di Münster. Il Trattato di Osnabrück fu firmato tra l'Impero svedese e il Sacro Romano Impero, mentre il Trattato di Münster fu concluso tra il Sacro Romano Impero e le Province Unite (oggi Paesi Bassi) e tra il Sacro Romano Impero e la Francia. Questi trattati sono storicamente importanti perché hanno gettato le basi del moderno ordine internazionale basato sulla sovranità degli Stati. Furono stabiliti il principio di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e il principio dei pesi e contrappesi. Il Trattato di Westfalia segnò la fine dell'idea di un impero cristiano universale in Europa e aprì la strada a un sistema di Stati nazionali indipendenti e sovrani.
I Trattati di Westfalia posero fine alla Guerra dei Trent'anni, una guerra di religione che dilaniò l'Europa, e in particolare il Sacro Romano Impero, tra il 1618 e il 1648. La guerra fu combattuta principalmente tra forze cattoliche e protestanti, sebbene anche la politica e la lotta per il potere giocassero un ruolo importante. Ponendo fine alla guerra, i Trattati di Westfalia non solo portarono una gradita pace, ma segnarono anche un cambiamento fondamentale nell'organizzazione politica dell'Europa. Prima di questi trattati, era ancora viva l'idea di un impero cristiano universale, in cui un'autorità superiore (il Papa o il Sacro Romano Imperatore) avrebbe avuto una certa autorità su regni e principati. I Trattati di Westfalia stabilirono il principio della sovranità statale, affermando che ogni Stato aveva un'autorità assoluta ed esclusiva sul proprio territorio e sul proprio popolo. Ciò significava che, per la prima volta, gli Stati, piuttosto che gli imperatori o i papi, diventavano i principali attori sulla scena internazionale. Si tratta del cosiddetto "sistema di Westfalia", che rimane il fondamento dell'ordine internazionale moderno.
La Svizzera è stata riconosciuta come entità indipendente con il Trattato di Westfalia del 1648, anche se la sua forma attuale di Stato ha richiesto più tempo per consolidarsi. La neutralità perpetua della Svizzera fu stabilita anche al Congresso di Vienna del 1815, rafforzando il suo status distinto sulla scena internazionale. Tuttavia, va notato che la Confederazione svizzera come unione di cantoni esisteva già prima del Trattato di Westfalia. La sua struttura unica, tuttavia, non corrispondeva esattamente al concetto di Stato nazionale emerso con il sistema di Westfalia. Per questo motivo, la Svizzera ha tardato a emergere nella sua forma moderna.
Il Trattato di Westfalia ha posto le basi del moderno sistema internazionale basato sulla sovranità nazionale. In altre parole, ogni Stato ha il diritto di governare il proprio territorio come meglio crede senza interferenze esterne. Questo principio di non interferenza negli affari interni degli altri Stati è un pilastro fondamentale del sistema internazionale. Detto questo, non elimina i conflitti o i disaccordi tra gli Stati. Quando sorge una controversia, si può ricorrere alla guerra come mezzo di risoluzione. Tuttavia, nel mondo moderno si preferiscono altre forme di risoluzione dei conflitti, come la diplomazia, il dialogo e la negoziazione. La guerra è spesso considerata l'ultima risorsa quando nessun'altra opzione è praticabile o efficace.
La distinzione tra spazio interno ed esterno degli Stati è fondamentale per la politica internazionale. All'interno dei suoi confini, uno Stato ha la sovranità di far rispettare le proprie leggi e regolamenti e di mantenere l'ordine come ritiene necessario. Questo spazio interno è spesso caratterizzato da un insieme di regole e norme ben definite, ampiamente riconosciute e rispettate. Al di fuori dei propri confini, uno Stato deve navigare in un ambiente più complesso e spesso meno regolamentato, dove le interazioni avvengono principalmente tra Stati sovrani che possono avere interessi divergenti. Questo spazio esterno è regolato dal diritto internazionale, che è meno vincolante e dipende maggiormente dalla cooperazione tra gli Stati.
Il principio di sovranità, sebbene stabilisca l'uguaglianza formale di tutti gli Stati nel diritto internazionale, non si traduce necessariamente in un'uguaglianza reale sulla scena internazionale. Alcuni Stati, grazie al loro potere economico, militare o strategico, possono esercitare un'influenza sproporzionata. Allo stesso tempo, l'ascesa degli attori non statali ha reso più complesso il panorama internazionale. Le organizzazioni non governative (ONG), le multinazionali e persino i singoli individui (come attivisti, dissidenti politici o celebrità) possono ora svolgere ruoli significativi nella politica internazionale. Questi attori possono influenzare le politiche globali mobilitando l'opinione pubblica, intraprendendo azioni dirette, fornendo servizi essenziali o esercitando il potere economico. Tuttavia, nonostante la crescente influenza di questi attori non statali, gli Stati rimangono gli attori principali e più potenti sulla scena internazionale.
Nel sistema internazionale contemporaneo, lo Stato è l'unità politica fondamentale. Il concetto di Stato-nazione sovrano, sebbene criticato e spesso complicato dalle questioni del transnazionalismo, della globalizzazione e delle relazioni internazionali interdipendenti, rimane il principale organizzatore della politica mondiale. Ogni Stato, in quanto entità sovrana, dovrebbe esercitare un'autorità assoluta sul proprio territorio e sulla propria popolazione. Il sistema internazionale si basa sull'interazione tra questi Stati sovrani e sul rispetto dei principi di non interferenza negli affari interni degli altri Stati. Tuttavia, la realtà è spesso più complessa. Numerosi attori non statali - dalle multinazionali ai gruppi terroristici, dalle organizzazioni non governative alle istituzioni internazionali - svolgono un ruolo importante sulla scena internazionale. A volte, questi attori possono persino sfidare l'autorità e la sovranità degli Stati. Ma nonostante queste sfide, l'idea di Stato nazionale rimane centrale per comprendere e strutturare il nostro mondo politico.
Non si parla di "world studies" o "global studies". Il termine che si è imposto è "relazioni internazionali". Il campo di studio delle "relazioni internazionali" si concentra sull'interazione tra gli Stati e, più in generale, tra gli attori della scena mondiale. Non si tratta semplicemente di studiare il mondo nel suo complesso, ma di capire come gli Stati interagiscono tra loro, come negoziano e si contendono il potere, come collaborano e come entrano in conflitto. L'accento è posto sulle "relazioni" perché è attraverso di esse che gli Stati si definiscono l'uno rispetto all'altro, modellano la loro politica estera e influenzano il sistema internazionale. Per questo motivo, nonostante la crescente interdipendenza e globalizzazione, la nozione di Stato nazionale e di confine statale rimangono concetti chiave nella teoria e nella pratica delle relazioni internazionali. La strutturazione dello spazio tra gli Stati è infatti una dimensione fondamentale nell'analisi delle relazioni internazionali. È questa strutturazione che determina, tra l'altro, le alleanze, i conflitti, il commercio e i flussi di popolazione. Ha anche un'influenza significativa sulla governance globale e sullo sviluppo di standard internazionali.
Il Trattato di Westfalia, firmato nel 1648, ha posto le basi dell'ordine internazionale moderno basato sul principio della sovranità nazionale. Secondo questo principio, ogni Stato ha il diritto di governare il proprio territorio e la propria popolazione senza interferenze esterne. L'uguaglianza sovrana significa che, dal punto di vista del diritto internazionale, tutti gli Stati sono uguali, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla loro ricchezza o dal loro potere. Significa che ogni Stato ha il diritto di partecipare pienamente alla comunità internazionale e di essere rispettato dagli altri Stati.
Detto questo, se il Trattato di Westfalia ha stabilito la sovranità e l'uguaglianza sovrana come principi fondamentali del sistema internazionale, non significa che la guerra sia una conseguenza inevitabile di questi principi. Infatti, sebbene le controversie tra gli Stati possano portare a un conflitto armato, la guerra non è né l'unico né il più auspicabile mezzo di risoluzione delle controversie. I principi del diritto internazionale, come la risoluzione pacifica delle controversie, sono anche centrali per l'ordine internazionale emerso da Westfalia. Inoltre, nel corso dei secoli, le norme e le istituzioni internazionali si sono evolute per governare e regolare la condotta della guerra e per promuovere il dialogo, la negoziazione e la cooperazione tra gli Stati. Il sistema di Westfalia non è quindi una semplice licenza per la guerra, ma il quadro all'interno del quale gli Stati coesistono, collaborano e, a volte, si scontrano.
Dalla guerra totale alla guerra istituzionalizzata (Holsti)[modifier | modifier le wikicode]
Il XVII secolo è stato un periodo di significative trasformazioni nell'organizzazione politica e sociale di molti Paesi, che ha portato all'emergere dello Stato moderno. In questo periodo gli Stati iniziarono a consolidare il loro potere, a centralizzare l'autorità, a imporre sistematicamente le tasse e a sviluppare burocrazie più efficienti e strutturate. La centralizzazione e la burocratizzazione permisero agli Stati di accumulare risorse e di mobilitarle in modo più efficace, soprattutto in vista di una guerra. Man mano che gli Stati diventavano più potenti ed efficienti, erano in grado di condurre guerre su scala più ampia e con maggiore intensità. Ciò ha spianato la strada alla cosiddetta "guerra totale", in cui tutti gli aspetti della società sono mobilitati per lo sforzo bellico e la distinzione tra combattenti e non combattenti diventa meno netta. Parallelamente a questi cambiamenti, anche il sistema internazionale si stava evolvendo, con l'istituzione del sistema di Westfalia basato sulla sovranità statale. Questi due processi - l'evoluzione dello Stato e la trasformazione del sistema internazionale - si sono rafforzati a vicenda. Il consolidamento dello Stato ha contribuito all'ascesa del sistema di Westfalia, mentre quest'ultimo ha fornito un quadro di riferimento per lo sviluppo e il rafforzamento degli Stati.
Se da un lato lo Stato moderno ha contribuito notevolmente alla riduzione della violenza interpersonale, stabilendo un ordine sociale interno e un monopolio sull'uso legittimo della forza, dall'altro la sua maggiore capacità di mobilitare e concentrare le risorse ha portato alla possibilità di conflitti su scala più ampia, spesso con conseguenze devastanti. Nel contesto delle relazioni internazionali, il sistema westfaliano ha creato un ambiente in cui gli Stati, cercando di proteggere i propri interessi e garantire la propria sicurezza, potevano ricorrere alla guerra come mezzo per risolvere le loro divergenze. Ciò ha portato a guerre sempre più distruttive, culminate nelle due guerre mondiali del XX secolo.
L'evoluzione delle norme e delle regole sulla guerra ha portato a una più chiara distinzione tra combattenti e non combattenti, con lo sforzo di proteggere questi ultimi dagli effetti diretti della guerra. Questa idea è stata codificata nel diritto internazionale umanitario, in particolare nelle Convenzioni di Ginevra. Nel Medioevo, la distinzione tra civili e combattenti non era sempre chiara e i civili erano spesso direttamente colpiti dalla guerra. Tuttavia, con lo sviluppo dello Stato moderno e la codificazione della guerra, è emersa la norma secondo cui i civili devono essere risparmiati il più possibile durante i conflitti. Detto questo, sebbene la distinzione sia oggi ampiamente riconosciuta e rispettata in teoria, purtroppo è spesso ignorata nella pratica. Molti conflitti contemporanei hanno visto gravi violazioni di questa norma, con attacchi deliberati ai civili e sofferenze enormi per le popolazioni non combattenti.
A partire dal XVII secolo, con l'ascesa dello Stato nazionale e la professionalizzazione degli eserciti, si è assistito a una riduzione dell'impatto diretto della guerra sui civili. I combattenti - generalmente soldati professionisti - sono diventati i principali partecipanti e vittime della guerra. Tuttavia, questa tendenza si è invertita nel corso del XX secolo, in particolare con le due guerre mondiali e altri grandi conflitti, in cui i civili sono stati spesso presi di mira o sono diventati vittime collaterali. La situazione si è intensificata dopo la fine della Guerra Fredda, con l'aumento dei conflitti interni agli Stati e dei gruppi armati non statali. In questi conflitti, i civili sono spesso direttamente presi di mira e costituiscono la maggior parte delle vittime.
L'emergere della guerra moderna è intrinsecamente legato all'emergere dello Stato nazionale. Nel Medioevo, i conflitti erano caratterizzati da una fluidità di strutture e fazioni, che comprendevano città-stato, ordini religiosi come il papato, signori della guerra e altri gruppi che cambiavano spesso alleanze in base ai loro interessi del momento. Era un'epoca in cui la violenza era onnipresente, ma i confini del conflitto erano spesso sfumati e mutevoli. Con l'ascesa dello Stato-nazione, la natura della guerra cambiò in modo significativo. Gli Stati iniziarono a formare eserciti di soldati, identificabili dalle loro uniformi, che servivano come rappresentanti dello Stato sul campo di battaglia. Che si trattasse di professionisti pagati o di coscritti mobilitati per il servizio militare, questi soldati simboleggiavano la capacità e l'autorità dello Stato di proiettare forza e difendere i propri interessi. La guerra divenne così un'estensione delle relazioni interstatali e delle politiche statali, con regole e convenzioni più chiaramente definite.
Dalla guerra totale alla guerra istituzionalizzata (Holsti)[modifier | modifier le wikicode]
La Pace di Westfalia ha creato un nuovo sistema politico, noto come sistema di Westfalia, che ha formalizzato l'idea di Stati nazionali sovrani. In questo sistema, la guerra divenne uno strumento istituzionalizzato per risolvere i conflitti tra gli Stati. Invece di essere una serie di schermaglie caotiche e continue, la guerra divenne uno stato dichiarato e riconosciuto di conflitto aperto tra Stati sovrani. Questo ha portato anche alla nascita di regole e convenzioni di guerra, volte a limitare gli effetti distruttivi del conflitto e a proteggere i diritti dei combattenti e dei civili. Queste regole sono state formalizzate in trattati e convenzioni internazionali, come le Convenzioni di Ginevra.
K. J. Holsti, nel suo libro "The State, War, and the State of War" (1996), distingue tra due tipi di guerra. Le "guerre di tipo 1" che definisce sono le guerre tradizionali tra Stati, che sono state la norma dal Trattato di Westfalia fino alla fine della Guerra fredda. Questi conflitti sono generalmente chiaramente definiti, con dichiarazioni di guerra formali, fronti militari chiari e la fine delle ostilità spesso segnata da trattati di pace. Le "guerre di tipo 2", secondo Holsti, sono invece le guerre moderne, che tendono a essere molto più caotiche e meno chiaramente definite. Possono coinvolgere attori non statali come gruppi terroristici, milizie o bande. Questi conflitti possono scoppiare all'interno dei confini statali, piuttosto che tra Stati diversi, e possono durare decenni, con una violenza costante piuttosto che un inizio e una fine chiaramente definiti.
Il periodo tra il 1648 e il 1789 viene spesso definito come l'era della "guerra limitata" o della "guerra di gabinetto". Queste guerre avevano generalmente obiettivi chiari e limitati. Spesso venivano combattute per motivi specifici, come il controllo di particolari territori o la risoluzione di specifiche controversie tra Stati. Queste guerre erano solitamente combattute da eserciti professionali sotto il diretto controllo del governo statale, da cui il termine "guerra di gabinetto". L'idea era quella di utilizzare la guerra come strumento per raggiungere specifici obiettivi politici, piuttosto che cercare la distruzione totale del nemico. Ciò corrisponde al concetto clausewitziano di guerra come "continuazione della politica con altri mezzi". Queste guerre erano generalmente ben strutturate, con dichiarazioni di guerra formali, regole di condotta concordate e, infine, trattati di pace per risolvere formalmente il conflitto. Ciò riflette il livello di formalizzazione e istituzionalizzazione del concetto di guerra in questo periodo. Tuttavia, la situazione iniziò a cambiare con le guerre rivoluzionarie e napoleoniche della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo, caratterizzate da una mobilitazione di massa e da un livello di distruzione molto più elevato. Queste guerre hanno aperto la strada all'era delle "guerre totali" del XX secolo.
Questo periodo storico, generalmente compreso tra il Trattato di Westfalia del 1648 e la Rivoluzione francese del 1789, ha visto un'importante codificazione delle strutture militari e delle regole di guerra. La comparsa di uniformi distintive è un segno di questa codificazione. Le uniformi aiutavano a identificare chiaramente i belligeranti sul campo di battaglia, contribuendo a una misura di disciplina e ordine. Questo periodo vide anche l'affermarsi di quella che potremmo definire una "cultura militare" professionale. Gli eserciti di questo periodo erano spesso comandati da membri della nobiltà, che venivano addestrati all'arte della guerra e vedevano il servizio militare come un'estensione dei loro obblighi sociali e politici. È spesso in questo periodo che si assiste all'emergere della "noblesse d'épée", una classe di nobili che traeva il proprio status e la propria reputazione dal servizio nell'esercito. Allo stesso tempo, le regole di guerra vennero codificate, portando a una maggiore attenzione ai diritti dei prigionieri di guerra, all'immunità diplomatica e ad altri aspetti del diritto di guerra. Questi codici di condotta furono rafforzati da trattati e convenzioni internazionali, gettando le basi del moderno diritto internazionale.
Durante questo periodo storico, le guerre erano generalmente caratterizzate da obiettivi limitati e da impegni relativamente brevi. I belligeranti spesso cercavano di raggiungere obiettivi strategici specifici, come la conquista di un particolare territorio o di una fortezza, piuttosto che la distruzione totale del nemico. Questi conflitti erano spesso caratterizzati dalla "guerra di manovra", in cui gli eserciti cercavano di ottenere un vantaggio strategico attraverso il movimento e la posizione piuttosto che con il combattimento frontale. Le battaglie erano spesso l'eccezione piuttosto che la regola e molti conflitti si concludevano con negoziati piuttosto che con una vittoria militare totale. Questo modo di condurre la guerra era in parte una conseguenza dei vincoli logistici dell'epoca. Gli eserciti erano spesso limitati dalla loro capacità di rifornire le truppe di cibo, acqua e munizioni, il che limitava la durata e la portata degli impegni militari.
In questo periodo di guerra limitata, l'obiettivo non era l'annientamento totale dell'avversario, ma piuttosto il raggiungimento di specifici obiettivi strategici. Le battaglie erano spesso orchestrate con cura e gli eserciti cercavano di ridurre al minimo le perdite di vite umane non necessarie. L'enfasi era sulla strategia e sulla tattica, non sulla distruzione indiscriminata. I civili venivano generalmente risparmiati, in parte perché la guerra era vista come un affare tra Stati, non tra popoli. Tuttavia, questo non significa che i civili non fossero mai colpiti. Lo sconvolgimento causato dalla guerra poteva portare a carestie, epidemie e altre forme di sofferenza per le popolazioni civili.
La Guerra di successione spagnola (1701-1714) è un buon esempio di guerra di questo periodo. Fu scatenata dalla morte del re Carlo II di Spagna senza un erede diretto. Il conflitto contrappose le principali potenze europee che cercavano di controllare la successione al trono spagnolo e, di conseguenza, di aumentare la propria influenza e il proprio potere in Europa. La guerra fu limitata nel tempo e, sebbene fosse brutale e costosa in termini di vite umane, era regolata da regole e convenzioni accettate che ne limitavano l'intensità e la portata. Ad esempio, le battaglie furono generalmente combattute da eserciti regolari e i civili furono ampiamente risparmiati. Tuttavia, questa guerra fu significativa in termini di cambiamenti geopolitici. Vide l'ascesa della Gran Bretagna e segnò una svolta negli equilibri di potere in Europa. Essa portò anche al Trattato di Utrecht del 1713, che ridefinì i confini ed ebbe un impatto duraturo sulla politica europea.
Il periodo che va dalla fine del XVII secolo al XVIII secolo fu caratterizzato dalla graduale codificazione degli eserciti. Questa codificazione riguardò molti aspetti della condotta militare. La struttura degli eserciti iniziò a essere formalizzata con l'introduzione di gerarchie chiaramente definite e di ruoli militari specifici. Questo portò a una migliore organizzazione e coordinamento delle forze armate. La codificazione delle uniformi fu un altro aspetto importante. Le uniformi militari non solo distinguevano i soldati dai civili, ma permettevano anche di distinguere gli alleati dai nemici e di identificare il grado e il ruolo di ciascun soldato. Anche il comportamento sul campo di battaglia fu regolamentato. Furono stabilite regole specifiche per disciplinare le azioni in tempo di guerra, compreso il trattamento dei prigionieri di guerra e la condotta nei confronti dei civili. Questa codificazione degli eserciti è stata una parte essenziale della formazione degli Stati nazionali moderni. Ha portato a una maggiore efficienza e a una migliore organizzazione nella conduzione della guerra, limitando al contempo alcune forme di violenza e proteggendo in una certa misura i non combattenti.
Le uniformi militari hanno svolto un ruolo cruciale nell'identificazione e nell'organizzazione delle forze armate durante questo periodo. Svolgevano una serie di funzioni importanti. In primo luogo, l'identificazione. Le uniformi aiutavano a distinguere gli alleati dagli avversari sul campo di battaglia. Servivano anche a identificare il grado e la funzione di un individuo all'interno dell'esercito. Questo è un modo per creare chiarezza durante i conflitti, dove le situazioni possono essere caotiche e mutevoli. In secondo luogo, l'uniforme crea un senso di unità tra i soldati. Indossando gli stessi abiti, i soldati si sentono legati gli uni agli altri, condividendo un'identità comune. L'uniforme simboleggia la loro lealtà allo Stato e il loro impegno per la causa per cui combattono. In secondo luogo, l'uniforme promuove la disciplina e l'ordine. Imponendo l'abito uniforme, l'esercito rafforza la sua organizzazione gerarchica e strutturata. È un promemoria costante del rigore e della struttura che la vita militare richiede. Infine, l'uniforme è anche uno strumento per rappresentare il potere e il prestigio dello Stato. Spesso è progettata per impressionare o intimidire gli avversari. È una dichiarazione visiva della forza e del potenziale dello Stato. La standardizzazione dell'abbigliamento militare iniziò a verificarsi a partire dal XVII secolo, parallelamente allo sviluppo dello Stato moderno e degli eserciti permanenti. Questo processo è stato influenzato dai progressi tecnologici che hanno reso possibile la produzione di massa di abiti, nonché dalla necessità di una maggiore disciplina e organizzazione all'interno delle forze armate.
Il secondo tipo di guerra o guerra totale: 1789-1815 e 1914-1945[modifier | modifier le wikicode]
Continuando la tipologia di K.J. Holsti, le guerre del secondo tipo sono emerse con le guerre della Rivoluzione e dell'Impero all'inizio del XIX secolo. Questi conflitti si differenziano notevolmente dal primo tipo di guerre del XVII e XVIII secolo.
Le guerre del secondo tipo, note anche come guerre di massa o guerre napoleoniche, erano caratterizzate da una mobilitazione senza precedenti di risorse umane e materiali. Sono definite dal desiderio di annientare il nemico, a differenza delle guerre del primo tipo, che miravano principalmente a raggiungere obiettivi politici limitati. Queste guerre sono spesso più lunghe, costose e distruttive. I conflitti non si limitano più a battaglie singole e limitate, ma si estendono a campagne militari su larga scala. Inoltre, la distinzione tra combattenti e civili è diventata meno netta, con intere popolazioni coinvolte nello sforzo bellico, sia attraverso la coscrizione che il sostegno allo sforzo bellico. Le guerre napoleoniche sono un classico esempio di questo tipo di guerra, con milioni di persone mobilitate in tutta Europa, una serie di conflitti durati oltre un decennio e importanti cambiamenti politici e territoriali come risultato.
La Rivoluzione francese del 1789 segnò una svolta importante nel modo di combattere le guerre. Con l'emergere delle idee rivoluzionarie di libertà, uguaglianza e fraternità, la guerra divenne più di un semplice strumento di politica statale. Divenne un'espressione delle aspirazioni e delle ambizioni collettive della nazione. Il concetto di "nazione in armi" apparve per la prima volta in questo periodo. Questo concetto faceva parte dell'idea di una mobilitazione totale della popolazione in preparazione alla guerra. Non si trattava più solo di professionisti della guerra o di mercenari che combattevano, ma dell'intera popolazione, compresi i cittadini comuni. Questi cittadini sono chiamati a prendere le armi non solo per difendere il territorio, ma anche per difendere l'idea stessa di nazione e i principi su cui si basa. Ciò è stato reso possibile dalla levée en masse, una misura rivoluzionaria che ha permesso di arruolare un gran numero di cittadini nell'esercito. Questa misura permise alla Francia di mobilitare notevoli risorse umane per far fronte alla minaccia delle potenze europee schierate contro di lei. La conseguenza di questo nuovo approccio alla guerra fu un'escalation di violenza e distruzione senza precedenti e il crescente coinvolgimento dei civili nel conflitto. Questa tendenza sarebbe continuata e si sarebbe intensificata nei due secoli successivi, in particolare con le due guerre mondiali del XX secolo.
La Rivoluzione francese sconvolse l'ordine stabilito in Europa. Le monarchie tradizionali, minacciate dalle idee rivoluzionarie di sovranità popolare e democrazia, formarono coalizioni per cercare di ripristinare l'Ancien Régime in Francia. In risposta a queste minacce esterne, i leader rivoluzionari francesi decisero di costituire un grande esercito di cittadini. Si trattava di un'importante rottura con il passato, quando gli eserciti erano costituiti principalmente da mercenari o truppe professionali. Il decreto Levée en masse, adottato nel 1793, mobilitò tutti i cittadini francesi in età militare. L'obiettivo era quello di respingere gli eserciti delle monarchie europee che stavano invadendo la Francia. Questa mobilitazione di massa portò alla formazione di un esercito di diverse centinaia di migliaia di soldati, che alla fine riuscì a respingere le invasioni e a preservare la Rivoluzione. Questa mobilitazione di massa è considerata la prima mobilitazione nazionale della storia moderna. Trasformò la natura della guerra da un conflitto limitato tra guerrieri professionisti a una lotta che coinvolgeva l'intera nazione. Cambiò anche il rapporto tra i cittadini e lo Stato, poiché il loro ruolo non era più solo quello di obbedire, ma anche di difendere attivamente la nazione e i suoi ideali.
Il passaggio a un esercito di leva richiedeva uno Stato moderno e organizzato, capace di fare il punto sulla popolazione, di addestrare ed equipaggiare rapidamente migliaia di soldati e di sostenere lo sforzo bellico a lungo termine. La mobilitazione di massa trasformò la natura della guerra rendendo possibile la mobilitazione di eserciti molto grandi. Sotto Napoleone, ad esempio, l'esercito francese arrivò a contare oltre 600.000 uomini, una cifra senza precedenti per l'epoca. Ciò aumentò anche la capacità dell'esercito di condurre operazioni su più fronti contemporaneamente. Tuttavia, ha anche aumentato la complessità della logistica militare, richiedendo la fornitura di cibo, armi e munizioni per molti più soldati. Ha quindi richiesto uno Stato più efficiente e organizzato, in grado di pianificare e sostenere queste operazioni su larga scala. Ha portato anche a un cambiamento nella natura stessa della guerra. Con eserciti così grandi, le battaglie sono diventate più distruttive e hanno provocato un maggior numero di vittime. La guerra divenne un affare di intere nazioni, coinvolgendo non solo i soldati, ma anche i civili che sostenevano lo sforzo bellico nelle retrovie.
L'introduzione di un esercito di leva richiede uno Stato moderno, per diverse ragioni. In primo luogo, uno Stato moderno ha un'amministrazione efficiente. Questa amministrazione è necessaria per identificare la popolazione e gestire la coscrizione. Identificare, registrare, mobilitare e addestrare le reclute è un compito amministrativo enorme che richiede una burocrazia efficiente. In secondo luogo, lo Stato deve avere la capacità logistica di sostenere un grande esercito. Ciò significa che deve essere in grado di fornire cibo, vestiti, armi e munizioni a un gran numero di soldati. Deve anche avere la capacità di curare i feriti. Tutti questi compiti richiedono una solida infrastruttura logistica. In terzo luogo, uno Stato moderno ha generalmente un'economia abbastanza forte da sostenere un esercito di leva. Le guerre sono costose e occorre uno Stato in grado di finanziare queste spese. Infine, la mobilitazione di massa richiede un certo grado di coesione e solidarietà sociale. Lo Stato deve avere la legittimità di chiedere ai suoi cittadini di combattere e morire per lui. Questo è generalmente più facile in uno Stato nazionale, dove i cittadini condividono un senso di appartenenza comune. Infine, il passaggio a un esercito di leva è una manifestazione della modernità di uno Stato, che illustra la sua capacità di esercitare potere sui propri cittadini e di mobilitare le proprie risorse per raggiungere i propri obiettivi.
Il secondo tipo di guerra, secondo la tipologia di Holsti, è caratterizzato da eserciti di leva su larga scala e non più da eserciti professionali basati su mercenari. Queste guerre sono emerse dopo la Rivoluzione francese e hanno raggiunto il loro apogeo con le guerre napoleoniche. L'idea di fondo è che l'intera nazione, piuttosto che una casta di guerrieri o un'élite professionale, viene mobilitata per la guerra. I soldati non combattevano più per la paga, ma per la difesa della nazione e dei suoi valori. Si tratta di una grande trasformazione nella natura della guerra, che comporta un grado molto maggiore di impegno e sacrificio da parte dei cittadini. Questa nuova forma di guerra ha reso possibile la costituzione di eserciti molto più grandi e potenti rispetto al passato, che hanno contribuito al dominio di Napoleone sull'Europa. Inoltre, questi eserciti nazionalisti cambiarono il modo in cui la guerra veniva percepita e vissuta dalla popolazione. La guerra non era più un affare professionale, ma una causa per la quale ogni cittadino era pronto a dare la propria vita. Ciò ebbe anche un impatto significativo sulla natura dei conflitti e sull'entità delle distruzioni e delle perdite di vite umane che potevano causare.
La natura ideologica delle guerre rivoluzionarie porta a un'intensificazione del conflitto. A differenza delle guerre cosiddette "tradizionali", dove gli obiettivi sono spesso territoriali o materiali, le guerre rivoluzionarie tendono ad avere obiettivi più astratti e fondamentali. Non si tratta più semplicemente di conquistare un territorio o di appropriarsi di risorse, ma di difendere un'idea, un ideale o addirittura un'identità. In questo contesto, il nemico non è solo un avversario militare, ma anche una minaccia all'esistenza stessa della nazione e dei suoi valori. Di conseguenza, l'obiettivo non è solo quello di sconfiggere il nemico sul campo di battaglia, ma di annientarlo completamente, perché la sua sola esistenza è percepita come una minaccia. Questo può portare a un'escalation di violenza e a guerre particolarmente letali e distruttive. Anche il fatto che l'intera popolazione sia mobilitata per la guerra contribuisce all'intensificazione dei conflitti, poiché tutti si sentono coinvolti in prima persona e pronti a sacrificarsi per la causa. D'altra parte, queste guerre possono anche essere percepite come più legittime o giustificate da chi le conduce, perché combatte per una causa in cui crede profondamente e non semplicemente per il potere o il profitto. Questo può contribuire a rafforzare l'unità nazionale e la determinazione a combattere.
Nelle guerre del secondo tipo, come quelle rivoluzionarie, la natura degli obiettivi cambia significativamente rispetto ai conflitti più tradizionali. Gli obiettivi non sono più puramente materiali, come la conquista del territorio o il controllo delle risorse, ma diventano ideologici e astratti. Questi obiettivi, come "liberazione", "democrazia" o "lotta di classe", non sono solo aperti, ma anche vaghi e soggettivi. Non possono essere misurati o raggiunti in termini concreti, il che può rendere difficile definire o raggiungere la fine del conflitto. Inoltre, questi obiettivi più astratti possono anche portare a conflitti più intensi e prolungati. Poiché questi obiettivi sono spesso percepiti come essenziali per l'identità o la sopravvivenza di una nazione, i combattenti sono spesso disposti a spingersi oltre e a correre maggiori rischi per raggiungerli. Infine, questi obiettivi ideologici possono anche rendere più difficile il raggiungimento di un accordo di pace. Essendo spesso assoluti e non negoziabili, questi obiettivi richiedono spesso la resa incondizionata dell'avversario, il che può complicare i negoziati e prolungare la durata dei conflitti.
La Seconda guerra mondiale è una perfetta illustrazione del concetto di "guerra del secondo tipo". L'obiettivo principale non era solo quello di sconfiggere militarmente la Germania nazista, ma anche di eliminare la stessa ideologia nazista. Questa guerra non era semplicemente una questione di territorio o di risorse, ma una lotta ideologica. L'obiettivo non era una resa tradizionale, in cui le forze nemiche depongono le armi e tornano a casa. Al contrario, l'obiettivo era lo sradicamento totale del nazismo come sistema politico e ideologico. Questo portò alla richiesta di "resa incondizionata" da parte degli Alleati, il che significa che i nazisti non avevano alcuna possibilità di negoziare i termini della loro resa. Si trattava di una richiesta insolita nel contesto storico dei conflitti, che illustrava la natura eccezionale e totale di questa guerra. Inoltre, dopo la fine della guerra, la Germania fu occupata e divisa e fu intrapreso un processo di "denazificazione" per eliminare l'influenza nazista dalla società tedesca. Ciò dimostrò la portata dell'impegno degli Alleati nell'eliminare non solo la minaccia militare nazista, ma anche la stessa ideologia nazista.
Il passaggio a questo tipo di guerra totale fu strettamente legato all'evoluzione dello Stato. Con l'emergere dello Stato nazionale moderno e del nazionalismo nel XVIII e XIX secolo, la guerra divenne sempre più una questione di tutto il popolo, non solo dell'esercito. Nelle guerre totali del XX secolo, come le due guerre mondiali, tutti gli aspetti della società e dell'economia furono mobilitati per lo sforzo bellico. I civili divennero obiettivi di guerra, sia direttamente attraverso i bombardamenti, sia indirettamente attraverso i blocchi e le carestie. Inoltre, la ragion d'essere di queste guerre era spesso espressa in termini ideologici o esistenziali, come la difesa della democrazia contro il fascismo o la lotta per la sopravvivenza della nazione. In questo contesto, una semplice vittoria sul campo di battaglia non era sufficiente: il nemico doveva essere completamente sconfitto e il suo sistema politico e ideologico smantellato.
Il regime nazista fu in grado di salire al potere e di commettere atrocità su scala così massiccia soprattutto grazie alle infrastrutture e all'apparato statale della Germania di allora. Le strutture statali moderne, comprese le istituzioni burocratiche, militari ed economiche altamente centralizzate, possono essere potenzialmente dirottate per scopi nefasti, come è accaduto con il nazismo in Germania. Senza uno Stato così potente e ben organizzato, sarebbe stato molto più difficile, se non impossibile, per ideologie totalitarie come il nazismo attuare i propri piani distruttivi su scala così massiccia. Allo stesso modo, senza la potenza industriale e militare di uno Stato moderno, il regime nazista non sarebbe stato in grado di lanciare una guerra su scala globale.
La Seconda guerra mondiale ha segnato una svolta significativa nel modo di condurre la guerra, soprattutto in termini di obiettivi. Con la diffusione dei bombardamenti aerei e l'industrializzazione della guerra, i civili divennero bersagli diretti. Questa guerra ha visto la maggior parte delle vittime spostarsi dai soldati ai civili. In questo contesto, le armi di distruzione di massa, come le bombe atomiche, possono causare distruzioni massicce e la morte di migliaia, persino centinaia di migliaia di civili in un istante. Inoltre, lo sforzo bellico coinvolge l'intera popolazione e l'industria degli armamenti è spesso un obiettivo prioritario, con conseguente aumento del numero di vittime civili. Il secondo tipo di guerra ha visto anche l'attuazione di politiche genocide e di crimini contro l'umanità su larga scala, che richiedono risorse industriali e organizzazione statale. I campi di concentramento e di sterminio nazisti sono un tragico esempio di come la capacità industriale e la burocrazia statale possano essere utilizzate per scopi disumani. Tutto ciò illustra ancora una volta quanto lo Stato moderno e la sua capacità di organizzare e mobilitare risorse possano avere conseguenze drammatiche quando vengono utilizzati in modo improprio.
La storia del XX secolo mostra chiaramente che guerra e industrializzazione sono intrinsecamente legate. Durante le due guerre mondiali, le nazioni hanno dovuto trasformare rapidamente le loro economie per sostenere lo sforzo bellico, portando a una significativa accelerazione dell'industrializzazione. Le fabbriche che in precedenza erano state dedicate alla produzione di beni di consumo furono convertite per produrre armi, veicoli militari, munizioni e altro materiale bellico. Queste industrie dovettero essere modernizzate e razionalizzate per raggiungere un livello di produzione senza precedenti, il che incoraggiò lo sviluppo di nuove tecnologie e tecniche di produzione. Durante la Prima guerra mondiale, ad esempio, la produzione di acciaio e di altri materiali essenziali aumentò in modo esponenziale per soddisfare le esigenze belliche. Questa maggiore capacità produttiva è stata poi riutilizzata dopo la guerra per stimolare la crescita economica.
Dalla fine del XVIII secolo, con l'emergere delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche, abbiamo assistito a una grande trasformazione nella natura dei conflitti. Queste guerre del secondo tipo sono diventate guerre totali, che coinvolgono non solo gli eserciti ma l'intera società. In queste guerre totali, la mobilitazione della popolazione diventa essenziale. Gli Stati istituiscono sistemi di coscrizione per reclutare un gran numero di soldati, trasformando la guerra in un vero e proprio sforzo nazionale. Le risorse economiche, industriali e tecnologiche di ogni Paese furono mobilitate per sostenere lo sforzo bellico. Ciò significa che l'intera società fu interessata dalla guerra. I civili erano direttamente coinvolti, sia come combattenti al fronte, sia come lavoratori nelle fabbriche di armamenti, sia come supporto logistico nelle infrastrutture di comunicazione, di trasporto e sanitarie. Anche i civili subiscono le conseguenze della guerra, tra cui la distruzione materiale, lo sfollamento forzato, le privazioni e la perdita di vite umane. Queste guerre totali influenzano profondamente la vita delle società coinvolte. Hanno rafforzato il legame tra lo Stato e la popolazione, trasformando la guerra in un impegno collettivo e nazionale. La distinzione tra fronte e retrovie si è attenuata e la guerra è diventata una realtà onnipresente nella vita quotidiana dei civili.
Tra il 1815 e il 1914, l'Europa visse un periodo di relativa stabilità e pace, spesso definito "pace dei cento anni" o "lungo XIX secolo". Durante questo periodo, le principali potenze europee evitarono i grandi conflitti tra loro, il che portò a una certa stabilità politica, economica e sociale nel continente. Tuttavia, questo periodo di relativa pace non fu privo di tensioni e conflitti più limitati. Durante questo periodo sono scoppiate guerre e crisi regionali, conflitti coloniali e lotte per l'indipendenza nazionale. Inoltre, le rivalità e le tensioni tra le potenze europee si sono sviluppate nel tempo, in particolare a causa dell'imperialismo, delle rivalità coloniali e delle tensioni nazionaliste. L'apparente stabilità di questo periodo fu infranta dallo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914. Questo grande conflitto fu un punto di svolta nella storia e segnò la fine della pace relativa in Europa. Seguì una serie di grandi sconvolgimenti politici, sociali ed economici che segnarono il XX secolo.
Dopo le guerre napoleoniche, nel 1814-1815 si tenne il Congresso di Vienna. Il Congresso riunì le principali potenze europee dell'epoca con l'obiettivo di riorganizzare l'Europa dopo gli sconvolgimenti causati dalle guerre napoleoniche e di prevenire nuovi conflitti. Il Congresso di Vienna stabilì il principio del "Concerto delle Nazioni", noto anche come "Sistema di Vienna". Si trattava di un sistema di diplomazia multilaterale in cui le principali potenze europee si incontravano regolarmente per discutere di questioni internazionali e mantenere la pace in Europa. L'idea era quella di creare un equilibrio di potere ed evitare le guerre distruttive che avevano caratterizzato il periodo napoleonico. Il Concerto delle Nazioni fu un tentativo di stabilire un sistema di relazioni internazionali basato sulla cooperazione, la consultazione e la diplomazia. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, il sistema mostrò i suoi limiti nel tempo, in particolare quando si trattò di affrontare i cambiamenti politici e le aspirazioni nazionaliste emerse nel corso del XIX secolo. Il periodo successivo al Congresso di Vienna fu segnato da tensioni e conflitti, tra cui l'ascesa del nazionalismo, le rivoluzioni del 1848 e le rivalità coloniali. Questi sviluppi portarono alla fine della "pace dei cento anni" e allo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914.
Il Concerto delle Nazioni, noto anche come Sistema Metternich, fu istituito dopo la caduta di Napoleone nel 1815 al Congresso di Vienna. I vincitori della guerra contro Napoleone - Gran Bretagna, Austria, Prussia e Russia, le principali potenze dell'epoca - definirono nuove regole per la gestione delle relazioni internazionali. Queste regole stabilirono un sistema concertato per la gestione delle controversie tra gli Stati, basato sull'equilibrio dei poteri, sul rispetto dei trattati e sulla non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. L'idea era quella di evitare il ripetersi delle devastanti guerre che avevano caratterizzato l'epoca napoleonica. Di conseguenza, pur non essendo un vero e proprio sistema di sicurezza collettiva, il Concerto delle Nazioni favorì la cooperazione tra le potenze e contribuì a mantenere la stabilità in Europa per gran parte del XIX secolo. In effetti, il sistema funzionò relativamente bene per un certo periodo, con una notevole riduzione del numero di guerre importanti in Europa. Tuttavia, è stato anche criticato per aver sostenuto e rafforzato lo status quo, impedendo così il progresso sociale e politico. Inoltre, alla fine non è riuscito a prevenire lo scoppio di guerre mondiali nel XX secolo. Il Concerto delle Nazioni ha rappresentato una pietra miliare nella storia delle relazioni internazionali, gettando le basi della moderna diplomazia multilaterale e fungendo da precursore di organizzazioni internazionali come la Società delle Nazioni e le Nazioni Unite.
L'era post-1945[modifier | modifier le wikicode]
Sebbene durante la Guerra Fredda vi siano state notevoli tensioni, in particolare tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, dal 1945 l'Europa ha goduto di un periodo di pace senza precedenti. Questo periodo, spesso definito "Pax Europaea" o pace europea, ha segnato il più lungo periodo di pace sul continente nella storia moderna. Dopo le guerre napoleoniche, l'Europa ha goduto di un periodo relativamente pacifico, noto come la Pace dei Cento Anni, tra il 1815 e il 1914, nonostante alcuni conflitti di rilievo come la guerra di Crimea e la guerra franco-prussiana. Questo periodo è stato caratterizzato dalla stabilità generale garantita dal Concerto delle Nazioni, che ha promosso l'equilibrio di potere e la risoluzione diplomatica dei conflitti. Allo stesso modo, nonostante le tensioni della guerra fredda e la minaccia di distruzione nucleare dopo il 1945, l'Europa ha goduto di un periodo di pace straordinariamente lungo. Questa "Pax Europaea" può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui la deterrenza nucleare, la creazione e l'espansione dell'Unione Europea, la presenza delle forze della NATO e del Patto di Varsavia e i consistenti aiuti economici forniti dal Piano Marshall. Questi elementi hanno contribuito ad aumentare l'interdipendenza tra le nazioni europee, rendendo il conflitto diretto non solo indesiderabile, ma sempre più impensabile. Di conseguenza, nonostante le sfide e le tensioni del dopoguerra, l'Europa è riuscita a mantenere una pace duratura e significativa.
Fino ai recenti conflitti in Ucraina, la pace in Europa è stata ampiamente mantenuta. Il conflitto in Ucraina, iniziato nel 2014, rappresenta una rottura significativa di questa pace. Tuttavia, è importante notare che questo conflitto è più localizzato e non è sfociato in una guerra su larga scala che ha coinvolto molti Paesi europei, come è avvenuto durante le due guerre mondiali. La crisi ucraina ha messo in luce alcune delle tensioni che ancora esistono in Europa, in particolare tra la Russia e le nazioni occidentali. La situazione in Ucraina è complessa e ha sollevato molte sfide per la stabilità e la sicurezza in Europa. Ha messo in discussione l'efficacia di alcune strutture e accordi che hanno contribuito a mantenere la pace in Europa per decenni. Tuttavia, anche con il conflitto in Ucraina, il periodo successivo al 1945 rimane uno dei più pacifici della storia europea, soprattutto se confrontato con i secoli precedenti, segnati da guerre frequenti e devastanti.
Mentre l'Europa e altre parti del mondo sviluppato hanno goduto di un periodo di relativa pace dopo la Seconda guerra mondiale, molti altri luoghi hanno subito violenti conflitti durante la Guerra fredda e oltre. Questo periodo è stato caratterizzato da una serie di guerre per procura, in cui le grandi potenze hanno sostenuto le parti opposte in conflitti locali senza impegnarsi direttamente in una guerra. Esempi di queste guerre per procura sono la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, la guerra civile in Angola e le guerre in Afghanistan, tra le altre. Questi conflitti hanno spesso causato pesanti perdite tra i civili e hanno avuto un impatto a lungo termine sulla stabilità e sullo sviluppo delle regioni interessate. È un importante promemoria del fatto che, sebbene la "Pax Europaea" e la pace tra le grandi potenze siano importanti, non rappresentano l'intera storia della guerra e della pace nel XX secolo e oltre. I conflitti continuano a interessare molte parti del mondo, spesso con conseguenze devastanti per le popolazioni locali.
Storicamente, i conflitti più importanti erano spesso il risultato di guerre dirette tra grandi potenze. Tuttavia, dalla fine della Seconda guerra mondiale nel 1945, queste potenze hanno in gran parte evitato di entrare in conflitto diretto tra loro. Questa transizione può essere attribuita a diversi fattori. Lo sviluppo e la proliferazione delle armi nucleari hanno creato un deterrente reciproco, dove il costo di un conflitto diretto sarebbe la distruzione totale. Inoltre, la crescente interdipendenza economica ha reso la guerra meno attraente per le grandi potenze, in quanto avrebbe interrotto il commercio mondiale e i mercati finanziari. Inoltre, la creazione di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite ha fornito meccanismi per la risoluzione pacifica delle controversie. Infine, anche la diffusione della democrazia può aver contribuito a questa tendenza, poiché le democrazie tendono a evitare di entrare in guerra tra loro, un concetto noto come "pace democratica".
Dalla fine della Prima guerra mondiale, si è registrata una crescente tendenza a considerare la guerra come illegale o, comunque, da evitare. Si tratta di un cambiamento importante nel modo in cui la guerra è stata percepita storicamente. La creazione della Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale è stato un primo passo verso questa idea. Sebbene la Società delle Nazioni non sia riuscita a prevenire la Seconda guerra mondiale, il suo successore, le Nazioni Unite, è stato fondato su principi simili di risoluzione pacifica delle controversie e di prevenzione della guerra. Inoltre, l'evoluzione del diritto internazionale umanitario e le Convenzioni di Ginevra hanno stabilito alcune regole sulla condotta della guerra, con l'idea di ridurne al minimo gli effetti dannosi. Più recentemente, è stata sviluppata l'idea della "responsabilità di proteggere" (R2P) per giustificare l'intervento internazionale in situazioni in cui uno Stato non è in grado o non vuole proteggere la propria popolazione.
Il filosofo Immanuel Kant abbozzò un piano per la "pace perpetua" in un trattato pubblicato nel 1795. Kant formulò l'idea che le democrazie liberali hanno meno probabilità di entrare in guerra tra loro, una teoria che fu ripresa da altri pensatori politici e divenne nota come "pace democratica". Secondo questa teoria, le democrazie sono meno inclini alla guerra perché i loro governi sono responsabili nei confronti dei cittadini, che sostengono i costi umani ed economici dei conflitti. Kant promosse anche l'idea di una federazione di nazioni libere, una sorta di precursore delle odierne organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. L'obiettivo di questa "federazione di pace" sarebbe stato quello di risolvere i conflitti attraverso la negoziazione e il diritto internazionale piuttosto che con la guerra.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, le nazioni del mondo hanno cercato di creare strutture per mantenere la pace e prevenire futuri conflitti. Questo ha portato alla creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che mira a facilitare la cooperazione internazionale e a prevenire i conflitti. L'ONU è un esempio del cosiddetto sistema di sicurezza collettiva. In questo sistema, gli Stati si impegnano a cooperare per garantire la sicurezza di tutti. Se uno Stato attacca un altro, ci si aspetta che gli altri Stati si schierino con lo Stato attaccato e intervengano per scoraggiare o fermare l'aggressore. Oltre alle Nazioni Unite, sono state istituite altre organizzazioni e trattati per promuovere la sicurezza collettiva, come l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e l'Unione Europea. Questi meccanismi hanno contribuito a prevenire i principali conflitti tra le grandi potenze dal 1945. Tuttavia, hanno anche i loro limiti e non sono sempre efficaci nel prevenire i conflitti, come dimostrano i numerosi conflitti regionali e le guerre civili che hanno avuto luogo dal 1945.
La Carta delle Nazioni Unite, istituita nel 1945, stabilisce le norme essenziali per regolare l'uso della forza tra gli Stati. In generale, vieta l'uso della forza nelle relazioni internazionali, tranne che in due circostanze specifiche. In primo luogo, l'articolo 51 della Carta sancisce il diritto intrinseco degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva in caso di attacco armato. Ciò significa che uno Stato ha il diritto di difendersi se viene attaccato, o se viene attaccato un altro Stato con cui ha concluso un accordo di difesa. In secondo luogo, il Capitolo VII della Carta consente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare misure per preservare o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. Questo può includere l'uso della forza ed è stato alla base dell'autorizzazione di diversi interventi militari, come la Guerra del Golfo del 1991. Sebbene questi principi siano stati concepiti per limitare l'uso della forza e incoraggiare la risoluzione pacifica dei conflitti, sono stati anche controversi, soprattutto per quanto riguarda la loro interpretazione e applicazione in situazioni concrete.
Dal 1945, c'è stata una tendenza crescente verso la regolamentazione e la proibizione della guerra. La Carta delle Nazioni Unite ha rappresentato un'importante pietra miliare in questo sviluppo, vietando l'uso della forza nelle relazioni internazionali se non per autodifesa o su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Oltre alla Carta delle Nazioni Unite, anche altri trattati e convenzioni hanno contribuito a questa tendenza. Ad esempio, le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi hanno stabilito regole severe per la condotta della guerra, con l'obiettivo di limitare le sofferenze umane. Allo stesso modo, i trattati sul controllo degli armamenti, come il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, hanno cercato di limitare la proliferazione delle armi più distruttive. Allo stesso tempo, si è assistito a un crescente movimento verso la risoluzione pacifica dei conflitti. I meccanismi di risoluzione pacifica delle controversie, come la mediazione, l'arbitrato e la composizione giudiziaria, sono sempre più utilizzati per risolvere le controversie internazionali. Tuttavia, sebbene questi sforzi abbiano contribuito a limitare e regolare la guerra, non sono riusciti a eliminarla completamente. I conflitti continuano a verificarsi in molte parti del mondo, sottolineando la sfida persistente di raggiungere una pace duratura e universale.
Le trasformazioni contemporanee della guerra[modifier | modifier le wikicode]
La fine della Guerra Fredda nel 1989, segnata dalla caduta del Muro di Berlino, ha rappresentato un importante punto di svolta nella storia della guerra moderna. Durante questo periodo di tensione bipolare tra Est e Ovest, il mondo era stato diviso tra le due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Sebbene queste due superpotenze non siano mai state in conflitto diretto, hanno sostenuto guerre per procura in tutto il mondo, portando a conflitti prolungati e costosi. La fine della Guerra Fredda ha cambiato le dinamiche della guerra moderna in diversi modi. In primo luogo, ha segnato la fine del bipolarismo che aveva caratterizzato la politica mondiale per quasi mezzo secolo. Di conseguenza, la natura dei conflitti è cambiata, passando dalle guerre tra Stati alle guerre civili e ai conflitti non statali. In secondo luogo, la fine della Guerra Fredda ha dato il via a una nuova ondata di ottimismo sulla possibilità di una pace mondiale duratura. Si sperava che, senza la costante tensione della Guerra Fredda, il mondo potesse compiere progressi significativi verso la risoluzione dei conflitti e la prevenzione delle guerre. Infine, la fine della Guerra Fredda ha portato anche a una serie di nuove sfide, tra cui la proliferazione delle armi nucleari, l'ascesa del terrorismo internazionale e il crescente problema degli Stati falliti. Queste sfide hanno influenzato la natura della guerra moderna e continuano ad essere questioni importanti per la sicurezza globale.
La fine della Guerra Fredda nel 1989 ha segnato una svolta significativa nella storia mondiale, con profonde implicazioni per la natura della guerra e dello Stato moderno. Fino ad allora, l'evoluzione della guerra moderna era strettamente legata all'emergere e al consolidarsi dello Stato nazionale moderno. Questo Stato era caratterizzato da una sovranità territoriale chiaramente definita, dal monopolio della violenza legittima e da una struttura di governo centralizzata. Le guerre erano principalmente scontri tra questi Stati nazionali. Tuttavia, dopo il 1989, molti ricercatori hanno osservato un cambiamento significativo in questa dinamica. Le guerre sono diventate meno frequentemente scontri diretti tra Stati nazionali e più spesso conflitti interni, guerre civili o guerre che coinvolgono attori non statali come gruppi terroristici o milizie. Inoltre, la nozione stessa di sovranità statale ha iniziato a essere messa in discussione. Gli interventi umanitari, le operazioni di mantenimento della pace e la dottrina della "responsabilità di proteggere" hanno messo in discussione l'idea tradizionale di non interferenza negli affari interni di uno Stato. Di conseguenza, si può affermare che la fine della Guerra Fredda ha inaugurato una nuova era in cui il rapporto tra guerra e Stato sta cambiando. I contorni precisi di questa nuova era sono ancora oggetto di dibattito tra studiosi e analisti.
Dalla fine della Guerra Fredda, molti ricercatori ed esperti militari hanno suggerito che la guerra ha subito una significativa trasformazione. Queste trasformazioni sono state attribuite a una serie di fattori, tra cui gli sviluppi della tecnologia militare, la globalizzazione, i cambiamenti nella natura dello Stato e il relativo declino della guerra interstatale. Le guerre di oggi sono spesso descritte come "postmoderne", per riflettere la loro differenza rispetto alle guerre tradizionali dei secoli precedenti. Le guerre postmoderne sono spesso caratterizzate dalla loro complessità, in quanto coinvolgono una moltitudine di attori statali e non statali, e talvolta anche imprese private e organizzazioni non governative. Spesso si svolgono in ambienti urbani, piuttosto che su campi di battaglia tradizionali, e possono coinvolgere attori asimmetrici, come gruppi terroristici o cyber-attaccanti. Queste guerre postmoderne hanno messo in discussione anche le norme e le regole tradizionali della guerra. Ad esempio, come si possono applicare i principi del diritto internazionale umanitario, concepiti per le guerre tra Stati, a conflitti che coinvolgono attori non statali o attacchi informatici? Questo non significa che le vecchie forme di guerra siano completamente scomparse. Ci sono ancora conflitti che assomigliano alle guerre tradizionali. Tuttavia, queste nuove forme di conflitto hanno aggiunto uno strato di complessità all'arte della guerra, richiedendo una riflessione costante e un adattamento alle nuove realtà del XXI secolo.
Il nuovo (dis)ordine mondiale[modifier | modifier le wikicode]
La caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 hanno segnato la fine della Guerra Fredda e del sistema bipolare che aveva dominato la politica mondiale per quasi mezzo secolo. Durante questo periodo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, in quanto superpotenze, avevano creato due blocchi distinti di influenza globale. Nonostante le costanti tensioni e le numerose crisi, il conflitto aperto tra queste due potenze è stato evitato, soprattutto grazie alla minaccia della distruzione reciproca assicurata (MAD) in caso di guerra nucleare. Tuttavia, la fine della Guerra Fredda non ha portato a un "nuovo ordine mondiale" di pace e stabilità, come alcuni avevano sperato. Al contrario, sono emerse nuove sfide e conflitti. Stati falliti, guerre civili, terrorismo internazionale e proliferazione delle armi di distruzione di massa sono diventati problemi importanti. Anche la natura dei conflitti è cambiata, con un aumento della guerra asimmetrica e dei conflitti che coinvolgono attori non statali.
La fine della Guerra Fredda ha inaugurato una nuova era nella politica mondiale, caratterizzata da un certo ottimismo. Molti esperti e politici speravano che la fine della rivalità tra superpotenze avrebbe portato a un'era di maggiore pace e cooperazione internazionale. Il filosofo politico Francis Fukuyama ha addirittura descritto questo periodo come "la fine della storia", suggerendo che la democrazia liberale era finalmente emersa come sistema di governo indiscusso e definitivo. Con la scomparsa dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti si ritrovarono ad essere l'unica superpotenza mondiale, inaugurando quella che alcuni hanno definito l'"iperpotenza" americana. Molti ritenevano che questa nuova era unipolare avrebbe portato maggiore stabilità e pace nel mondo. Allo stesso tempo, la fine della rivalità tra le due superpotenze ha permesso alle Nazioni Unite di svolgere un ruolo più efficace nella prevenzione dei conflitti e nella promozione della pace. L'ostruzione sistematica da parte di uno dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che aveva spesso paralizzato l'organizzazione durante la Guerra Fredda, è stata in gran parte eliminata. Ciò ha portato a un aumento significativo delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite negli anni Novanta.
Con la fine della Guerra Fredda, gli anni '90 hanno visto un aumento significativo delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Le forze di pace delle Nazioni Unite sono state dispiegate nei conflitti di tutto il mondo, con l'obiettivo di mantenere o ripristinare la pace e promuovere la riconciliazione e la ricostruzione. L'idea era che queste operazioni di mantenimento della pace potessero aiutare a prevenire l'escalation dei conflitti, a proteggere i civili, a facilitare la fornitura di aiuti umanitari e a sostenere il processo di pace. In altre parole, queste missioni avrebbero dovuto aiutare a "raccogliere il dividendo della pace" dopo la fine della Guerra Fredda.
La fine della Guerra Fredda e l'emergere di un nuovo sistema internazionale sono stati accompagnati da un crescente discorso sul "disordine globale". Questo termine si riferisce all'idea che il mondo post-Guerra Fredda sia caratterizzato da una maggiore incertezza, da sfide globali complesse e interconnesse e dall'assenza di un quadro chiaro e stabile per la governance internazionale. Diversi fattori hanno contribuito a questa percezione di "disordine globale". In primo luogo, la fine del bipolarismo della Guerra Fredda ha eliminato il quadro chiaro che aveva precedentemente strutturato le relazioni internazionali. Invece di un mondo diviso tra due superpotenze, abbiamo assistito a un panorama più complesso e multipolare con molti attori importanti, tra cui non solo gli Stati nazionali, ma anche le organizzazioni internazionali, le imprese multinazionali, i gruppi non governativi e altri. In secondo luogo, il mondo post-Guerra Fredda è stato caratterizzato da una serie di sfide globali, tra cui il terrorismo transnazionale, le crisi finanziarie, i cambiamenti climatici, le pandemie, la sicurezza informatica e altri problemi che non rispettano i confini nazionali e non possono essere risolti da un singolo Paese o addirittura da un gruppo di Paesi. Infine, è cresciuta la consapevolezza dei limiti e delle contraddizioni delle istituzioni internazionali esistenti. Ad esempio, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e altre organizzazioni sono state criticate per la loro mancanza di rappresentatività, la loro inefficienza e la loro incapacità di rispondere efficacemente alle sfide globali. In questo contesto, la questione di come gestire questo "disordine globale" e costruire un sistema internazionale più equo, efficiente e resistente è diventata una questione centrale della politica mondiale.
Nel suo libro molto discusso "Lo scontro delle civiltà", l'analista politico Samuel P. Huntington ha proposto un nuovo modo di guardare al mondo post-Guerra Fredda. Egli ha sostenuto che le future fonti di conflitto internazionale non riguarderanno tanto le ideologie politiche o economiche, quanto piuttosto le differenze tra le varie grandi civiltà del mondo. Secondo Huntington, il mondo potrebbe essere diviso in circa otto grandi civiltà, basate sulla religione e sulla cultura. Egli prevedeva che i maggiori conflitti del XXI secolo sarebbero stati tra queste civiltà, in particolare tra quella occidentale e quelle islamica e confuciana (quest'ultima rappresentata principalmente dalla Cina).
La fine della guerra fredda ha segnato una transizione significativa nella natura dei conflitti. Mentre il periodo della Guerra Fredda è stato dominato dai conflitti interstatali e dalle guerre per procura tra le due superpotenze, il periodo successivo alla Guerra Fredda ha visto un aumento significativo delle guerre civili e dei conflitti interni. Questi conflitti hanno spesso coinvolto una varietà di attori non statali, come gruppi di ribelli, milizie, gruppi terroristici e bande criminali. Inoltre, sono stati spesso caratterizzati da violenze intense e prolungate, massicce violazioni dei diritti umani e gravi crisi umanitarie. Queste tendenze hanno posto serie sfide alla comunità internazionale. Da un lato, è stato più difficile gestire e risolvere questi conflitti, poiché spesso coinvolgono questioni profondamente radicate come l'identità etnica o religiosa, la governance, la disuguaglianza e l'accesso alle risorse. Inoltre, questi conflitti hanno spesso effetti destabilizzanti che trascendono i confini nazionali, come i flussi di rifugiati, la diffusione di gruppi estremisti e la destabilizzazione regionale.
Storicamente, lo Stato nazionale è stato il principale attore dei conflitti armati e la maggior parte delle guerre è stata combattuta tra Stati. Tuttavia, con il crollo dell'ordine mondiale bipolare alla fine della Guerra Fredda, la natura della guerra ha iniziato a cambiare. La guerra civile, un tempo un tipo di conflitto relativamente raro, è diventata sempre più comune. Questi conflitti interni spesso coinvolgono una varietà di attori non statali, come gruppi di ribelli, milizie, gruppi terroristici e bande criminali. L'aumento delle guerre civili ha posto nuove sfide alla gestione dei conflitti e alla sicurezza internazionale. A differenza delle guerre tra Stati, le guerre civili sono spesso più complesse e difficili da risolvere. Possono coinvolgere problemi profondamente radicati come le divisioni etniche o religiose, la governance, la disuguaglianza e l'accesso alle risorse. Inoltre, questi conflitti hanno spesso conseguenze destabilizzanti che trascendono i confini nazionali, come i flussi di rifugiati, la diffusione di gruppi estremisti e la destabilizzazione regionale.
Dalla fine della Guerra Fredda nel 1989, la natura dei conflitti è cambiata in modo significativo. Mentre un tempo le guerre tra Stati erano la forma di conflitto dominante, l'era post-Guerra Fredda ha visto un aumento delle guerre civili e dei conflitti interni. Queste guerre civili hanno spesso coinvolto una serie di attori non statali, tra cui gruppi armati, milizie, gruppi terroristici e bande. Di conseguenza, spesso si ha la percezione che lo Stato non sia più l'attore principale nei conflitti armati. Questo rappresenta una sfida significativa per il sistema internazionale, che è stato costruito sul principio della sovranità statale e progettato per gestire i conflitti tra Stati. Le guerre civili sono spesso più complesse, più difficili da risolvere e con maggiori probabilità di causare crisi umanitarie rispetto alle guerre tra Stati.
L'era post-Guerra Fredda è stata segnata dall'emergere e dalla proliferazione di una varietà di attori non statali che sono diventati protagonisti di molti conflitti in tutto il mondo. Gruppi terroristici, milizie e organizzazioni criminali come mafie e bande sono diventati i principali protagonisti della violenza e dei conflitti. Questi attori sono spesso riusciti a sfruttare le debolezze dello Stato, in particolare nei Paesi in cui lo Stato è debole o fragile, dove non ha la capacità di controllare efficacemente il territorio o di fornire servizi di base alla popolazione. Spesso hanno usato la violenza per raggiungere i loro obiettivi, sia per minare l'autorità dello Stato, sia per controllare il territorio o le risorse, sia per promuovere una causa politica o ideologica. Ciò ha avuto molte implicazioni per la sicurezza internazionale. Da un lato, ha reso i conflitti più complessi e più difficili da risolvere. Dall'altro, ha portato a un aumento della violenza e dell'instabilità, con conseguenze devastanti per le popolazioni civili.
Il concetto di sovranità, che per lungo tempo è stato fondamentale per strutturare il sistema interstatale e regolare la violenza, è stato messo seriamente in discussione nel contesto post-Guerra Fredda. L'ascesa di attori non statali violenti, come gruppi terroristici e organizzazioni criminali, è spesso avvenuta in aree in cui l'autorità statale è debole o assente, evidenziando i limiti della sovranità come mezzo per mantenere l'ordine e la sicurezza. Inoltre, la proliferazione di conflitti interni e guerre civili ha sollevato importanti questioni sulla responsabilità dello Stato di proteggere la propria popolazione e sul diritto della comunità internazionale di intervenire negli affari di uno Stato sovrano per prevenire o porre fine a gravi violazioni dei diritti umani. Queste sfide hanno portato a importanti discussioni e dibattiti sulla natura e sul significato della sovranità nel XXI secolo. Tra i concetti emersi da questi dibattiti c'è il principio della "responsabilità di proteggere", che afferma che la sovranità non è solo un diritto, ma anche una responsabilità, e che se uno Stato non è in grado o non vuole proteggere la sua popolazione da crimini di massa, la comunità internazionale ha la responsabilità di intervenire.
Gli "Stati falliti" sono Stati che non sono più in grado di mantenere l'ordine e la sicurezza sul loro territorio, di fornire servizi essenziali alla popolazione o di rappresentare il potere legittimo agli occhi dei cittadini. Questi Stati, sebbene siano ancora riconosciuti come sovrani sulla scena internazionale, devono spesso affrontare la perdita di controllo su una parte significativa del loro territorio, insurrezioni o violenti conflitti interni, oltre a corruzione e cattiva governance. Dagli anni Novanta, un gran numero di conflitti, soprattutto in Africa ma anche in altre parti del mondo, ha avuto luogo in questi Stati falliti. Questi conflitti sono spesso caratterizzati da violenze massicce contro i civili, diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e spesso hanno un impatto destabilizzante sui Paesi e le regioni circostanti.
L'aumento dei conflitti interni e delle guerre civili a partire dagli anni Novanta ha indotto a rivalutare il concetto tradizionale di sovranità nel discorso internazionale. Mentre in precedenza la sovranità era vista come una garanzia di ordine e stabilità, che proteggeva gli Stati da interferenze esterne, ha iniziato a essere percepita in modo più problematico. In questo contesto, la sovranità è stata talvolta vista come un ostacolo all'intervento internazionale in situazioni in cui le popolazioni erano minacciate da violenze di massa, genocidi o crimini contro l'umanità. Ciò ha dato origine a dibattiti sulla "responsabilità di proteggere" e sulla questione di quando e come la comunità internazionale debba intervenire per proteggere le popolazioni civili, anche in violazione del tradizionale principio di non interferenza negli affari interni di uno Stato sovrano. Inoltre, la sovranità è stata messa in discussione anche come fonte di legittimità, quando regimi autoritari o dispotici l'hanno usata per giustificare le violazioni dei diritti umani o per resistere alle richieste di riforme democratiche. Pertanto, sebbene la sovranità rimanga un principio fondamentale del sistema internazionale, il suo significato e la sua applicazione sono diventati sempre più contestati nel contesto contemporaneo.
L'emergere di nuove guerre[modifier | modifier le wikicode]
Mary Kaldor, specialista in relazioni internazionali e teoria della guerra, ha introdotto l'idea di "nuove guerre" nel suo libro New and Old Wars: Organised violence in a global era (1999). L'autrice sostiene che i conflitti emersi dopo la fine della Guerra Fredda hanno caratteristiche diverse dalle tradizionali "vecchie guerre", soprattutto a causa dell'impatto della globalizzazione e dei cambiamenti politici, economici e tecnologici.
Le "nuove guerre", secondo Kaldor, sono tipicamente caratterizzate da:
- La degradazione della guerra in violenza diffusa e spesso decentralizzata, che coinvolge una varietà di attori non statali, come milizie, gruppi terroristici, bande criminali e signori della guerra.
- L'attenzione all'identità piuttosto che all'ideologia come motore del conflitto, spesso utilizzando la retorica etnica, religiosa o nazionalista per mobilitare il sostegno e giustificare la violenza.
- La crescente importanza dei crimini contro l'umanità e degli attacchi ai civili, piuttosto che dei combattimenti convenzionali tra forze armate.
- Il crescente coinvolgimento di attori internazionali e transnazionali, sia in termini di finanziamenti e sostegno alle parti in conflitto, sia in termini di sforzi per risolvere i conflitti o mitigarne l'impatto umanitario.
Queste "nuove guerre" presentano sfide diverse in termini di prevenzione, risoluzione e ricostruzione post-conflitto e richiedono strategie e approcci diversi da quelli efficaci nelle "vecchie guerre".
Nella sua analisi delle nuove guerre, Mary Kaldor sostiene che l'era post-1989 è caratterizzata da tre elementi chiave. Il primo è la globalizzazione. La fine del XX secolo è stata caratterizzata da un'accelerazione della globalizzazione, che ha trasformato profondamente le relazioni economiche, politiche e culturali a livello globale. Questa globalizzazione ha ripercussioni dirette sulla natura dei conflitti. Il finanziamento transnazionale dei gruppi armati, la diffusione di ideologie estremiste attraverso i media digitali e il coinvolgimento delle forze internazionali nelle operazioni di mantenimento della pace sono tutti fenomeni che ne sono derivati. In secondo luogo, l'era post-1989 è segnata da una grande trasformazione delle strutture politiche. Con la fine della Guerra Fredda, molti regimi comunisti e autoritari sono crollati, dando vita a nuove democrazie. Allo stesso tempo, sono aumentati gli interventi internazionali negli affari interni degli Stati, spesso giustificati dalla necessità di proteggere i diritti umani o di prevenire un genocidio. Infine, Kaldor sottolinea un cambiamento fondamentale nella natura della violenza. I conflitti sono diventati più diffusi e decentrati, coinvolgendo una moltitudine di attori non statali. Gli attacchi deliberati contro i civili, lo sfruttamento dell'identità etnica o religiosa a fini di mobilitazione e l'uso di tattiche di terrore sono diventati comuni. Secondo Kaldor, questi tre elementi interagiscono per creare un nuovo tipo di guerra, profondamente diverso dalle tradizionali guerre interstatali del passato.
Secondo Mary Kaldor, l'era moderna ha visto uno spostamento dalle ideologie alle identità come principali motori di conflitto. In questo contesto, le battaglie non sono più combattute per ideali politici, ma per l'affermazione e la difesa di particolari identità, spesso etniche. Questo sviluppo segna un passo verso l'esclusione, in quanto può portare a una maggiore polarizzazione e divisione della società. A differenza di un dibattito ideologico in cui possono esserci compromessi e consenso, la difesa dell'identità può creare una dinamica "noi contro loro", che può essere estremamente distruttiva.
Mary Kaldor sottolinea questo cambiamento cruciale nei motivi di conflitto. Quando le lotte erano incentrate sulle ideologie, come il socialismo internazionale, erano più inclusive. L'obiettivo era convincere e radunare il maggior numero possibile di persone a una causa, a un sistema di pensiero o a una visione del mondo. Al contrario, quando i conflitti si basano sull'identità, in particolare sull'identità etnica, tendono a essere più esclusivi. La lotta per una specifica identità etnica delimita un particolare gruppo come "noi", che inevitabilmente implica un "loro" distinto e diverso. Questo crea una dinamica di esclusione che può essere profondamente divisiva e portare alla violenza intercomunitaria. Si tratta di un cambiamento profondo rispetto ai conflitti ideologici del passato.
D'altra parte, secondo Kaldor, la guerra non è più per il popolo, ma contro il popolo, il che significa che ci troviamo sempre più spesso di fronte ad attori che non rappresentano lo Stato e che non aspirano nemmeno ad esserlo. In precedenza, i conflitti erano generalmente combattuti dagli Stati o da attori che aspiravano a controllare lo Stato. La guerra veniva quindi combattuta "per il popolo", nel senso che l'obiettivo era ottenere il controllo del governo per servire, teoricamente, gli interessi del popolo. Nel contesto odierno, l'autrice sostiene che la guerra è spesso combattuta "contro il popolo". Ciò significa che attori non statali come gruppi terroristici, milizie o bande sono sempre più coinvolti nei conflitti. Questi gruppi non cercano necessariamente di controllare lo Stato e possono di fatto impegnarsi in atti di violenza diretti principalmente contro le popolazioni civili. Di conseguenza, la natura della guerra si è evoluta fino a diventare meno una lotta per il controllo dello Stato e più una fonte di violenza contro la popolazione.
È sempre più una guerra di banditi, in cui l'obiettivo è estrarre le risorse naturali dei Paesi per l'arricchimento personale di alcuni gruppi. Mary Kaldor descrive questa trasformazione come una forma di "guerra dei banditi". In questo contesto, la guerra non è condotta per raggiungere obiettivi politici tradizionali, come il controllo dello Stato o la difesa di un'ideologia, ma piuttosto per l'arricchimento personale o di gruppo. Questa nuova forma di conflitto è spesso caratterizzata dall'estrazione e dallo sfruttamento delle risorse naturali nelle regioni in conflitto. Queste "guerre dei banditi" possono avere conseguenze disastrose per le popolazioni locali, non solo per la violenza diretta che comportano, ma anche per la destabilizzazione economica e sociale che generano. Spesso, le risorse che potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo economico e sociale vengono invece dirottate verso interessi o gruppi privati, il che può esacerbare la povertà e le disuguaglianze.
L'era post-Guerra Fredda ha visto l'emergere di un'economia di guerra globale, con attori non statali come organizzazioni criminali, gruppi terroristici e milizie private che giocano un ruolo sempre più importante. Questi gruppi spesso si affidano a reti transnazionali per finanziare le loro operazioni, attraverso il traffico di droga, il commercio illegale di armi, il contrabbando di merci e altre forme di criminalità organizzata. Questa economia di guerra ha l'effetto di prolungare i conflitti, fornendo ai gruppi armati un mezzo per finanziare le loro attività senza bisogno del sostegno statale o popolare. Allo stesso tempo, contribuisce all'instabilità regionale, poiché i profitti di queste attività illegali sono spesso utilizzati per finanziare altre forme di violenza e disordine. Inoltre, queste reti transnazionali rendono più difficile il controllo e la risoluzione dei conflitti da parte delle autorità statali e delle organizzazioni internazionali. Spesso operano al di fuori dei quadri giuridici tradizionali e possono diffondersi in diversi Paesi o regioni, complicando gli sforzi per combatterle. Infine, il coinvolgimento di attori non statali nei conflitti può avere effetti destabilizzanti sugli Stati, minando la loro autorità e la capacità di mantenere l'ordine e la sicurezza. Ciò può a sua volta aggravare le tensioni e i conflitti, creando un circolo vizioso di violenza e instabilità.

L'approccio di Mary Kaldor alla guerra può essere visto come depoliticizzante. L'autrice sostiene che i conflitti contemporanei sono motivati principalmente da fattori etnici, religiosi o identitari piuttosto che da ideologie politiche. Questo segna una rottura con le guerre del passato, spesso combattute in nome di un'ideologia politica, come il comunismo o il fascismo. In questa prospettiva, la guerra non è più una continuazione della politica con altri mezzi, come diceva il teorico militare Carl von Clausewitz, ma piuttosto un atto di violenza motivato da differenze di identità. Ciò suggerisce che le soluzioni tradizionali, come i negoziati politici o gli accordi di pace, potrebbero non essere sufficientemente efficaci per risolvere questi conflitti.
La visione tradizionale della guerra, descritta da Carl von Clausewitz, la vede come "la continuazione della politica con altri mezzi". Da questa prospettiva, la guerra è vista come uno strumento che gli Stati utilizzano per raggiungere specifici obiettivi politici. Tuttavia, secondo Mary Kaldor e altri studiosi simili, questa dinamica è cambiata. Essi sostengono che nei conflitti contemporanei, gli obiettivi politici tradizionali sono spesso messi in ombra da altre motivazioni, come l'identità etnica o religiosa, o il desiderio di accedere a risorse economiche. In questi casi, la guerra non è più al servizio della politica, ma sembra piuttosto essere motivata da interessi economici o identitari.
Ci troviamo di fronte a Stati emersi dalla decolonizzazione, soprattutto nelle regioni meridionali, che hanno subito difficili processi di nation-building. Spesso questi Stati non hanno ricevuto gli strumenti necessari per costruire una struttura solida e duratura. Di conseguenza, sono diventati fragili e instabili, una situazione che favorisce l'emergere di conflitti e violenze. Quando questi Stati iniziano a disintegrarsi, lasciano spazio a un certo grado di caos in cui i gruppi etnici possono trovarsi in conflitto tra loro. Allo stesso tempo, banditi e altri attori non statali approfittano di questa instabilità per promuovere i propri interessi. L'assenza di un'autorità statale forte ed efficace contribuisce a perpetuare questo disordine e impedisce l'instaurazione di una pace duratura.
La prospettiva avanzata da Mary Kaldor, che suggerisce la scomparsa del conflitto politico a favore di una forma di disordine globale, ha avuto un impatto significativo sulla nostra comprensione delle trasformazioni belliche contemporanee. Secondo questa visione, gli Stati deboli o in crisi sarebbero incapaci di garantire la stabilità sul loro territorio, aprendo così la porta a tutta una serie di minacce e pericoli. In assenza di una struttura e di un controllo statali, può emergere il caos, generando spesso conflitti etnici, attività criminali e accesso illimitato alle risorse naturali da parte di vari gruppi non statali. È in questo contesto che assistiamo a un aumento delle guerre civili e dei conflitti interni, alimentati da reti transnazionali come le mafie. L'assenza di uno Stato forte e stabile porta a un panorama conflittuale complesso, in cui i tradizionali conflitti politici lasciano il posto a una moltitudine di minacce più diffuse e decentrate. Questo approccio ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare la nostra comprensione dei conflitti moderni e delle sfide alla pace e alla sicurezza globale.
Il disordine che si è verificato in Medio Oriente ha suscitato molte preoccupazioni, spesso legate al concetto di Stato e al suo ruolo di entità stabilizzatrice. Quando lo Stato sembra incapace di mantenere il controllo e l'ordine, ciò può portare a una moltitudine di minacce e rischi. Nel caso del Medio Oriente, queste minacce sono diverse. Vanno dall'instabilità sociale ed economica all'interno dei Paesi, all'aumento dei conflitti settari ed etnici, al rischio di terrorismo internazionale. Questi conflitti possono anche portare a crisi umanitarie, spostamenti massicci di popolazione e problemi di rifugiati su scala globale. L'assenza di un controllo statale efficace può anche consentire ad attori non statali, come i gruppi terroristici, di acquisire influenza e potere. Ad esempio, lo Stato Islamico (EI) è riuscito a emergere e a prendere il controllo di vasti territori in Iraq e Siria sfruttando la debolezza degli Stati locali e il caos imperante. Ciò illustra chiaramente la complessità delle questioni legate all'assenza di controllo statale e all'instabilità e le sfide che esse pongono alla sicurezza internazionale.
La nostra concezione del sistema internazionale è fortemente radicata nel concetto di Stato. Lo Stato è generalmente considerato l'attore principale della politica internazionale, che garantisce sicurezza, ordine e stabilità all'interno dei propri confini. Il collasso di uno Stato o la sua incapacità di esercitare efficacemente la propria autorità può avere conseguenze destabilizzanti sia per il Paese interessato sia per la comunità internazionale. Il crollo di uno Stato può portare a un vuoto di potere, creando un terreno fertile per l'emergere di gruppi armati non statali, conflitti interni e violenza diffusa. Può anche portare a una crisi umanitaria, con rifugiati in fuga dalla violenza e dalla povertà, che a sua volta può creare tensioni nei Paesi vicini e oltre. L'incapacità di uno Stato di controllare il proprio territorio può anche rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale. Può creare uno spazio in cui il terrorismo, la criminalità organizzata e altre attività illecite possono prosperare, con conseguenze potenzialmente gravi oltre i confini dello Stato interessato. Per questi motivi, il collasso degli Stati è spesso considerato una delle principali fonti di instabilità e insicurezza del sistema internazionale. È quindi fondamentale che la comunità internazionale collabori per prevenire il collasso degli Stati e per contribuire a ripristinare la stabilità quando questo si verifica.
Nella storia delle relazioni internazionali, ci sono stati casi in cui le potenze straniere hanno sostenuto regimi autoritari o dittatoriali per preservare la stabilità regionale, contenere un'ideologia concorrente, ottenere accesso alle risorse o per ragioni strategiche. Tuttavia, questa pratica pone problemi etici significativi e può essere in contraddizione con i principi democratici e i diritti umani che queste potenze straniere spesso affermano di difendere. Nel contesto della politica internazionale, il sostegno a un regime autoritario può talvolta riflettere la preferenza per uno Stato che controlla saldamente il proprio Paese, anche se ciò avviene a spese dei diritti umani o della democrazia. Questa tendenza deriva spesso da una preoccupazione per la stabilità regionale e la sicurezza internazionale. L'idea è che, sebbene questi regimi possano essere repressivi e antidemocratici, possano anche fornire un certo grado di stabilità e prevedibilità. Possono prevenire il caos o la violenza che potrebbero altrimenti emergere in assenza di un forte controllo statale e possono anche fungere da contrappeso ad altre forze regionali o internazionali percepite come una minaccia.
Lo Stato nazionale rimane una struttura fondamentale per organizzare e comprendere le nostre società e il mondo in cui viviamo. È attraverso lo Stato che generalmente definiamo la nostra identità nazionale, è lo Stato che rappresenta i cittadini sulla scena internazionale ed è attraverso gli Stati che più spesso strutturiamo le nostre interazioni e relazioni internazionali. Lo Stato nazionale è anche uno strumento fondamentale per mantenere l'ordine pubblico, garantire i diritti e le libertà dei cittadini, fornire servizi pubblici essenziali e assicurare la sicurezza nazionale. Rappresenta quindi un grado di stabilità e prevedibilità in un mondo altrimenti complesso e in costante cambiamento.
Il concetto di "guerra postmoderna" si riferisce a un'evoluzione fondamentale dell'arte della guerra, che si allontana dai paradigmi tradizionali legati agli Stati nazionali in conflitto per ragioni politiche o territoriali. Il cuore della guerra postmoderna è la depoliticizzazione del conflitto, in cui le motivazioni politiche o il controllo del territorio sono sostituiti da una moltitudine di fattori come le dispute etniche, religiose, economiche o ambientali. Questa nuova era della guerra è caratterizzata anche dalla deterritorializzazione, in cui i conflitti non sono più limitati a regioni specifiche, ma possono diventare transnazionali o globali, come nel caso del terrorismo internazionale o dei conflitti informatici. Uno degli aspetti più inquietanti della guerra postmoderna è la privatizzazione della violenza, con attori non statali come gruppi terroristici, milizie private e organizzazioni criminali che giocano un ruolo sempre più importante. Allo stesso tempo, si è intensificato l'impatto dei conflitti sui civili, con effetti diretti devastanti, come la violenza, e indiretti, come lo spostamento della popolazione, la carestia e le malattie.
Sebbene le democrazie abbiano meno probabilità di entrare in guerra tra loro - un concetto noto come "pace democratica" - continuano a essere coinvolte in conflitti militari. Questi conflitti spesso coinvolgono Paesi non democratici o fanno parte di missioni internazionali di mantenimento della pace o di lotta al terrorismo. I Paesi del Nord tendono anche a utilizzare mezzi diversi dalla guerra convenzionale per raggiungere i loro obiettivi di politica estera. Ad esempio, possono utilizzare la diplomazia, le sanzioni economiche, gli aiuti allo sviluppo e altri strumenti di "soft power" per influenzare altre nazioni. Inoltre, la tecnologia ha cambiato la natura della guerra. I Paesi del Nord, in particolare, tendono a fare molto affidamento sulla tecnologia avanzata nella loro condotta di guerra. L'uso di droni, attacchi informatici e altre forme di guerra non convenzionale è sempre più comune. In definitiva, sebbene la natura e la condotta della guerra possano cambiare, l'uso della forza militare rimane purtroppo una caratteristica della politica internazionale. È quindi fondamentale continuare a cercare modi per prevenire i conflitti e promuovere la pace e la sicurezza globale.
Verso una guerra postmoderna[modifier | modifier le wikicode]
I modelli di guerra sono cambiati in modo significativo, soprattutto nei Paesi occidentali. Le caratteristiche principali di questo cambiamento sono state un maggiore uso della tecnologia, una maggiore professionalizzazione degli eserciti e una crescente avversione per le perdite umane, spesso definita "allergia al rischio". Il concetto di "Western Way of War" sottolinea la preferenza per la tecnologia avanzata e la superiorità aerea nella conduzione della guerra. La tecnologia è diventata un elemento chiave nella conduzione della guerra, con lo sviluppo di armi sempre più sofisticate, l'uso di droni e la crescente importanza della guerra informatica. Inoltre, la crescente professionalizzazione delle forze armate ha portato a un addestramento più avanzato e a una maggiore specializzazione del personale militare. Gli eserciti professionali sono sempre più diffusi e la coscrizione o la leva sono sempre meno frequenti nei Paesi occidentali. L'"allergia al rischio" è stata esacerbata dal fatto che le società occidentali hanno sempre più difficoltà ad accettare la perdita di vite umane in guerra. Questo ha portato a preferire gli attacchi aerei e l'uso dei droni, che permettono di condurre operazioni militari senza mettere in pericolo la vita dei soldati.
Attualmente si assiste a un chiaro declino dell'accettazione sociale della perdita di vite umane nelle guerre combattute all'estero. Le persone sono sempre meno disposte a sostenere conflitti che comportano la perdita di vite umane, in particolare dei propri cittadini. Questa situazione è in parte alimentata dalla copertura mediatica onnipresente e istantanea dei conflitti, che rende i costi umani della guerra più visibili e reali per la popolazione generale. Allo stesso tempo, i progressi tecnologici hanno reso possibile combattere le guerre da una distanza maggiore. L'uso di droni, missili di precisione e altre tecnologie all'avanguardia consente di effettuare attacchi a distanza, senza alcun rischio diretto per le truppe a terra. Questa forma di guerra tecnologica è in gran parte il risultato di sviluppi tecnologici facilitati dai governi.
L'uso dei droni nei conflitti moderni ha cambiato radicalmente la natura della guerra. Il pilotaggio dei droni consente di condurre operazioni militari, compresi attacchi letali, a migliaia di chilometri di distanza. Il personale che controlla questi droni spesso lo fa da basi situate al di fuori del campo di battaglia, a volte persino in un altro Paese. Ciò solleva una serie di questioni etiche e morali. Da un lato, riduce al minimo i rischi per le forze militari che controllano i droni. Dall'altro, può creare un distacco tra l'atto di uccidere e la realtà della guerra, che a sua volta può avere conseguenze psicologiche per gli operatori dei droni. Inoltre, può rendere il processo decisionale sull'uso della forza meno immediato e meno personale, abbassando potenzialmente la soglia dell'uso della forza. L'uso dei droni ha anche implicazioni strategiche. Permette di effettuare attacchi precisi con un rischio minimo per le forze militari, ma può anche causare vittime civili e danni collaterali. L'uso dei droni solleva quindi importanti questioni di diritto umanitario internazionale e di responsabilità.
La domanda è se questo allontanamento stia cambiando la natura della guerra, se si tratti di un'evoluzione, di una rivoluzione negli affari militari con il concetto di guerra "a morte zero", se dobbiamo andare oltre Clausewitz quando parliamo di Mary Kaldor, per esempio. Mettere la guerra a distanza grazie alla tecnologia, in particolare ai droni, solleva la questione se la natura stessa della guerra stia cambiando. La possibilità di condurre operazioni militari senza mettere direttamente in pericolo la vita dei propri soldati cambia innegabilmente l'esperienza della guerra e può influenzare il processo decisionale sull'uso della forza. Il concetto di "guerra a zero morti" può sembrare attraente dal punto di vista di coloro che fanno la guerra, ma non dovrebbe oscurare il fatto che anche una guerra combattuta a distanza può avere conseguenze devastanti per i civili e causare la perdita di vite umane. Se dobbiamo "andare oltre Clausewitz" è una questione dibattuta tra i teorici militari. Clausewitz sosteneva che la guerra è un'estensione della politica con altri mezzi. Sebbene la tecnologia abbia cambiato il modo di combattere la guerra, si può sostenere che l'obiettivo finale rimane lo stesso: raggiungere obiettivi politici. Da questo punto di vista, il pensiero di Clausewitz è ancora attuale. Detto questo, il lavoro di studiosi come Mary Kaldor ha evidenziato che le forme contemporanee di violenza organizzata possono differire dai modelli tradizionali di guerra previsti da Clausewitz. Le "nuove guerre", secondo Kaldor, sono caratterizzate dalla violenza all'interno degli Stati, dal coinvolgimento di attori non statali e dalla crescente importanza delle identità piuttosto che delle ideologie. Queste trasformazioni potrebbero portarci a ripensare alcune delle teorie classiche della guerra.
La guerra sta davvero cambiando? È qualcosa che sta diventando sempre più spoliticizzato nei Paesi del Sud, e in definitiva è qualcosa di eminentemente tecnologico in cui non c'è più alcun legame con ciò che accade sul campo? La percezione della guerra come qualcosa di lontano e tecnologico, soprattutto in Occidente, può essere un fenomeno in crescita. Tuttavia, affermare che la guerra si stia "depoliticizzando" richiede un'analisi più sfumata.
Nei Paesi del Sud, nonostante l'aumento dei conflitti intrastatali e della violenza perpetrata da attori non statali, questi conflitti rimangono profondamente politici. Possono essere legati a lotte per il controllo delle risorse, a differenze etniche o religiose, ad aspirazioni di autodeterminazione o a reazioni alla corruzione e al malgoverno. Inoltre, la violenza organizzata può avere importanti implicazioni politiche, influenzando le strutture di potere, alterando le relazioni tra i gruppi e plasmando il futuro politico di un Paese. Nei Paesi del Nord, l'uso di tecnologie come i droni può dare l'impressione di una "disumanizzazione" della guerra, in cui gli atti di violenza sono commessi a distanza e in modo apparentemente distaccato. Tuttavia, questo approccio alla guerra può avere le sue implicazioni politiche. Ad esempio, l'apparente facilità con cui la violenza può essere inflitta a distanza può influenzare le decisioni su quando e come usare la forza. Inoltre, il modo in cui queste tecnologie vengono utilizzate e regolate può dare origine a importanti dibattiti politici. È quindi fondamentale capire che, sebbene la natura e la condotta della guerra possano evolversi, la guerra rimane un'impresa profondamente politica e le sue conseguenze si fanno sentire ben oltre il campo di battaglia.
Stiamo parlando di tutte le guerre che vediamo sugli schermi, come la Guerra del Golfo negli anni '90, che sembrano lontane perché non le viviamo nemmeno attraverso le nostre famiglie o le nostre esperienze. La Guerra del Golfo degli anni '90 ha segnato un punto di svolta nel modo in cui la guerra viene percepita dal pubblico. La guerra è stata ampiamente coperta dai media, con immagini della guerra trasmesse in diretta dalla televisione. Questo ha contribuito a creare una certa distanza tra il pubblico e il conflitto reale. Guardando la guerra attraverso lo schermo televisivo, essa può sembrare distante e scollegata dalla nostra vita quotidiana. Questa distanza può essere accentuata anche dal fatto che sempre meno persone nei Paesi occidentali hanno un'esperienza diretta di servizio militare. Mentre un tempo il servizio militare era un'esperienza comune per molti uomini (e alcune donne), oggi molti Paesi hanno eserciti completamente professionali. Ciò significa che la guerra è vissuta direttamente da una percentuale minore della popolazione. Sebbene la guerra possa sembrare lontana per molte persone nei Paesi occidentali, ha conseguenze molto reali per coloro che ne sono direttamente coinvolti, sia che si tratti dei militari dispiegati nelle zone di conflitto che delle popolazioni locali colpite. Inoltre, anche se un conflitto può sembrare geograficamente lontano, può avere conseguenze indirette attraverso fenomeni come i flussi di rifugiati, l'impatto economico o le minacce alla sicurezza internazionale.
Appendici[modifier | modifier le wikicode]
- Leander, Anna. Wars and the Un-Making of States: Taking Tilly Seriously in the Contemporary World
- Goldstone , Jack A. States Making Wars Making States Making Wars... in Contemporary Sociology, Vol. 20, No. 2 (Mar., 1991), pp. 176-178. Url: https://www.jstor.org/stable/pdf/2072886.pdf?acceptTC=true
- Kaldor, Mary. New & Old Wars. Stanford, CA: Stanford UP, 2007. Print.
- La naissance de la guerre moderne : war-making et state-making dans une perspective occidentale
- Tilly, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. url: http://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/q3/28/02/reading_response_4_2.pdf
- NATO StratCom COE; Mark Laity. (2018, August 10). What is War?. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Gj-wsdGL4-M