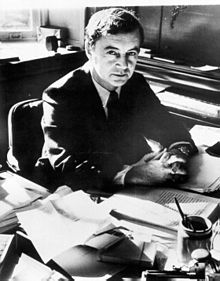Interazionismo e Costruttivismo
La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales
L'interazionismo e il costruttivismo sono due quadri teorici chiave che arricchiscono la nostra comprensione delle dinamiche nella scienza politica.
L'interazionismo è una teoria che si concentra sulle relazioni tra gli individui per decifrare il comportamento politico. Postula che gli individui non siano semplicemente il prodotto del loro ambiente o delle strutture sociali, ma che svolgano un ruolo attivo nel plasmare e trasformare queste strutture attraverso le loro interazioni. In un contesto politico, l'interazionismo può aiutare ad analizzare come interagiscono politici, burocrati ed elettori e come queste interazioni determinano le politiche pubbliche e i risultati elettorali.
Il costruttivismo, invece, si concentra sul modo in cui gli attori politici utilizzano le loro idee e convinzioni per costruire la loro realtà sociale e politica. Secondo questo approccio, le strutture politiche e sociali non sono prestabilite, ma piuttosto vengono costruite dagli attori politici attraverso i loro discorsi, le loro idee e le loro azioni. Il costruttivismo, nel campo delle scienze politiche, esplora come le credenze e le idee degli attori politici diano forma alle strutture politiche e alle politiche pubbliche.
Questi due quadri teorici possono essere utilizzati insieme per ottenere una comprensione più profonda della politica. Ad esempio, l'interazionismo può essere utilizzato per esaminare come gli attori politici lavorano insieme per sviluppare le politiche, mentre il costruttivismo può essere utilizzato per analizzare come queste politiche sono influenzate dalle idee e dalle convinzioni di questi attori.
Interazionismo e costruttivismo
L'interazionismo e il costruttivismo sono due quadri teorici essenziali che sono emersi da contesti produttivi distinti e hanno plasmato la nostra comprensione dei processi sociali e politici.
L'interazionismo
L'interazionismo, in particolare l'interazionismo simbolico, affonda le sue radici nella Scuola di Chicago dei primi del Novecento. I rapidi e massicci cambiamenti subiti dalla città di Chicago in quel periodo hanno fatto da sfondo allo sviluppo di questo approccio teorico.
Chicago è passata in pochi decenni da una piccola città a una fiorente metropoli, con una popolazione esplosa a causa dell'immigrazione e delle migrazioni interne. Questo ha portato a profondi cambiamenti nella struttura sociale e spaziale della città. I nuovi arrivati, provenienti da contesti etnici e culturali diversi, si sono stabiliti in quartieri distinti, creando un mosaico di comunità culturali in città. Di fronte a questi cambiamenti, i sociologi della Scuola di Chicago hanno cercato di capire come gli individui e i gruppi interagissero in questi nuovi ambienti urbani. Iniziarono a sviluppare teorie interazioniste che sottolineavano il ruolo delle interazioni sociali nella formazione dell'identità individuale e collettiva, nella costruzione delle comunità e nella creazione dell'ordine sociale. I sociologi della Scuola di Chicago, come Robert E. Park, Ernest Burgess e Herbert Blumer, hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell'interazionismo. Essi hanno posto l'accento sull'osservazione diretta delle interazioni sociali e hanno utilizzato metodi di ricerca innovativi, come lo studio etnografico e l'osservazione dei partecipanti, per studiare le interazioni sociali nelle metropoli in trasformazione.
L'interazionismo è nato quindi dallo sforzo di comprendere le trasformazioni sociali e spaziali in atto in una metropoli in rapida evoluzione. Continua a essere un approccio teorico fondamentale in sociologia e scienze politiche, che aiuta a spiegare come le interazioni sociali plasmino gli individui, i gruppi e la società nel suo complesso.
I sociologi della Scuola di Chicago sono stati tra i primi ad affrontare di petto queste sfide complesse e interconnesse. Il loro lavoro ha evidenziato le difficoltà di integrazione sociale, professionale e culturale incontrate dai nuovi arrivati in città. Hanno osservato come queste sfide abbiano portato a un'etnicizzazione della città, con diversi gruppi etnici che si sono insediati in quartieri distinti, creando un complesso "mosaico etnico". Hanno anche studiato l'emergere della marginalità sociale, compresa la criminalità e la delinquenza, in questo contesto urbano in evoluzione. I fenomeni di marginalità e devianza sociale, come le bande e la criminalità organizzata, sono stati di grande interesse per questi sociologi. Essi cercavano di capire perché certi individui e gruppi scegliessero di impegnarsi in attività illegali e come queste scelte fossero modellate dal loro ambiente sociale ed economico. Il lavoro della Scuola di Chicago sulla devianza sociale è stato particolarmente influente. Ricercatori come Clifford R. Shaw e Henry D. McKay hanno sviluppato la teoria della disorganizzazione sociale, che suggerisce che il crimine è principalmente il risultato della disintegrazione delle istituzioni sociali tradizionali nelle aree urbane svantaggiate. Questa teoria ha influenzato profondamente il modo in cui oggi comprendiamo il crimine e la devianza. I sociologi della Scuola di Chicago sono stati pionieri nello studio dei fenomeni urbani e dei problemi sociali associati alla rapida urbanizzazione e industrializzazione. Il loro approccio interazionista ha aperto la strada a una comprensione più sfumata di come gli individui e i gruppi interagiscono con il loro ambiente sociale e di come queste interazioni plasmino le loro esperienze e i loro comportamenti.
L'interazionismo, come concettualizzato dalla Scuola di Chicago, pone l'interazione al centro dell'esperienza sociale. Questo approccio enfatizza l'idea che il comportamento individuale sia plasmato dalle interazioni e dagli scambi con gli altri. In altre parole, gli individui non agiscono in modo isolato, ma sono costantemente impegnati in un processo di interazione con chi li circonda. Da questa prospettiva, la società non è semplicemente un insieme di strutture rigide che determinano il comportamento degli individui, ma una rete dinamica di interazioni sociali. Gli individui non sono semplici destinatari passivi delle norme sociali, ma svolgono un ruolo attivo nel creare e modificare tali norme attraverso le loro interazioni. Ciò significa che per comprendere il comportamento degli individui, dobbiamo esaminare la natura delle interazioni in cui sono impegnati. Ad esempio, come interagiscono gli individui in contesti diversi, come la famiglia, il lavoro, la scuola, ecc. Come queste interazioni influenzano le loro credenze, i loro atteggiamenti e i loro comportamenti? E come queste interazioni contribuiscono alla creazione e alla trasformazione delle strutture sociali? Inoltre, l'interazionismo sostiene che tutte le relazioni umane comportano una qualche forma di scambio o interazione, sia essa verbale o non verbale, formale o informale, positiva o negativa. Di conseguenza, l'interazionismo offre un valido quadro di riferimento per lo studio dei fenomeni sociali, dalle interazioni quotidiane tra individui ai più ampi processi di cambiamento sociale e politico.
L'interazionismo sottolinea che il comportamento di un individuo è profondamente influenzato dalle sue interazioni con gli altri e non esiste in modo isolato dal suo contesto sociale. Questa prospettiva evidenzia il fatto che il comportamento non è mai statico o costante, ma viene sempre trasformato attraverso le interazioni sociali. È qui che l'interazionismo si differenzia dalla teoria funzionalista. Il funzionalismo, concentrandosi sul modo in cui le diverse parti della società lavorano insieme per mantenere l'equilibrio e l'armonia, tende a vedere il comportamento individuale come ampiamente determinato dal ruolo funzionale che svolgono nella società. Questa prospettiva può essere talvolta criticata per la mancanza di considerazione delle dinamiche di potere, del conflitto e del cambiamento sociale. L'interazionismo, invece, pone l'accento sul modo in cui gli individui negoziano, interpretano e contestano i loro ruoli sociali attraverso le interazioni con gli altri. Sottolinea la complessità e la dinamica del comportamento umano, piuttosto che la sua conformità a norme funzionali predeterminate. Inoltre, l'interazionismo vede la società non come una struttura fissa, ma come un processo in costante evoluzione plasmato dalle interazioni umane. L'interazionismo offre quindi una prospettiva più sfumata e dinamica sul comportamento umano e sulla società. Evidenzia il ruolo attivo svolto dagli individui nel creare e trasformare la loro realtà sociale e il modo in cui il comportamento è plasmato dalle interazioni e dagli scambi con gli altri.
I principi dell'interazione sono quattro:
- Unità di interazione: l'interazionismo riconosce che le interazioni possono avvenire tra individui (interazione interpersonale) o gruppi (interazione di gruppo). Queste unità di interazione sono gli attori fondamentali della società.
- Regole dell'interazione: le interazioni sono governate da regole, che possono essere esplicite (come leggi o regolamenti) o implicite (come norme sociali non scritte). Queste regole aiutano a strutturare le interazioni e a dare un significato al comportamento.
- Processo ordinato: l'interazionismo vede le interazioni sociali come un processo ordinato. Ciò significa che le interazioni seguono determinate sequenze e schemi che possono essere analizzati e compresi. Ad esempio, l'interazionismo è stato utilizzato per studiare fenomeni come la violenza, collocandoli nel loro specifico contesto di interazione.
- Scambio: l'interazionismo sottolinea l'idea che le interazioni sociali siano fondamentalmente basate sullo scambio. Questo può essere uno scambio di beni o servizi, ma anche di informazioni, sentimenti, idee e così via. Ciò sottolinea la natura reciproca e influenzante delle interazioni sociali.
Questi principi forniscono un quadro di riferimento per comprendere come gli individui e i gruppi interagiscono tra loro, come queste interazioni sono strutturate e regolate e come contribuiscono alla creazione e al cambiamento sociale.
Il costruttivismo
Il costruttivismo, che ha preso piede negli anni '60 e '70, è una scuola di pensiero che ha avuto una profonda influenza su molti campi, tra cui la sociologia, la filosofia, l'antropologia e la linguistica. Il costruttivismo si basa sull'idea che la conoscenza non viene semplicemente scoperta, ma viene costruita attivamente dall'individuo o dalla società. Jean Piaget, famoso psicologo svizzero, è una figura chiave del costruttivismo, anche se il suo lavoro è generalmente classificato nel campo della psicologia dello sviluppo. Piaget ha proposto che i bambini costruiscano attivamente la loro comprensione del mondo attraverso l'interazione con l'ambiente. Secondo la sua teoria, lo sviluppo cognitivo avviene attraverso una serie di stadi, ciascuno dei quali rappresenta un livello più complesso e sofisticato di comprensione del mondo. Nel campo della linguistica, Piaget considera il linguaggio come un costrutto sociale e cognitivo. Secondo Piaget, i bambini acquisiscono il linguaggio non semplicemente memorizzando parole e regole, ma costruendo attivamente la loro comprensione del linguaggio attraverso le interazioni con gli altri. Questo riflette l'approccio generale del costruttivismo, che enfatizza l'interazione e la costruzione attiva della conoscenza.
La premessa fondamentale del costruttivismo è che la conoscenza non è un insieme statico di fatti in attesa di essere scoperti, ma è costruita attivamente da individui e gruppi. Ciò significa che la conoscenza non è semplicemente qualcosa che abbiamo, ma qualcosa che facciamo. Ogni nuova informazione o esperienza viene integrata nella nostra base di conoscenza esistente, modificando e sviluppando la nostra comprensione del mondo. Da questa prospettiva, la realtà non è un'entità oggettiva indipendente da noi, ma è costantemente costruita e ricostruita attraverso le nostre interazioni con il mondo e con gli altri. Ciò significa che la nostra conoscenza del mondo è sempre in via di sviluppo, sempre "costruita". Il costruttivismo riconosce anche che la nostra conoscenza del mondo è sempre influenzata dal nostro contesto sociale e culturale. Le nostre convinzioni, i nostri valori, le nostre esperienze e le interazioni con gli altri giocano un ruolo importante nella costruzione della nostra conoscenza del mondo. Per questo motivo il costruttivismo è spesso associato ad approcci metodologici che si concentrano sull'esplorazione delle percezioni, delle interpretazioni e delle esperienze delle persone, come lo studio dei casi, l'etnografia o l'analisi narrativa. Questi metodi mirano a capire come gli individui e i gruppi costruiscono la loro conoscenza del mondo e come questa conoscenza influenza il loro comportamento e le loro interazioni.
Il costruttivismo sostiene che la nostra comprensione della realtà è costruita socialmente, piuttosto che osservata oggettivamente. La realtà, così come la conosciamo, è plasmata dai nostri sistemi di conoscenza, a loro volta influenzati da norme, valori e pratiche sociali. La realtà non viene percepita direttamente, ma viene interpretata attraverso queste costruzioni sociali. Pertanto, secondo il costruttivismo, per comprendere veramente la realtà, dobbiamo capire i processi attraverso i quali essa viene costruita. Ciò significa esaminare i sistemi di conoscenza - le scienze, le norme, le regole, le ideologie, eccetera - che danno forma alla nostra percezione e comprensione della realtà. - che danno forma alla nostra percezione e interpretazione del mondo. Ciò implica un'analisi di "secondo livello": non solo dobbiamo esaminare la realtà così come viene costruita, ma dobbiamo anche esaminare gli stessi processi di costruzione. Da questa prospettiva, la conoscenza non è mai neutra o oggettiva, ma è sempre influenzata dal contesto sociale e culturale in cui viene prodotta. Ciò sottolinea la natura fondamentalmente soggettiva della conoscenza e della realtà. Il costruttivismo ha importanti implicazioni per il modo in cui affrontiamo la ricerca e la pratica in molti campi, dalla sociologia alla politica, dall'educazione alla psicologia. Ci ricorda che le nostre percezioni e interpretazioni del mondo sono sempre modellate dal nostro contesto sociale e culturale e che la realtà è sempre un costrutto, mai un dato di fatto.
I teorici del costruttivismo sostengono che la realtà viene costruita nel tempo da una moltitudine di attori in una determinata società. Si tratta di un processo collettivo e complesso che coinvolge numerose interazioni e negoziazioni tra individui e gruppi. Il costruttivismo si concentra sull'analisi delle strutture sociali piuttosto che degli individui. Esamina come le idee, le norme, i valori, le credenze e le pratiche sociali plasmino la nostra comprensione della realtà. Ad esempio, nel campo della politica, i costruttivisti possono analizzare come le idee e le ideologie politiche influenzino la formazione delle politiche pubbliche. Inoltre, i costruttivisti riconoscono che le costruzioni sociali della realtà hanno un potere coercitivo. In altre parole, strutturano i nostri pensieri e comportamenti e ci costringono a conformarci ad essi. Ad esempio, le norme sociali e culturali possono farci sentire obbligati ad agire in un certo modo, anche se non siamo personalmente d'accordo con quelle norme. Tuttavia, il costruttivismo riconosce anche che le costruzioni sociali della realtà possono essere messe in discussione e modificate. Gli individui e i gruppi possono opporsi alle norme sociali, sfidare le idee dominanti e proporre nuovi modi di comprendere e interpretare il mondo. Il costruttivismo offre quindi una prospettiva dinamica e flessibile sulla realtà sociale, sottolineando sia la sua stabilità che il suo potenziale di cambiamento.
Il costruttivismo offre strumenti preziosi per analizzare e confrontare le realtà costruite in contesti diversi. Due importanti dimensioni del costruttivismo sono:
- Confronto tra realtà costruite: Il costruttivismo riconosce che società diverse possono costruire realtà diverse. Pertanto, un approccio costruttivista può comportare il confronto di queste diverse realtà costruite. Ad esempio, in che modo le norme e i valori differiscono tra le società? In che modo queste differenze influenzano il comportamento e gli atteggiamenti degli individui in queste società?
- Relazioni internazionali: il costruttivismo ha avuto un impatto significativo sul campo delle relazioni internazionali. Offre una prospettiva unica sulle questioni di potere, conflitto e cooperazione tra le nazioni. Secondo il costruttivismo, le relazioni internazionali non sono influenzate solo da fattori materiali come il potere militare o economico, ma anche da idee, norme e identità. Le realtà costruite di ciascun Paese, plasmate dai loro specifici sistemi politici, economici, culturali e sociali, possono entrare in conflitto tra loro, dando luogo a tensioni e conflitti internazionali.
Queste due dimensioni evidenziano il ruolo della costruzione sociale nel plasmare la nostra comprensione della realtà e come questa costruzione possa variare notevolmente tra le diverse società e i contesti internazionali.
Il costruttivismo incoraggia la concettualizzazione dello spazio non come entità fisica fissa, ma come prodotto delle nostre costruzioni sociali e culturali. Lo spazio, da questa prospettiva, è visto come una serie di "realtà costruite" che sono modellate e definite dagli individui e dalle società che le abitano. Ciò significa che la nostra comprensione ed esperienza dello spazio è influenzata da una moltitudine di fattori, tra cui le nostre credenze, i valori, le norme sociali, i sistemi politici ed economici e le interazioni con gli altri. Ad esempio, uno spazio urbano può essere percepito in modo diverso da gruppi diversi, a seconda del loro status socio-economico, dell'etnia, dell'età, del genere e così via. Inoltre, gli spazi stessi possono essere visti come attori influenti nella costruzione delle nostre realtà. Hanno il potenziale per plasmare il nostro comportamento, i nostri atteggiamenti e le nostre interazioni in modo significativo. Ad esempio, la pianta di una città, la presenza o l'assenza di certe infrastrutture, la disposizione delle aree residenziali e commerciali, ecc. possono influenzare il modo in cui sperimentiamo e interpretiamo i nostri ambienti. In questo modo, il costruttivismo offre una prospettiva ricca e sfumata sul modo in cui comprendiamo e interagiamo con lo spazio, sottolineando il suo ruolo nel plasmare le nostre realtà costruite.
Interazionisti e costruttivisti come alternative critiche alle teorie funzionaliste, strutturaliste e sistemiche.
Le teorie interazioniste e costruttiviste offrono alternative critiche alle teorie funzionaliste, strutturaliste e sistemiche in scienze politiche e sociologia.
L'interazionismo, con la sua attenzione alle interazioni microsociali e al modo in cui queste modellano il comportamento degli individui e il funzionamento della società, offre una critica diretta al funzionalismo. Il funzionalismo tende a vedere la società come un sistema organizzato in cui ogni parte ha una funzione specifica da svolgere per il bene dell'insieme. L'interazionismo, invece, sottolinea il ruolo degli individui e delle loro interazioni nella strutturazione della società. Il costruttivismo, invece, offre una critica agli approcci strutturalisti e sistemici. Lo strutturalismo tende a vedere la società come un insieme strutturato di relazioni che determinano il comportamento degli individui. Il costruttivismo, invece, enfatizza il ruolo degli individui e dei gruppi nella costruzione della loro realtà sociale, comprese le strutture sociali stesse. Allo stesso modo, il costruttivismo si oppone al sistemismo, che vede la società come un sistema di elementi interconnessi che interagiscono tra loro. Il costruttivismo, invece, si concentra maggiormente sull'analisi di casi specifici e sul modo in cui le realtà sociali vengono costruite e cambiano nel tempo.
Questi due approcci - l'interazionismo e il costruttivismo - offrono quindi una visione più dinamica e flessibile della società, sottolineando il ruolo attivo svolto dagli individui nel plasmare la loro realtà sociale.
La teoria interazionista
Le origini: la Scuola di Chicago
All'inizio del XX secolo a Chicago si verificarono importanti cambiamenti socio-demografici ed economici. La città si trasformò rapidamente in una metropoli, soprattutto grazie alla rapida industrializzazione e all'immigrazione di massa dall'Europa e dalle zone rurali del sud degli Stati Uniti. L'arrivo in massa di questi nuovi residenti, in cerca di lavoro nell'industria in piena espansione, ha portato a una rapida espansione della città. Tuttavia, ha anche esacerbato le tensioni razziali ed etniche, creato condizioni di vita precarie e portato a un aumento della criminalità. I nuovi immigrati si stabilirono spesso in quartieri etnicamente omogenei, talvolta chiamati "ghetti", dove le condizioni di vita erano spesso difficili. La segregazione razziale ed etnica ha spesso portato a tensioni, che a volte sono degenerate in violenza e rivolte razziali. Allo stesso tempo, la mancanza di opportunità economiche e di istruzione per molti giovani ha contribuito all'aumento della delinquenza giovanile. Allo stesso modo, la povertà e la disperazione hanno portato alcune persone a ricorrere alla prostituzione come mezzo di sussistenza. Tutti questi fattori crearono un clima sociale teso e posero molte sfide alle autorità cittadine e ai sociologi dell'epoca, che cercarono di capire e risolvere questi problemi. È in questo contesto che si sviluppò la Scuola di sociologia di Chicago, che adottò un approccio interazionista allo studio di questi fenomeni sociali.
All'inizio del XX secolo, la Scuola di Chicago rivoluzionò il campo della sociologia spostando l'attenzione dai fattori strutturali e dalle risposte repressive ai comportamenti devianti a un'analisi più sfumata delle interazioni sociali e delle dinamiche della marginalità. Concentrandosi sulle comunità emarginate e sradicate della crescente metropoli di Chicago, i sociologi della Scuola di Chicago hanno cercato di comprendere le motivazioni, le razionalità e le interazioni sociali alla base dei comportamenti devianti. Essi adottarono un approccio empirico, basato sull'osservazione diretta e sulla ricerca sul campo, che all'epoca rappresentava una novità nel campo della sociologia. Questi ricercatori hanno evidenziato il ruolo delle interazioni sociali nella creazione di comportamenti devianti, dimostrando che tali comportamenti non sono semplicemente il risultato di fattori individuali, ma sono anche modellati dalle condizioni sociali e dalle interazioni all'interno della comunità. Ciò ha aperto la strada a una comprensione più profonda e sfumata della devianza sociale e ha gettato le basi dell'approccio interazionista in sociologia.
Basandosi sull'approccio interazionista, la Scuola di sociologia di Chicago ha evidenziato alcuni temi principali nella sua ricerca:
- Lo studio dei gruppi minoritari ha permesso di comprendere i processi di assimilazione, discriminazione e segregazione, nonché l'impatto di questi processi sulla struttura sociale e sulle dinamiche intergruppi.
- L'uomo marginale: questo concetto, introdotto da Robert E. Park, descrive gli individui che vivono al confine tra due culture o gruppi sociali e che hanno difficoltà a integrarsi pienamente nell'una o nell'altra. Questa marginalità può portare a sentimenti di alienazione, confusione e conflitto.
- La città: la trasformazione di Chicago in una metropoli in rapida evoluzione è stata un campo di studio privilegiato per comprendere i processi sociali, economici e politici che hanno luogo nelle aree urbane.
- Devianza: i sociologi della Scuola di Chicago sono stati tra i primi a studiare la devianza non come un atto isolato, ma come un processo sociale, influenzato dalle interazioni e dalle dinamiche comunitarie.
- Crimine e delinquenza: concentrandosi sui quartieri ad alta criminalità di Chicago, questi ricercatori hanno cercato di comprendere le cause di fondo del crimine e della delinquenza, ponendo l'accento sui fattori sociali e ambientali piuttosto che sulle disposizioni individuali.
Questi temi hanno contribuito notevolmente alla comprensione delle dinamiche sociali negli ambienti urbani e hanno influenzato molte ricerche successive in sociologia e scienze politiche.
Il lavoro della Scuola di sociologia di Chicago sulle minoranze ha rivelato che questi gruppi spesso sviluppano solidi sistemi di interazione in risposta alle sfide dell'ambiente sociale. Questi sistemi, che comprendono norme, valori e pratiche condivise, fungono da meccanismi di difesa e protezione contro le forze esterne, tra cui la discriminazione e l'esclusione. Ad esempio, in contesti di immigrazione o emarginazione, i membri delle minoranze possono unirsi e creare comunità di sostegno per far fronte alle avversità. Queste comunità possono essere organizzate intorno ad alcune caratteristiche comuni, come la razza, l'etnia, la lingua, la religione o la classe sociale. Oltre a fornire sostegno sociale ed emotivo, questi sistemi di interazione possono anche facilitare l'adattamento e l'integrazione degli individui nella società in generale. Possono aiutare i membri della comunità a superare le sfide della vita quotidiana, ad accedere a risorse preziose e a mantenere la propria identità culturale. Ad esempio, il lavoro della Scuola di sociologia di Chicago ha dimostrato che i sistemi di interazione all'interno delle minoranze non sono solo manifestazioni di solidarietà e resilienza, ma anche elementi essenziali per comprendere le dinamiche delle relazioni sociali e politiche nei contesti urbani.
Le parole chiave dell'interazionismo includono :
- Socializzazione: Questo processo si riferisce al modo in cui gli individui apprendono e interiorizzano le norme, i valori e i comportamenti della loro società. Ciò avviene nel corso della vita e modella il modo in cui le persone interagiscono con gli altri e comprendono il loro posto nella società.
- Interazionismo simbolico: Questa prospettiva sottolinea la creazione di significati sociali attraverso le interazioni. Gli individui non sono semplicemente passivi di fronte alla società, ma svolgono un ruolo attivo nella creazione della loro realtà sociale attraverso l'interpretazione di simboli e segni.
- Osservazione partecipante: Questo metodo di ricerca prevede che il ricercatore si impegni attivamente con la comunità o il gruppo che sta studiando. Ciò consente al ricercatore di comprendere le esperienze e le prospettive dei partecipanti dall'interno.
- Darwinismo sociale: Questa teoria applica i principi della selezione naturale di Darwin alla società, suggerendo che gli individui o i gruppi più capaci di adattarsi hanno successo mentre gli altri falliscono.
- Funzionalismo: Questa teoria vede la società come un sistema complesso in cui tutte le parti lavorano insieme per garantire stabilità e armonia. Ogni parte ha una funzione specifica che contribuisce al funzionamento complessivo della società.
- Etnometodologia: Questo approccio si concentra sui metodi che le persone utilizzano nella loro vita quotidiana per comprendere e navigare nel loro mondo sociale.
- Ecologia urbana: Questa prospettiva esamina come le caratteristiche spaziali e fisiche di una città influenzino le interazioni sociali e i comportamenti degli individui.
- Disorganizzazione: Questo concetto si riferisce alla rottura o alla degradazione dell'ordine sociale, spesso causata da rapidi cambiamenti o conflitti. Questo può portare a una riduzione dell'influenza delle norme e dei valori collettivi sugli individui.
Erwin Goffman (1922-1982): mettere in scena la vita quotidiana
Erving Goffman è stato un famoso sociologo che ha dato un contributo significativo alla sociologia dell'interazione. Nato nel 1922 e morto nel 1982, è noto soprattutto per il suo lavoro sulla "messa in scena della vita quotidiana" e sulla teoria del "dramma sociale". In "La messa in scena della vita quotidiana", Goffman utilizza la metafora del teatro per descrivere come gli individui si presentano a se stessi e agli altri nella vita quotidiana. Parla di "faccia" (l'immagine di sé che si presenta agli altri), di "ruoli" (i comportamenti attesi in base alle aspettative sociali) e di "palcoscenico" (il contesto in cui avviene l'interazione). Secondo Goffman, gli individui "giocano" costantemente dei ruoli e adattano il loro comportamento in base alla situazione e alle aspettative degli altri. Egli suggerisce che siamo tutti attori sul "palcoscenico" della vita quotidiana, che recitano ruoli diversi e manipolano le nostre "performance" per gestire le impressioni che suscitiamo negli altri. Nel contesto del suo lavoro sugli ospedali psichiatrici, Goffman ha studiato come gli individui si muovono all'interno di queste istituzioni e come le interazioni e i comportamenti sono modellati dal contesto istituzionale. Il suo lavoro ha rivelato come le istituzioni possano esercitare un controllo sociale sugli individui e come questi ultimi resistano o si adattino a tali vincoli. Questo lavoro ha dato un contributo significativo alla comprensione di come si strutturano le interazioni sociali e di come gli individui gestiscono la propria identità e le proprie prestazioni sociali.
Anche Erving Goffman, sebbene spesso associato all'interazionismo simbolico, ha contribuito alla teoria costruttivista. Il costruttivismo si concentra sul modo in cui gli individui e i gruppi sociali costruiscono e interpretano la realtà attraverso le loro interazioni e rappresentazioni.
Goffman sostiene che la realtà è plasmata dalle rappresentazioni che ne facciamo e da quelle che condividiamo con gli altri. A suo avviso, esistono due aspetti della realtà:
- Rappresentazioni della realtà: formiamo immagini, idee e credenze sulla realtà in base alle nostre esperienze personali e alle interazioni con gli altri. Queste rappresentazioni influenzano la nostra comprensione del mondo e guidano il nostro comportamento.
- La realtà delle rappresentazioni: Quando le rappresentazioni della realtà sono condivise e accettate da un gruppo o da una società, acquistano forza reale e agiscono sugli individui e sulle interazioni sociali. In altre parole, le rappresentazioni collettive diventano una realtà sociale in sé.
Per Goffman, quindi, gli individui partecipano attivamente alla costruzione della loro realtà sociale attraverso le loro rappresentazioni e le loro interazioni. Gli individui non sono semplici ricettori passivi della realtà, ma attori attivi che plasmano e sono plasmati dalle loro rappresentazioni e dalle loro esperienze sociali. Questo approccio enfatizza la natura dinamica e mutevole della realtà sociale e sottolinea l'importanza dei processi di interpretazione e negoziazione nella costruzione della realtà.
La nozione di "drammaturgia sociale" è centrale nel lavoro di Erving Goffman. Secondo lui, la vita sociale si svolge come un'opera teatrale, con attori (gli individui), un palcoscenico (l'ambiente sociale) e un pubblico (le altre persone presenti). Ogni individuo interpreta ruoli diversi, a seconda della situazione in cui si trova e delle aspettative sociali associate a tale situazione. Da questa prospettiva, lo spazio pubblico è visto come un "palcoscenico" dove gli individui mettono in scena i loro ruoli sociali. Goffman distingue tra il "palcoscenico anteriore", dove gli individui si conformano alle norme sociali e recitano un ruolo destinato a essere visto dagli altri, e il "palcoscenico posteriore", dove gli individui possono rilassarsi, essere se stessi e prepararsi per le loro performance sul palcoscenico anteriore. Per Goffman, la "presentazione di sé" è una componente essenziale dell'interazione sociale. Gli individui cercano di controllare l'impressione che danno agli altri manipolando il loro aspetto, il linguaggio del corpo e il comportamento. Ad esempio, una persona può vestirsi in un certo modo o comportarsi in un certo modo per dare un'impressione specifica, come apparire competente o affidabile. Per Goffman, quindi, lo spazio pubblico è un luogo in cui gli individui svolgono i loro ruoli sociali, cercano di controllare l'impressione che fanno agli altri e negoziano costantemente la loro identità e le relazioni con gli altri attraverso le loro interazioni...
Nella sua analisi della vita sociale, Erving Goffman sottolinea le forme di impegno che gli individui assumono nelle loro interazioni. Le tre abilità - cooperazione, impegno e assorbimento - sono essenziali per il modo in cui gli individui si comportano e interagiscono in diverse situazioni sociali. Sono particolarmente rilevanti nell'analisi di Goffman della "drammaturgia sociale", in cui le interazioni sociali sono viste come spettacoli teatrali.
- Cooperazione: Goffman sottolinea che le interazioni sociali richiedono una forma di cooperazione tra gli individui. Ciò comporta il rispetto reciproco delle norme sociali e delle aspettative comportamentali. La cooperazione è essenziale per mantenere l'ordine sociale e facilitare le interazioni sociali. Ad esempio, in una conversazione, gli individui devono cooperare prendendo il proprio turno di parola e ascoltando quando è il turno dell'altro.
- Impegno: secondo Goffman, l'impegno si riferisce alla misura in cui un individuo è coinvolto o impegnato in un'interazione sociale. L'impegno può variare a seconda della situazione e del ruolo che l'individuo svolge. Ad esempio, una persona può essere molto impegnata in una conversazione seria con un amico, ma meno in una conversazione informale con uno sconosciuto.
- Assorbimento: Goffman usa il termine "assorbimento" per riferirsi a situazioni in cui un individuo è completamente impegnato in un'attività al punto da esserne "assorbito". In queste situazioni, l'individuo può essere talmente concentrato sull'attività in corso da essere meno consapevole dell'ambiente sociale e meno sensibile alle interazioni sociali.
Queste tre abilità sono fondamentali per il modo in cui gli individui navigano nel mondo sociale e sono componenti chiave della teoria del dramma sociale di Goffman.
La prospettiva di Erving Goffman sulla società come teatro implica che siamo tutti attori e spettatori nello spazio pubblico. Questa prospettiva è spesso chiamata "drammaturgia sociale" e suggerisce che la vita sociale è una serie di spettacoli. In queste rappresentazioni, gli individui giocano un certo ruolo e, allo stesso tempo, sono anche spettatori delle rappresentazioni degli altri. Quando interagiamo con gli altri, "recitiamo un ruolo" in base a ciò che crediamo gli altri si aspettino da noi. Queste aspettative possono essere basate su norme sociali, ruoli sociali, stereotipi e così via. E mentre recitiamo il nostro ruolo, osserviamo e interpretiamo anche le performance degli altri. In altre parole, siamo sia attori che danno forma all'interazione sociale sia spettatori che la interpretano. Queste interazioni sono fortemente influenzate dalla cultura, che fornisce il "copione" o le linee guida generali per le nostre rappresentazioni. Ad esempio, la cultura definisce norme e valori appropriati, ruoli di genere, comportamenti accettabili e così via. Quindi, attraverso le nostre interazioni nello spazio pubblico, partecipiamo sia alla creazione della realtà sociale (come attori) sia alla sua interpretazione (come spettatori). Questi processi sono entrambi modellati dal contesto culturale in cui si svolgono.
Secondo Erving Goffman, il linguaggio e il corpo sono due elementi cruciali nell'interazione sociale. Sono gli strumenti principali che utilizziamo per "recitare" la nostra parte nella performance sociale.
- Discorso: Goffman sottolinea l'importanza della comunicazione verbale nell'interazione sociale. Il modo in cui parliamo, le parole che scegliamo, il tono che usiamo, ecc. sono tutti elementi della nostra performance. Contribuiscono a esprimere la nostra identità, a indicare il nostro status sociale, a dimostrare l'appartenenza a un certo gruppo e così via. Il linguaggio è anche un modo importante per interpretare le prestazioni degli altri. Ascoltando gli altri, raccogliamo informazioni sul loro ruolo, status, identità, ecc.
- Il corpo: Goffman sottolinea anche l'importanza della comunicazione non verbale nell'interazione sociale. I movimenti del corpo, le espressioni facciali, il contatto visivo, ecc. sono elementi chiave della nostra performance. Possono trasmettere una serie di informazioni, come le nostre emozioni, i nostri atteggiamenti, il nostro comfort o disagio in una situazione e così via. Inoltre, anche il nostro aspetto fisico (abbigliamento, acconciatura, ecc.) può giocare un ruolo nel modo in cui siamo percepiti dagli altri.
Nell'interazione sociale, quindi, usiamo sia la parola che il corpo per "recitare" il nostro ruolo e per interpretare quello degli altri. Questi processi ci permettono di "negoziare" il nostro posto nella società e di capire quello degli altri.
== Interazionismo simbolico
Erving Goffman ha studiato varie forme di comportamento sociale, tra cui le strategie di evitamento. Gli individui possono usare queste strategie per mantenere la loro "faccia" (un'immagine di sé presentata agli altri) o per navigare in situazioni sociali potenzialmente scomode o imbarazzanti.
Secondo Goffman, alcune di queste strategie di evitamento possono includere:
- Evitamento fisico: può includere cose come cambiare strada per evitare di urtare qualcuno o lasciare una stanza quando entrano certe persone.
- Evitamento della comunicazione: non rispondere a un messaggio, ignorare qualcuno durante una conversazione o evitare di parlare di certi argomenti possono essere forme di evitamento della comunicazione.
- Evitamento dello sguardo: a volte gli individui possono evitare il contatto visivo diretto con qualcuno per evitare un'interazione.
- Evitamento della distrazione: le persone possono fingere di essere occupate o distratte per evitare l'interazione.
Queste strategie sono tutte utilizzate per gestire il modo in cui veniamo percepiti dagli altri, il che è al centro del quadro dell'interazionismo simbolico di Goffman. Tuttavia, è importante notare che questi comportamenti possono anche avere conseguenze negative, come ostacolare la comunicazione o creare malintesi.
L'interazionismo simbolico offre una prospettiva interessante per la comprensione della politica. In politica, le interazioni tra individui, gruppi, partiti politici, istituzioni e persino nazioni giocano un ruolo cruciale nel modo in cui vengono prese le decisioni e attuate le politiche.
Ecco alcuni dei punti chiave dell'interazionismo in politica:
- Negoziazione e dibattito: la politica è spesso una negoziazione e un dibattito tra diverse parti con interessi diversi. L'interazionismo ci aiuta a capire come avvengono questi processi e come gli individui e i gruppi usano simboli e significati condivisi per influenzare queste negoziazioni.
- Costruzione dell'identità: la politica è anche un processo di costruzione e contestazione delle identità. Ad esempio, l'identità politica di un individuo può essere plasmata dalle interazioni con gli altri nel suo ambiente sociale e politico.
- Influenza e potere: L'interazionismo può aiutare a capire come il potere viene esercitato e negoziato nelle interazioni politiche. Ad esempio, come gli individui o i gruppi usano il linguaggio, i simboli e i rituali per influenzare gli altri e acquisire potere.
- Cambiamento sociale: l'interazionismo offre una prospettiva su come il cambiamento sociale possa avvenire attraverso le interazioni quotidiane. Ad esempio, il modo in cui i movimenti sociali utilizzano le interazioni per mobilitare il sostegno, diffondere idee e produrre cambiamenti nelle norme sociali e politiche.
L'interazionismo simbolico ci ricorda quindi che la politica non riguarda solo le strutture istituzionali e i processi formali, ma anche le interazioni sociali, i significati condivisi e le negoziazioni quotidiane.
Erving Goffman ha identificato diverse situazioni che possono interrompere l'interazione sociale rituale. Ecco una spiegazione più dettagliata di queste tre situazioni:
- Offesa e riparazione: in questa situazione, una persona può commettere un'offesa, o una violazione delle norme di interazione, che può causare un sentimento di vergogna o di disagio nella persona offesa. Tuttavia, di solito esiste una possibilità di riparazione, in cui la persona che ha commesso l'offesa può scusarsi o fare ammenda per ripristinare l'ordine sociale.
- Dissacrazione: in questo caso, una persona rifiuta deliberatamente di seguire le norme di interazione. Ciò può accadere quando una persona mette apertamente in discussione o critica le norme sociali stabilite. Questa violazione intenzionale delle norme può causare gravi disagi alle interazioni sociali.
- Anormalità: in questo caso, una persona non è in grado di seguire le norme di interazione a causa di alcune condizioni o circostanze al di fuori del suo controllo. Ciò può accadere, ad esempio, se una persona soffre di una malattia mentale o di una disabilità fisica che le impedisce di partecipare alle interazioni sociali nel modo consueto.
Tutte queste situazioni possono sconvolgere l'ordine sociale e causare imbarazzo o disagio agli altri partecipanti all'interazione. Tuttavia, Goffman sostiene che queste interruzioni possono anche essere un'opportunità per esaminare e sfidare le norme sociali stabilite.
La teoria costruttivista
Le origini: l'epistemologia di Alfred Schütz (1899 - 1959)
Alfred Schütz è stato un sociologo e filosofo austriaco che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della fenomenologia sociale, un approccio che cerca di capire come gli individui danno senso al loro mondo sociale. Schütz ritiene che la nostra comprensione del mondo sia strutturata dalla nostra esperienza diretta. In altre parole, costruiamo la nostra realtà sulla base della nostra prospettiva e delle nostre esperienze personali. Egli sostiene che gli individui interagiscono con il mondo sulla base delle loro interpretazioni e comprensioni soggettive. Per Schütz, la realtà è un fenomeno socialmente costruito. Ogni individuo ha una concezione unica e soggettiva della realtà, basata sulle sue esperienze personali, sulle interazioni con gli altri e sulle interpretazioni di queste esperienze e interazioni. Questa prospettiva viene spesso definita "costruzionismo sociale". Seguendo Schütz, anche Goffman ha esplorato il modo in cui gli individui costruiscono e interpretano la loro realtà sociale, concentrandosi in particolare sul modo in cui gli individui presentano e gestiscono se stessi in diverse situazioni sociali. Da questa prospettiva, un "oggetto di pensiero" può essere inteso come qualcosa che viene costruito dagli individui attraverso la loro interazione e interpretazione del mondo. Ad esempio, le norme sociali, i ruoli di genere e le identità culturali possono essere visti come "oggetti di pensiero" socialmente costruiti.
Nelle scienze sociali, e più in generale nella ricerca, la costruzione dell'oggetto di studio è una fase cruciale che richiede una concettualizzazione e un'operazionalizzazione rigorose. Ciò significa che il ricercatore deve definire con precisione cosa sta cercando di studiare (concettualizzazione) e determinare come misurare o osservare il fenomeno (operazionalizzazione). La costruzione dell'oggetto di studio implica generalmente l'assunzione di un concetto o di un'idea generale e la sua trasformazione in qualcosa di specifico, misurabile e osservabile. Ad esempio, un ricercatore interessato a studiare la "qualità della vita" dovrà definire con precisione cosa intende con questo concetto (ad esempio, includendo fattori come la salute, il benessere economico, le relazioni sociali, ecc. È inoltre importante notare che la costruzione dell'oggetto di studio è spesso influenzata dal quadro teorico del ricercatore, ossia dall'insieme di teorie e concetti che utilizza per comprendere il proprio argomento. Ricercatori diversi possono quindi costruire e interpretare l'oggetto di studio in modi diversi, a seconda della loro prospettiva teorica. Infine, è essenziale comprendere che la costruzione dell'oggetto di studio è una fase fondamentale della ricerca scientifica, che contribuisce a garantire la validità e l'affidabilità della ricerca. Senza una definizione chiara e precisa dell'oggetto di studio, sarebbe molto difficile, se non impossibile, condurre una ricerca rigorosa e produrre risultati affidabili.
Alfred Schütz ha proposto un approccio fenomenologico alla sociologia, ovvero era interessato al modo in cui gli individui percepiscono e interpretano il mondo che li circonda. A suo avviso, la nostra comprensione del mondo è sempre un costrutto di secondo grado, basato sulle nostre interpretazioni personali e soggettive della realtà. Secondo Schütz, il compito del sociologo è quello di comprendere queste costruzioni soggettive della realtà, e non di cercare di scoprire una "realtà oggettiva". Per fare ciò, è necessario sviluppare strumenti e metodi di ricerca che consentano di esplorare e comprendere le percezioni e le interpretazioni degli individui. Ciò significa che, anziché limitarsi a osservare il comportamento degli individui, il ricercatore deve sforzarsi di comprendere il significato che gli individui danno al loro comportamento e alla loro esperienza. Ciò può comportare l'utilizzo di metodi di ricerca qualitativi, come le interviste in profondità o l'osservazione dei partecipanti, che consentono di raccogliere dati dettagliati sulle esperienze e sulle percezioni delle persone. In questo senso, l'approccio di Schütz può essere visto come una critica agli approcci più tradizionali della sociologia, che cercano di spiegare il comportamento sociale in termini di leggi o strutture oggettive. Al contrario, Schütz sostiene che il comportamento sociale può essere compreso solo tenendo conto della prospettiva degli stessi attori sociali.
L'approccio costruttivista, rappresentato da pensatori come Schütz e Goffman, sottolinea l'importanza di comprendere le realtà sociali così come sono percepite e costruite dagli individui stessi. Questa prospettiva sottolinea il ruolo attivo svolto dagli individui nel creare e trasformare il loro mondo sociale. In questo contesto, la ricerca sociologica non si limita a osservare e descrivere la realtà sociale. Si tratta anche di capire come questa realtà viene costruita, come viene vissuta e come viene interpretata dagli individui. Questo approccio richiede una riflessione epistemologica sui metodi di ricerca utilizzati e sulle ipotesi su cui si basano. Inoltre, è necessario riconoscere che anche la nostra comprensione come ricercatori è un costrutto, plasmato dalle nostre esperienze, dalle nostre prospettive e dal nostro contesto culturale e storico. L'obiettivo non è quindi quello di arrivare a una "verità" oggettiva o universale, ma piuttosto di comprendere le molteplici realtà che vengono costruite e vissute dagli individui in diversi contesti sociali.
La filosofia del linguaggio di John Searle
John Searle è un noto filosofo americano che ha lavorato a lungo sulla filosofia del linguaggio e della mente. In "La costruzione della realtà sociale" (1995), Searle esplora il modo in cui le nostre concezioni della realtà sono modellate dalle nostre credenze e pratiche sociali. Searle distingue tra fatti bruti, che esistono indipendentemente dall'intervento umano (ad esempio, la gravità), e fatti istituzionali, che esistono solo grazie alle nostre credenze in essi (ad esempio, l'idea del denaro come mezzo di scambio). Searle sostiene che molte delle nostre realtà sociali - come i governi, i matrimoni, il denaro e la proprietà - sono costruite attraverso processi linguistici. Ad esempio, quando diciamo "Questo è denaro", contribuiamo a creare la realtà sociale che la carta o il metallo che abbiamo in mano ha un certo valore. Allo stesso modo, quando diciamo "Siamo sposati", creiamo una nuova realtà sociale con diritti, obblighi e aspettative specifiche. La prospettiva di Searle sul costruttivismo è quindi strettamente legata al modo in cui il linguaggio aiuta a costruire la nostra realtà sociale.
Per John Searle il linguaggio è fondamentale per la costruzione della realtà sociale. A suo avviso, il linguaggio non è solo un mezzo per comunicare informazioni, ma anche uno strumento per creare e modificare la nostra realtà sociale. Nel suo lavoro si concentra su quelli che chiama "atti di parola", ossia i diversi modi in cui usiamo il linguaggio per compiere azioni nel mondo sociale. Ad esempio, quando facciamo una promessa, usiamo il linguaggio per creare un obbligo sociale. Quando diamo un nome a qualcosa, usiamo il linguaggio per dare un'identità a un oggetto o a una persona. Quando formuliamo leggi o regole, usiamo il linguaggio per stabilire norme di comportamento. La visione di Searle del linguaggio è quindi molto vicina a quella di Piaget, che vedeva nel linguaggio un costrutto essenziale per la nostra comprensione e interazione con il mondo.
John Searle è stato un importante contributo alla filosofia del linguaggio, una sottodisciplina della filosofia che si occupa dei concetti legati al linguaggio e al suo uso. A suo avviso, il linguaggio svolge un ruolo cruciale nella costruzione della nostra realtà sociale. Egli sostiene che quando usiamo il linguaggio, compiamo quelli che chiama "atti di parola". Un atto di parola non è solo l'atto di dire qualcosa, ma anche l'atto di fare qualcosa con quelle parole. Ad esempio, dicendo "prometto di lavare i piatti", non comunichiamo solo informazioni, ma ci impegniamo anche a compiere un'azione (fare una promessa). Secondo Searle, questi atti di parola hanno il potere di creare realtà sociali. Ad esempio, quando il sindaco di una città dice "Dichiaro aperta questa fiera", non sta solo descrivendo una situazione, ma sta anche creando una nuova realtà: la fiera è ora ufficialmente aperta. È attraverso questo processo che il linguaggio contribuisce alla costruzione della nostra realtà sociale. In altre parole, Searle vede il linguaggio non solo come un mezzo per descrivere il mondo, ma anche come un mezzo per cambiarlo. Per questo afferma che "il discorso è una forma di azione".
Lo studio dell'etimologia, ovvero l'origine e la storia delle parole, può fornire molte informazioni preziose su come usiamo il linguaggio per concepire e costruire la nostra realtà. Ogni parola ha una storia e questa storia è spesso legata al modo in cui comprendiamo il mondo. Ad esempio, la parola "capire" deriva dal latino "comprehendere", che significa "afferrare insieme". Questo suggerisce che per capire qualcosa, dobbiamo essere in grado di coglierne tutti gli aspetti contemporaneamente, per metterli insieme in un insieme coerente. Quindi, studiando l'etimologia delle parole, possiamo capire meglio come usiamo il linguaggio per dare un senso al mondo che ci circonda. Questo può aiutarci a pensare in modo più critico al modo in cui usiamo il linguaggio, a individuare gli assunti nascosti nei nostri discorsi e a sviluppare nuovi modi di pensare e parlare del mondo. Tuttavia, è anche importante notare che l'etimologia non è sempre una guida affidabile al significato attuale di una parola. I significati delle parole cambiano nel tempo e a volte il significato originale di una parola può essere molto diverso dal suo uso attuale. Pertanto, sebbene l'etimologia possa offrire spunti interessanti, deve essere usata con cautela come strumento di analisi linguistica.
Il linguaggio svolge un ruolo essenziale nel modo in cui concepiamo e costruiamo la nostra realtà sociale. Non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche un mezzo con cui diamo senso al mondo che ci circonda. Ecco alcuni dei modi in cui il linguaggio contribuisce alla costruzione della realtà sociale:
- Categorizzazione e concettualizzazione: il linguaggio ci aiuta a suddividere il mondo in categorie e concetti comprensibili. Ad esempio, le parole che usiamo per descrivere i colori, le emozioni o le relazioni sociali ci aiutano a strutturare la nostra esperienza del mondo.
- Creare e trasmettere la cultura: la lingua è il principale veicolo della cultura. Ci permette di condividere idee, credenze e valori e di trasmettere la nostra cultura di generazione in generazione.
- Negoziazione e creazione di significati: Attraverso il linguaggio possiamo discutere, dibattere e negoziare il significato di eventi, idee ed esperienze. Ciò è particolarmente importante in situazioni di cambiamento sociale o di conflitto.
- Creare e mantenere relazioni sociali: il linguaggio ci permette di creare e mantenere relazioni sociali. Ad esempio, usiamo il linguaggio per esprimere affetto, rispetto o ostilità verso gli altri.
- Definizione e costruzione dell'identità: il linguaggio svolge un ruolo importante nel definire la nostra identità e il nostro posto nella società. Per esempio, il modo in cui parliamo e le parole che usiamo possono riflettere la nostra origine etnica, la nostra classe sociale, il nostro genere, ecc.
Il linguaggio è uno strumento potente che modella la nostra comprensione del mondo e la nostra interazione con esso. Contribuisce alla costruzione della nostra realtà sociale in modi complessi e sfaccettati.
Peter Berger et Thomas Luckman : « la construction sociale de la réalité »
Peter L. Berger et Thomas Luckmann, dans leur livre influent "The Social Construction of Reality" (1966), ont développé une théorie de la connaissance en sociologie qui explique comment les réalités sociales sont créées, institutionnalisées et rendues significatives pour les individus au sein d'une société. Pour eux, la réalité est un phénomène à la fois objectif et subjectif, construit à travers les interactions humaines et le langage.
- Construction sociale de la réalité : Pour Berger et Luckmann, la réalité n'est pas une entité externe fixe et immuable, mais plutôt un phénomène en constante évolution qui est construit et remodelé par les interactions humaines. Les individus, par leurs actions et leurs interactions, créent une réalité sociale qui, bien que subjective, est perçue comme objective et "réelle".
- Rôle du langage : Le langage est essentiel à ce processus de construction sociale de la réalité. Il fournit le cadre dans lequel les individus interprètent, décrivent et donnent un sens à leur expérience du monde. Par l'échange de symboles et de significations par le langage, les individus construisent conjointement une réalité partagée.
- Institutionnalisation et rôles sociaux : Les patterns répétés d'interaction deviennent institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils se transforment en structures sociales stables et prévisibles, comme la famille, l'éducation, le gouvernement, etc. Ces institutions, à leur tour, influencent le comportement des individus en leur assignant des rôles spécifiques.
- Réalité subjective et objective : Bien que la réalité soit construite socialement, elle est vécue par les individus comme une réalité objective indépendante de leur volonté. C'est ce que Berger et Luckmann appellent la "réification" - le processus par lequel la réalité socialement construite est perçue comme une réalité objective et inaltérable.
La perspective de Berger et Luckmann met en évidence le rôle central des interactions sociales et du langage dans la construction de notre réalité perçue. Les sciences sociales, à leur avis, devraient donc se concentrer sur la compréhension de ces processus de construction sociale de la réalité.
Peter L. Berger et Thomas Luckmann, dans leur livre "The Social Construction of Reality", expliquent que la réalité est constamment créée et modifiée par les interactions sociales. Ils soulignent trois concepts clés dans ce processus :
- Le langage comme fondement de la connaissance de la vie quotidienne : Le langage n'est pas seulement un outil de communication, mais également un moyen par lequel les individus donnent du sens à leur monde. C'est par le langage que nous nommons, catégorisons et interprétons notre expérience du monde. Ainsi, le langage joue un rôle crucial dans la construction de notre réalité sociale.
- La société comme réalité objective : Bien que la société soit socialement construite, elle est perçue par les individus comme une réalité objective et indépendante de leur volonté. Les institutions sociales, les normes et les règles sont considérées comme des entités existantes en dehors de l'individu et exercent une influence et un contrôle sur son comportement. Cette objectivation de la réalité sociale contribue à la stabilité et à la continuité de la société.
- La société comme réalité subjective : Berger et Luckmann soutiennent également que la réalité sociale est une réalité subjective. En d'autres termes, les individus donnent du sens à leur monde à travers leurs propres perspectives et expériences. Cela implique l'identification à l'autre, où nous apprenons à voir le monde à travers les yeux des autres. C'est ce processus d'internalisation qui nous permet de comprendre et de nous conformer aux attentes et aux normes sociales.
Berger et Luckmann démontrent que la réalité est un construit social, façonné par le langage et les interactions sociales, et perçu comme une entité objective qui exerce une influence sur l'individu. En même temps, la réalité est une expérience subjective, influencée par notre identification et notre empathie envers les autres.
Du point de vue de la science politique, le pouvoir est un élément central de la construction sociale de la réalité. Le pouvoir est l'aptitude à influencer les comportements d'autres individus ou groupes d'individus, en établissant des règles, des normes et des structures qui façonnent et dirigent les comportements sociaux.
Le pouvoir peut se manifester de diverses manières dans une société :
- Pouvoir institutionnel : Il s'agit de l'autorité et du contrôle exercés par les institutions sociales, telles que le gouvernement, les organisations juridiques, les établissements d'enseignement, les organisations religieuses, etc. Ces institutions établissent des normes et des règles qui orientent le comportement des individus.
- Pouvoir social : Il s'agit de l'influence exercée par les groupes sociaux sur les individus. Cela peut inclure la pression des pairs, l'influence des médias, le poids des traditions culturelles, etc.
- Pouvoir individuel : C'est la capacité d'une personne à influencer les autres, que ce soit par le charisme, le savoir, l'expertise, la richesse, le statut social, etc.
Ainsi, la réalité sociale est en partie une construction du pouvoir. Les individus sont soumis aux règles et normes établies par ceux qui détiennent le pouvoir, et participent également à cette construction en acceptant, en négociant ou en résistant à ces règles et normes. En comprenant comment le pouvoir façonne la réalité sociale, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques de la société et comment les changements sociaux peuvent survenir. La capacité de faire adhérer les individus à une réalité sociale construite est une dimension essentielle du pouvoir. Les institutions sociales exercent un contrôle sur les individus en établissant et en faisant respecter les normes et les règles qui définissent la réalité sociale. Si un individu remet en question ou viole ces normes et règles, il peut être soumis à diverses formes de sanctions, allant de la désapprobation sociale à des sanctions légales plus sévères. Dans des cas extrêmes, comme celui de Galilée, ceux qui défient l'ordre établi peuvent même être menacés de mort ou d'autres formes de violence extrême. Le cas de Galilée est un exemple de la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour imposer une certaine conception de la réalité. Galilée a été condamné par l'Église catholique pour avoir soutenu l'héliocentrisme, une théorie qui contredisait la conception géocentrique du monde acceptée à l'époque. Cependant, il est important de noter que la réalité sociale construite n'est pas immuable et peut être modifiée ou remise en question au fil du temps. Par exemple, malgré la condamnation de Galilée, sa théorie de l'héliocentrisme a finalement été acceptée comme la vérité scientifique. Cela illustre également que le pouvoir n'est pas toujours absolument déterminant : il peut être remis en question et transformé, et les réalités sociales peuvent évoluer à travers ce processus de contestation et de changement.
Selon Berger et Luckmann, la réalité sociale est construite au quotidien à travers des processus d'institutionnalisation et de légitimation.
L'institutionnalisation est le processus par lequel certaines actions et comportements deviennent répétés et prévisibles, formant ainsi des modèles qui façonnent la réalité sociale. Ces modèles de comportement institutionnalisés sont intériorisés par les individus et deviennent des habitudes qui structurent leurs actions quotidiennes. Par exemple, le fait de se lever tôt pour aller travailler, de respecter les règles de circulation routière, ou encore de se conformer aux normes de politesse dans les interactions sociales sont des exemples de comportements institutionnalisés.
Le processus de légitimation, d'autre part, est le mécanisme par lequel ces comportements institutionnalisés sont validés et soutenus par la société. Ils sont justifiés et soutenus par des croyances partagées, des valeurs, des normes et des règles. Par exemple, le respect des lois est légitimé par la croyance que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la stabilité dans la société.
Ces deux processus fonctionnent ensemble pour créer et maintenir la réalité sociale. L'institutionnalisation établit les comportements et les attentes, tandis que la légitimation fournit la justification et le soutien pour ces comportements et attentes. C'est à travers ces processus que la réalité sociale est construite et maintenue au quotidien.
Le processus d'institutionnalisation est un aspect essentiel de toute société. Il s'agit de formaliser et de codifier les comportements et les interactions entre les individus afin de créer un ordre social stable et prévisible. Cela peut se faire par le biais de lois, de règles, de normes sociales, de traditions, et d'autres formes de structures sociales. L'accoutumance (l'adoption de comportements par habitude ou routine) et la division des tâches (la spécialisation des rôles et des responsabilités) sont deux mécanismes clés de l'institutionnalisation. La transmission est également un aspect crucial de ce processus. Les valeurs, les normes et les comportements institutionnalisés sont transmis d'une génération à l'autre, assurant la continuité et la stabilité de l'ordre social. Le processus de légitimation, quant à lui, consiste à justifier et à valider ces comportements institutionnalisés. Les traditions, le langage, et les croyances partagées jouent un rôle clé dans ce processus, car ils fournissent la justification morale, sociale et culturelle des comportements institutionnalisés. Ces deux processus, l'institutionnalisation et la légitimation, sont intrinsèquement liés et travaillent ensemble pour créer et maintenir la réalité sociale. En d'autres termes, ils contribuent à construire le "monde social" tel que nous le connaissons.
Le processus de légitimation est crucial dans toute société. Il est lié au maintien de l'ordre social et de la stabilité en conférant une validité et une acceptabilité aux normes, aux règles, aux institutions et aux comportements établis. C'est une étape clé dans la consolidation et l'acceptation de la réalité sociale construite. Les symboles jouent un rôle majeur dans ce processus. Les symboles - qu'ils soient culturels, religieux, politiques ou autres - servent à communiquer des valeurs, des idéaux et des croyances qui renforcent la réalité sociale construite. Par exemple, dans le contexte du gouvernement et du pouvoir, les symboles tels que les drapeaux, les hymnes nationaux, les monuments, les emblèmes et les rituels officiels contribuent à légitimer l'autorité et à promouvoir une certaine vision de la société. Le processus de légitimation peut également être considéré comme un mécanisme de contrôle social. Il aide à établir et à maintenir les normes et les comportements attendus, et à poser des limites à ce qui est considéré comme acceptable dans une société donnée. Il peut également aider à prévenir ou à gérer les conflits en établissant un consensus autour de ce qui est considéré comme juste et correct.
Le processus de légitimation vise à assurer l'acceptation collective de la réalité sociale construite. Ce processus comprend des mécanismes par lesquels des normes, des valeurs, des croyances et des institutions sont validées et rendues crédibles aux yeux des membres de la société. Lorsque la légitimation est réussie, la réalité sociale construite est largement acceptée comme "naturelle" ou "inévitable", et non comme un produit de la construction sociale. Il est important de noter que la légitimation est un processus dynamique. Les réalités sociales construites peuvent être remises en question, modifiées ou même complètement démantelées à la suite de changements sociaux, culturels, économiques ou politiques. De nouvelles réalités sociales peuvent alors être construites et légitimées. En ce sens, la légitimation est une composante essentielle de la stabilité et du changement sociaux. Elle peut à la fois maintenir l'ordre social existant et faciliter son évolution.
Le constructivisme dans la théorie des relations internationales
Le constructivisme dans le domaine des relations internationales soutient que les normes, les idées, les identités et les interactions sont des éléments centraux dans la structuration du système international. Il ne perçoit pas les États et autres acteurs internationaux comme étant uniquement motivés par des considérations matérielles comme la sécurité militaire ou la richesse économique, mais aussi par des idées, des valeurs, des cultures et des normes sociales. Pour les constructivistes, le système international n'est pas simplement un champ de bataille pour le pouvoir et la richesse. C'est aussi un domaine de construction sociale, où les acteurs internationaux se façonnent mutuellement à travers leurs interactions. Par exemple, les normes internationales sur les droits de l'homme, l'environnement ou le commerce peuvent influencer le comportement des États et d'autres acteurs internationaux. En outre, les constructivistes soutiennent que les relations internationales sont en constante évolution. Les normes, les idées et les identités des acteurs internationaux peuvent changer avec le temps, et ces changements peuvent à leur tour remodeler le système international. Par exemple, l'émergence de normes internationales sur le changement climatique a contribué à transformer les priorités et les politiques de nombreux États et organisations internationales. Ainsi, le constructivisme offre une perspective dynamique et en constante évolution sur les relations internationales. Il met l'accent sur les processus de construction sociale et l'importance des idées, des valeurs et des normes dans la structuration du système international.
Dans un champ interactionniste, tout comme dans le domaine des relations internationales, les stratégies sont constamment en mouvement et en évolution en réponse aux changements dans le contexte social, politique et économique. Il est crucial de comprendre ces dynamiques pour interpréter correctement les comportements des acteurs et prédire les futurs mouvements ou changements stratégiques. Les stratégies peuvent changer en fonction de divers facteurs, y compris les changements dans les perceptions des intérêts nationaux, les évolutions du contexte international, les transformations internes des acteurs (par exemple, des changements de leadership ou de politique), et les interactions entre les acteurs eux-mêmes. Par exemple, un pays peut choisir de modifier sa stratégie en matière de relations internationales en réponse à un changement de leadership dans un autre pays, à un changement dans le climat politique international, ou à des développements internes tels que des changements économiques ou sociaux. De plus, l'interactionnisme symbolique, qui est une approche constructiviste, suggère que les stratégies sont influencées par les interactions entre les acteurs. Les acteurs interprètent et réagissent aux actions des autres, ce qui peut entraîner des changements dans leurs propres stratégies. Par conséquent, l'analyse des interactions entre les acteurs peut fournir des informations précieuses sur les dynamiques stratégiques dans les relations internationales.
L'approche constructiviste dans les relations internationales s'intéresse beaucoup aux acteurs et à leur interprétation des situations. Le constructivisme insiste sur le fait que les réalités sociales, y compris les structures internationales, sont construites à travers les interactions humaines et les croyances partagées. Voici comment ces niveaux se manifestent dans le contexte des relations internationales :
- Rôle des acteurs : Les acteurs dans les relations internationales ne sont pas seulement des États, mais aussi des organisations internationales, des ONG et même des individus. Leur interprétation des situations et leur comportement sont influencés par une variété de facteurs, y compris leurs croyances, leurs valeurs, leurs idéologies, ainsi que leurs intérêts matériels. En effet, les acteurs ont des identités qui influencent leurs intérêts et leurs actions. Par exemple, un pays qui se voit comme un leader mondial en matière de droits de l'homme agira différemment d'un pays qui ne partage pas cette identité.
- Construction des réalités sociales : Dans le constructivisme, les structures internationales sont considérées comme des constructions sociales. Cela signifie que les normes, les règles et les institutions qui forment l'ordre international sont le produit de l'interaction humaine. Elles ne sont pas fixes et peuvent être transformées par l'action humaine. Par exemple, les normes internationales sur les droits de l'homme ont évolué au fil du temps en raison des actions et des interactions des États, des organisations internationales et des acteurs de la société civile.
- Champ des interactions : Le constructivisme met l'accent sur le rôle des interactions dans la formation des structures internationales et des comportements des acteurs. Les acteurs interagissent les uns avec les autres dans divers contextes, tels que les négociations diplomatiques, les forums internationaux et même les conflits. Ces interactions influencent leur compréhension de la situation, leurs intérêts et leurs actions.
Le constructivisme offre un cadre précieux pour comprendre la dynamique complexe des relations internationales. Il met en évidence le rôle des idées, des normes et des interactions dans la formation de l'ordre international et le comportement des acteurs.
Le constructivisme offre une perspective alternative aux approches plus traditionnelles des relations internationales, comme le réalisme, le libéralisme et le fonctionnalisme. Ces approches ont tendance à se concentrer sur les structures matérielles et les intérêts étatiques comme principaux déterminants du comportement international. Cependant, le constructivisme met l'accent sur l'importance des idées, des normes et des identités dans la structuration de la politique internationale. Il suggère que les intérêts et les identités des États sont façonnés par leurs croyances et leurs interactions avec d'autres acteurs. Ainsi, le comportement international n'est pas simplement le produit de contraintes structurelles ou de calculs d'intérêts matériels, mais est également influencé par des facteurs sociaux et idéologiques. En outre, le constructivisme conteste l'idée que la politique internationale puisse être comprise en termes de systèmes rigides ou de modèles fonctionnalistes. Au lieu de cela, il voit le monde international comme étant en constante évolution, façonné par des processus dynamiques d'interaction et de construction sociale. En ce sens, le constructivisme offre une perspective plus nuancée et plus complexe de la politique internationale, qui prend en compte la diversité des acteurs, des idées et des processus qui façonnent le monde. Cette perspective est particulièrement utile pour comprendre les défis contemporains des relations internationales, tels que le multilatéralisme, les droits de l'homme, le changement climatique et la gouvernance mondiale.
Les théories constructivistes remettent en question l'idée qu'il existe des réalités objectives ou des structures fixes dans les relations internationales, comme le concept de l'anarchie. Elles soutiennent que ces concepts sont en fait des constructions sociales, façonnées par nos croyances, nos normes et nos interactions. L'anarchie, par exemple, est souvent présentée dans les théories réalistes comme une caractéristique fondamentale du système international, où il n'y a pas d'autorité centrale pour imposer des règles ou réguler le comportement des États. Cependant, les constructivistes remettent en question cette idée et suggèrent que l'anarchie elle-même est une construction sociale. Ce n'est pas une réalité objective, mais une perception ou une interprétation de la réalité qui est façonnée par nos croyances et nos interactions. En outre, les constructivistes soutiennent que même en l'absence d'une autorité centrale, il existe des normes, des règles et des institutions internationales qui influencent le comportement des États. Ces normes et institutions ne sont pas simplement le produit de calculs d'intérêts matériels, mais sont également façonnées par des processus de construction sociale. Ainsi, le constructivisme offre une perspective plus nuancée et dynamique sur les relations internationales, qui prend en compte la diversité des acteurs et des processus qui façonnent le monde. Il offre également des outils pour analyser et comprendre des phénomènes complexes tels que les conflits, la coopération, le changement social et la construction de l'ordre international.
Le constructivisme remet en question l'idée réaliste de l'anarchie comme état naturel du système international. Pour les constructivistes, l'anarchie n'est pas un état fixe ou présocial, mais une construction qui émerge des interactions entre les acteurs internationaux. En d'autres termes, l'anarchie n'est pas un donné, mais une réalité construite. Les États ne sont pas simplement plongés dans un environnement anarchique ; ils contribuent activement à créer et à maintenir cet état à travers leurs interactions, leurs normes et leurs croyances. Les relations entre les États ne sont pas simplement dictées par le désir de puissance ou la peur de l'insécurité, mais sont également façonnées par des facteurs sociaux, culturels et idéologiques. De plus, le constructivisme reconnaît que les États ne sont pas les seuls acteurs pertinents dans les relations internationales. D'autres acteurs, tels que les organisations internationales, les ONG, les mouvements sociaux et même les individus, peuvent aussi jouer un rôle important. Leur influence ne se limite pas à leur pouvoir matériel, mais peut aussi être déterminée par leur capacité à façonner les normes, les idées et les croyances qui sous-tendent le système international. Dans cette perspective, l'analyse des relations internationales ne peut pas se limiter à l'étude des rapports de force entre les États. Elle doit également prendre en compte les processus sociaux et culturels qui façonnent ces relations et les structures dans lesquelles elles s'insèrent.
Dans le champ des relations internationales, les théories constructivistes apparaissent : ils vont penser la réalité des structures et des conflits et aussi penser l’intersubjectivité c’est-à-dire que c’est le fait que nous sommes dans la représentation et comment certain pays peuvent se permettre de caractériser un autre au nom de l’interprétation de son propre développement.
Le constructivisme met l'accent sur l'importance des normes et des idées dans la structuration des relations internationales. La souveraineté des États, par exemple, est un principe central de l'ordre international, mais elle n'est pas un fait objectif et immuable. Elle est plutôt une construction sociale qui repose sur la reconnaissance mutuelle des États. Dans le cadre constructiviste, les normes internationales, qu'elles soient explicites (comme les traités et les accords internationaux) ou implicites (comme les normes de comportement non écrites), jouent un rôle clé dans la détermination du comportement des États. Ces normes ne sont pas simplement imposées de l'extérieur, mais sont intériorisées par les États, qui les adoptent comme une partie de leur identité et de leurs intérêts. De plus, le constructivisme reconnaît que ces normes peuvent changer au fil du temps en fonction des interactions entre les acteurs internationaux. Si une norme n'est pas respectée ou acceptée par un État, cela peut déclencher des réactions et des négociations qui peuvent finalement conduire à une modification de la norme. En bref, le constructivisme offre une perspective dynamique et évolutive sur les relations internationales, mettant en évidence l'importance des processus sociaux et des interactions dans la formation et la transformation de l'ordre international.
Le constructivisme dans les relations internationales met un accent particulier sur l'importance des identités et des intérêts des acteurs, qui sont vus comme étant construits par l'interaction sociale plutôt que prédéterminés par la nature humaine ou les structures économiques, comme le suggèrent d'autres théories. Cela implique que les États (et d'autres acteurs) sont influencés par les normes et les idées qui prévalent dans la société internationale, et que leurs identités et intérêts peuvent évoluer avec le temps en fonction de ces influences. Par exemple, un État peut adopter certaines normes en matière de droits de l'homme ou de politique environnementale parce qu'elles sont largement acceptées dans la communauté internationale, et non parce qu'elles sont directement dans son intérêt économique ou sécuritaire. De plus, le constructivisme reconnaît que les acteurs ont la capacité d'agir de manière créative et stratégique pour influencer les normes et les idées internationales. Cela peut se faire par le biais de la diplomatie, de la persuasion, de la rhétorique et d'autres formes de communication sociale. Par conséquent, les relations internationales sont vues comme un processus dynamique d'interaction et de négociation, plutôt que comme un jeu à somme nulle déterminé par des intérêts nationaux fixes et inaltérables.
Appendici
- Vers un « constructivisme tempéré ». Le constructivisme et les études européennes, SiencePo - Centre d'études européennes